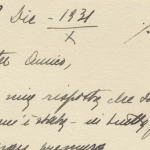Torino 2 dicembre 1931
Gent imo Signor Barone,
La preparazione dell’offensiva sugli Altipiani cui, nella
primavera, si era atteso, con più o meno buona volontà, e la qua=
le offensiva era stata richiesta dal Comando interalleato
per distrarre forze dal fronte francese, venne senz’altro sospe=
sa non appena si ebbe sicura notizia della preparazione della
grande offensiva austriaca, a fronteggiare la quale si ri=
tenne oppportuno d’adottare schieramento e criteri d’impie=
go delle forze decisamente difensivi, perché i rapporti
fra le forze contrapposte, le condizioni del terreno e
della sua sistemazione che avrebbero reso arduo ed assai
rischiosa una grande controffensiva, tipo quella che avrebbe
voluto sferrare Capello[1] a Caporetto[2], ed anche la considerazione
del tempo necessario per trasformare in offensivo uno schiera_
mento, specialmente ne’ riguardi delle grosse artiglierie,
difensivo, non consigliavano di pensare, e quindi di
predisporre grandi controffensive di carattere strategica;
ciò che, naturalmente, non escludeva che si dovesse dare
carattere molto attivo e movimentato alla nostra difesa, con
controffensive parziali di carattere tattico.
Con ciò non si esclude che, oltre a queste ultime controf=
fensive tattiche, anima di ogni buona difesa, si tenesse
presente altresì la possibilità d’essere chiamati a sferrare
controffensive di stile, ma questa, nel caso, si sarebbero
sviluppate piuttosto sulla difesa del Piave, sul terreno
ora occupato e che, in primo tempo, fossimo stati costretti ad abbandonare
che con grandi controffese al di là del Piave, oppure
sui monti per spingerle fin verso la Valsugana o la Conca
Feltrina.
Già il gen le Cadorna[3] aveva pensato ad una eventuale
grande controffensiva da sferrarsi da nord-ovest contro
l’avversario che, passato il Piave fra il ponte della
Priula e quello di Piave, si fosse impegnato contro
le difese del Campo trincerato di Treviso; ed in tale
caso, si proponeva un grande concentramento di ar=
tiglierie in regione Veneziana (ovest di Spresiano)
Il critico dell’operato del nostro Comando Supremo[4]
avrebbe voluto che, in seguito al fallimento dell’attac=
co di Conrad[5] sugli Altipiani e sul Grappa, fino
dalla sera del 15 si fosse iniziato ivi una grande
nostra controffensiva, “alla quale gli Austriaci
“non avrebbe potuto resistere, quindi, a parer suo,
“l’Impero Austro-Ungarico sarebbe stato buttato
“a terra.”
Ora la sera del 15 il nostro Comando Supremo sapeva
che, in complesso, sugli Altopiani e sul Grappa
si era riuscito a conservare le nostre posizioni,
pure avendo dovuto cedere alcune, e fra quelle
di capitale importanza, in un primo momento,
ma sapeva altresì che l’attacco del Piave, favo=
rito dalla nebbia e dalle cortine di fumo prodotte
dagli Austriaci, aveva loro dato, in un primo tempo,
sensibili vantaggi al saliente del Montello ed alle
teste di ponte di Fagarè e San Donà di Piave; in
seguito, la linea si era irrigidita per cui maggiori
perdite di terreno, quel giorno, non avemmo, però
quei primissimi vantaggi restarono al nemico.
Tuttavia, anche ammesso che il nostro C. S.
fosse riuscito a rendersi conto di tutta la gran=
dezza del successo, specialmente né riguardi
morali, che avevamo conseguito contro Conrad,
crede il suo critico che sarebbe stato saggio di
decidere d’impegnare senz’altro le riserve nella
controffensiva sui monti, mentre tanto gra=
ve appariva la minaccia nel piano?
Eppoi, non subito si sarebbe potuto sferrare
la grande controffensiva sui monti, perché pri=
ma occorreva passare dallo schieramento di=
fensivo a quello offensivo di oltre un migliaio
di bocche da fuoco, ciò che avrebbe richiesto
alcuni giorni: E se nel frattempo, quell’offensiva
nemica che si spinse fino a Meolo perché il
tempo arginata dalle nostre difese, quando
questo difetto, si fosse spinta fino a Mestre
ed oltre?
Io non escludo che la controffensiva propugnata
dal critico[6], favorita dalla fortuna, potesse con=
durre al successo, però io penso non esser leci=
to di giocare su una carta l’esistenza e l’ono_
re d’una nazione pel miraggio d’una ma_
novra geniale di cui parlerà poi la Storia. –
Oggi magari che non conviene dimenticare che
trattavasi d’un esercito non preparato alla ma=
novra e sul quale, non ostante la magnifica re_
sistenza sostenuta nel novembre – dicembre 1917,
sul Piave e sul Grappa, ancora pesava l’ombra
di Caporetto …. Rimaniamo nel campo della realtà
non della poesia, giudicando delle decisioni de’ capi, a far benone(?)
Come vede, caro Sig. Barone[7], Le ho manifesta=
to senza reticenze, com’è mio costume, il mio pen_
siero.
Le sono molto grato per la fiducia che mi di=
mostra e La prego di gradire i sensi dell’alta mia
stima e sincera devozione
L. Segato[8]
timbro POSTE ITALIANE Cent 50[8]
annullo TORINO 17 -18 3 XII 31 X FERROVIA[9]
Signor Barone Comm. e Alberto Lumbroso
12 – A Via Marcello Durazzo
GENOVA
annullo GENOVA CENTRO 1 -2 4 XII 31 X
Note
Una premessa sul memoriale:
Quello che nello scritto viene nominato “critico” è il Generale Edoardo Monti. I memoriali dei vari Generali redatti su sollecitazione del Barone Lumbroso in merito alla questione sollevata dal Generale Monti, relativa alla mancata controffensiva italiana in grande stile la sera del 15 giugno 1918 contro il gruppo Conrad, non rivelano mai il nome del Generale al quale rispondono. Il nome appare nel biglietto privato che il Generale Vannutelli acclude al suo memoriale.
[1] Luigi Attilio Capello. Nato a Intra (Novara) il 14 apr. 1859 da Enrico e da Ernesta Volpi, venne avviato alla carriera militare dal padre, funzionario dei telegrafi, di medie possibilità economiche. Allievo dell’Accademia militare nel 1875, sottotenente di fanteria nel 1878, frequentò nel 1884-86 la scuola di guerra conseguendo il brevetto di ufficiale di Stato Maggiore. Rivelava contemporaneamente una vastità di interessi poco comune negli ambienti militari del tempo, tanto che nel 1893, di stanza a Napoli come maggiore, collaborò al Corriere di Napoli insieme con F. S. Nitti e G. D’Annunzio. I suoi articoli di critica militare, che sostenevano la necessità dell’offensiva e dello spirito di iniziativa a tutti i livelli e polemizzavano contro lo spirito di casta dell’esercito e il criterio burocratico dell’avanzamento per anzianità, gli valsero un trasferimento a Cuneo per punizione. La sua carriera non ne fu compromessa e nel 1898 conseguì la promozione a colonnello e il comando del 50º reggimento di fanteria. Verosimilmente in questi anni (la data esatta non è nota) entrò nella massoneria, raggiungendovi posizioni di responsabilità e stringendo rapporti con personalità politiche; è attestata la sua simpatia per il socialismo riformista e in particolare verso Bissolati, che lo ricambiava di pari stima.
Maggiore generale e comandante della brigata Abruzzi nel 1910, il C. partecipò alla campagna di Libia alla testa di una brigata di fanteria dislocata a Derna. Nei diversi combattimenti in cui fu impegnato e nella vita di guarnigione diede prova di energia e decisione, distinguendosi per spirito aggressivo e severità e attirandosi così alcuni attacchi di stampa.
Come risulta dalle sue carte, il C. criticava fortemente la prudenza degli alti comandi, che prescrivevano un contegno passivo alle truppe italiane malgrado la loro schiacciante superiorità in uomini mezzi e organizzazione. Questo guerreggiare difensivo, scriveva, non poteva che “atrofizzare ogni sentimento di iniziativa e di offensiva” e rendere necessario “molto tempo a pace conclusa per togliere tante idee storte e ritornare ad una educazione consona all’unico sistema di guerra che possa dare la vittoria”. In queste parole e in tutto il suo comportamento emergeva già la sua decisa convinzione che solo l’offensiva potesse risolvere le guerre.
Allo scoppio del conflitto mondiale il C. comandava la 25a divisione di stanza a Cagliari. Sono interessanti alcune sue circolari del settembre-ottobre 1914 che rivelano una preoccupazione assai rara nei comandi italiani per la preparazione morale dei soldati e l’organizzazione di una propaganda capillare nei reparti. Con l’intervento italiano la 25a divisione fu assegnata alla 3a armata e prese parte alle prime battaglie sul Carso, in cui si distinse specialmente la sua brigata Sassari; ma già il 28 sett. 1915 il C., promosso tenente generale, era destinato al comando del VI corpo d’armata che fronteggiava la testa di ponte austro-ungarica di Gorizia.
Contro i pilastri di questa testa di ponte, le alture del Sabotino e del Podgora, il VI corpo sferrò ripetuti sanguinosissimi attacchi nel corso della terza e quarta battaglia dell’Isonzo (ottobre-novembre 1915), senza riuscire a intaccare la linea di resistenza nemica; i non grandi vantaggi territoriali andarono in parte perduti nel corso di una controffensiva austro-ungarica nella zona di Oslavia nel gennaio 1916. Il prestigio del C. non fu scosso da questi insuccessi, perché su tutto il fronte italiano la necessità politica di una condotta offensiva della guerra anche in assenza di adeguati mezzi bellici aveva portato al sacrificio delle truppe senza un corrispettivo di guadagni territoriali e di vittorie evidenti.
La pausa invernale, l’affluenza di reparti di nuova costituzione e lo sviluppo dell’artiglieria italiana (specie dei medi calibri e delle bombarde) permisero al C. di impostare su nuove basi la conquista della testa di ponte di Gorizia. Il gen. Montuori, comandante della 4a divisione, e il col. Badoglio curarono un’attenta preparazione del terreno sul Sabotino, tanto che quando il 6 ag. 1916 fu sferrata l’offensiva (ritardata fino ad allora per la Strafexpedition austro-ungarica nel Trentino) il terribile caposaldo fu conquistato con un attacco travolgente quasi senza perdite. Lo sfruttamento della rottura fu però ostacolato dalla scarsezza delle riserve che il comando della 3ª armata aveva concesso; tuttavia le truppe del VI corpo giunsero l’8 agosto all’Isonzo, lo passarono il giorno successivo e occuparono Gorizia spingendosi sino alle alture a est della città, dove però il loro impeto si infranse contro le nuove posizioni nemiche.
Il mancato sfruttamento strategico della rottura del Sabotino nulla toglieva alla risonanza della conquista di Gorizia (il primo netto successo della guerra italiana) e ai meriti del C., la cui popolarità crebbe rapidamente sino a metterlo in urto con Cadorna. Gli avversari del generalissimo italiano vedevano infatti nel C. un possibile successore, capace di imprimere un nuovo dinamismo, offensivo alla guerra italiana e di stabilire rapporti più intensi e proficui tra paese ed esercito. Oltre alle sue indiscusse qualità militari giocavano a favore del C. la sua familiarità con gli ambienti politici interventisti, i legami stretti con molti giornalisti e l’ascendente su giovani ufficiali di complemento che brillavano per ingegno e cultura (da Alessandro Casati ad Ardengo Soffici). Non è dato sapere fino, a che punto il C. incoraggiasse o subisse le interessate premure degli avversari di Cadorna; certo è che il comando del VI corpo era diventato un centro di contatti politici, intellettuali e giornalistici. Cadorna se ne preoccupò sino a decidere di colpire il potenziale rivale; e poiché non poteva silurarlo all’indomani della vittoria di Gorizia, il 12 sett. 1916 lo rimosse dal comando del VI corpo passandolo a quello di assai minor rilievo del XIII corpo d’armata sugli Altopiani. Il carattere punitivo del trasferimento era sottolineato dal fatto che il C. veniva a trovarsi agli ordini del gen. Mambretti, fino a quattro mesi prima suo sottoposto.
Il provvedimento si inseriva in una più ampia offensiva di Cadorna contro le ingerenze del governo nella condotta delle operazioni; negli stessi giorni infatti il generalissimo vietò l’accesso della zona di guerra ai ministri e particolarmente a Bissolati, che pure era il ministro incaricato dei rapporti con il Comando Supremo. Il dissidio fu composto nei mesi seguenti con il rafforzamento della posizione di Cadorna, la sua rappacificazione con Bissolati e il ristabilimento di rapporti corretti tra governo e Comando Supremo.
Se ne avvantaggiò il C., che il 13 dic. 1916 passò a comandare il V corpo della 1a armata e il 28 dicembre ricevette la nomina a grand’ufficiale dell’Ordine militare di Savoia per la parte avuta nella vittoria di Gorizia. Nel marzo 1917 infine Cadorna, che nonostante le differenze di orientamento politico e di personalità riconosceva nel C. il migliore dei suoi generali, lo richiamò sul fronte dell’Isonzo affidandogli il comando della zona Gorizia di nuova costituzione, che di fatto, anche se non ancora di nome, aveva il ruolo di un’armata (10 marzo 1917).
Il piano di Cadorna per la decima battaglia dell’Isonzo, iniziata il 12 maggio 1917, prevedeva, in un primo tempo, la conquista delle alture del Kuk, Vodice e Monte Santo ad opera delle truppe della zona Gorizia e poi lo spostamento del centro di gravità dell’offensiva più a sud, contro l’Hermada, ad opera della 3ªarmata. Nonostante la superiorità di forze e l’accurata preparazione del C. e del suo capo di Stato Maggiore Badoglio (che durante la battaglia assunse il comando del II corpo d’armata) l’attacco iniziale portò solo alla conquista del Kuk; il C. ottenne però l’autorizzazione a protrarre gli sforzi e, a prezzo di perdite sanguinosissime, riuscì a occupare anche il Vodice, mentre il Monte Santo resistette ad ogni assalto. II prolungamento dell’offensiva a nord provocò però l’insuccesso degli attacchi all’Hermada; la battaglia, sospesa il 28 maggio, portava ancora una volta solo a successi tattici non risolutivi pagati a duro prezzo. Ne usciva rafforzata la posizione del C. che il 1º giugno passò a comandare la 2a armata, in cui era assorbita la zona Gorizia.
Anche per l’undicesima battaglia dell’Isonzo (nota anche come battaglia della Bainsizza, 18 ag.-15 sett. 1917) Cadorna aveva previsto un duplice attacco, a nord con la 2a armata verso l’altopiano della Bainsizza, a sud con la 3a armata sul Carso. Il C. chiese però di estendere l’offensiva anche alla testa di ponte austroungarica di Tolmino, con azione fino al Monte Nero; e Cadorna acconsentì perché fiducioso nell’eccezionale concentramento di forze: 51 divisioni con 5.200 pezzi d’artiglieria. L’offensiva della 2ª armata ottenne un rapido successo sulla Bainsizza, ma fallì verso Tolmino, malgrado il C. concentrasse in questo settore le sue riserve. La conquista dell’altopiano della Bainsizza costituiva comunque un grosso successo tattico, specie in confronto al fallimento della contemporanea offensiva sul Carso. Sperando di ampliare la vittoria, il C. chiese allora ed ottenne di prolungare la battaglia con una serie di sanguinosissimi attacchi al San Gabriele, chiave delle posizioni nemiche ad est di Gorizia; ne conseguì un doloroso logoramento di truppe già provate, che non riuscirono a espugnare le munite linee nemiche. I successi del Kuk, del Vodice e della Bainsizza, gli unici conseguiti dall’esercito italiano nel 1917, consolidarono la reputazione di comandante del C., che il 6 ottobre fu fatto cavaliere di gran croce dell’Ordine militare di Savoia.
Suo merito precipuo era l’accurata preparazione iniziale, basata su possenti ed elastici concentramenti d’artiglieria, che in entrambe le battaglie garantì il rapido successo di una parte dei primi attacchi. Altra caratteristica era un’elevatissima volontà offensiva che, trasmessa a tutti i comandi dipendenti, valeva ad assicurare molta decisione nei reiterati assalti, ma portava anche a prolungare la battaglia oltre i limiti della convenienza. Comandante duro ed energico verso i suoi ufficiali, ma capace di suscitare entusiasmo e dedizione in quanti lo avvicinavano, il C. non trascurava l’addestramento delle truppe e la loro preparazione morale, ma le sottoponeva senza esitazione a sforzi sanguinosissimi, che non potevano non avere gravi conseguenze. Si trattava di una situazione comune a tutto l’esercito, più sentita nella 2ª armata solo perché su di essa era ricaduto il peso maggiore delle battaglie del 1917; e non ne fu danneggiata la popolarità del C., che proprio allora raggiungeva il culmine. Il comando della 2ª armata divenne un punto d’incontro di uomini politici e di intellettuali interventisti, quasi in contrapposizione al grigio e ufficiale Comando Supremo.
I rapporti tra Cadorna e il C. tuttavia si mantennero sufficientemente buoni: i successi dell’estate avevano rafforzato anche la posizione del generalissimo, che non temeva più di essere sostituito e poteva quindi accettare la popolarità e i legami politici del comandante della 2ªarmata. E questi a sua volta pareva soddisfatto di essere diventato incontestabilmente il numero due dell’esercito, anche se lasciava correre la voce che in ogni offensiva fosse stato il Comando Supremo a fermarlo limitandogli i rincalzi e le munizioni d’artiglieria. Tra i due uomini c’erano rapporti di stima, non amicizia né possibilità di comprensione; e il risultato era che Cadorna teneva a lasciare anche troppa libertà d’azione al suo dinamico subordinato, già portato per suo conto ad agire di propria iniziativa.
Il 18 sett. 1917 Cadorna avvertì i comandanti della 2ª e della 3ª armata di aver rinunciato alla progettata offensiva autunnale in vista di un probabile serio attacco nemico e di aver deciso “di concentrare ogni attività nelle predisposizioni per la difesa ad oltranza”. Si limitò però a queste direttive di massima, sottovalutando le dimensioni e la pericolosità della controffensiva austro-tedesca, e non si preoccupò di impostare una battaglia difensiva unitaria né di crearsi adeguate riserve. Il C. fu quindi libero di preparare non una difensiva, ma una controffensiva in grande stile: egli giustamente si attendeva che l’attacco nemico sboccasse dalla testa di ponte di Tolmino, per puntare su Cividale; e si proponeva di stroncarlo soprattutto con un contrattacco che partendo dalla Bainsizza tagliasse fuori Tolmino e rovesciasse l’intera ala settentrionale nemica. Il deficiente collegamento tra il Comando Supremo e il comando della 2ª armata, aggravato dalle condizioni di salute del C. (costretto a letto dalla nefrite, dal 9 al 23 ottobre egli cedette formalmente il comando dell’armata al gen. Montuori, pur continuando ad esercitarlo di fatto), fece sì che questo piano ambizioso fosse portato avanti in contrasto con le direttive di Cadorna (peraltro informato di tutto) e in assenza dei mezzi necessari. Solo il 19 ottobre, dopo aver finalmente ottenuto un colloquio con Cadorna, il C. rinunciava ai propositi di controffensiva ed emanava tardive disposizioni per la battaglia difensiva, senza però poter modificare uno schieramento troppo proiettato in avanti. La deficiente impostazione strategica di Cadorna veniva così aggravata dalla divergenza col C., troppo tardi affrontata, e dall’iniziativa dei comandanti di corpo della 2ªarmata (e in particolare di Badoglio, il cui XXVII corpo fronteggiava la testa di ponte di Tolmino), tutti orientati alla preparazione di contrattacchi più che alla difesa delle loro linee da un nemico di cui si sottovalutava la capacità di manovra.
Il 23 ottobre, nell’imminenza dell’offensiva austro-tedesca, il C. riassunse anche formalmente il comando, della 2ªarmata, benché tutt’altro che ristabilito. L’indomani mattina si scatenò l’attacco nemico che, contenuto sul fronte del IV corpo, sfondò le posizioni del XXVII corpo e raggiunse rapidamente Caporetto, prendendo a rovescio l’estrema sinistra della 2ª armata. La profondità e la celerità della penetrazione e l’abilità manovriera dei reparti tedeschi sconvolgevano tutte le predisposizioni italiane impedendo un’efficace azione di comando; i contrattacchi ordinati si rivelarono superati dagli avvenimenti, le riserve frettolosamente avviate per tamponare la falla furono sorprese ancora in marcia dall’avanzata nemica. Il mattino del 25 ottobre, considerando l’ampiezza dello sfondamento e l’insufficiente resistenza di molti reparti, il C. propose a Cadorna, nel corso di un colloquio a Udine, di ordinare la ritirata generale sul Tagliamento per permettere all’esercito di riprendere fiato e fiducia; diramò anche le direttive per la ritirata della 2ª armata (ritardata di 36 ore dal Cadorna) e poi lasciò il comando per il precipitare delle sue condizioni fisiche. Si riprometteva di tornare al suo posto dopo quattro giorni di riposo, ma le pressioni dei medici e le preoccupazioni di Cadorna per la continuità dell’azione di comando lo costrinsero ad assistere agli sviluppi del disastro da un letto d’ospedale, mentre il comando della 2ªarmata passava al gen. Montuori.
Il 26 novembre del 1917 il C., che si era rimesso in salute, venne destinato al comando della nuova 5ª armata, in corso di costituzione nelle retrovie con le unità più provate nella rotta e gli sbandati che rientravano ai reparti. Affrontò il delicato incarico (che dimostrava come egli godesse della fiducia del nuovo Comando Supremo di Diaz) con la consueta attività, organizzando una moderna rete di propaganda e preoccupandosi di assicurare alle truppe buone condizioni di vita. L’8 febbraio tuttavia fu privato del comando e posto a disposizione della Commissione d’inchiesta nominata dal governo Orlando per far luce sulle cause della rotta di Caporetto; uguale sorte ebbero Cadorna e Porro, mentre Badoglio fu salvato dall’intervento di Diaz che non volle privarsi del suo più stretto collaboratore. Contro la tendenza del governo e della Commissione, che così si preannunciava, di addebitare le maggiori responsabilità a Cadorna e al C., quest’ultimo si batté con energia, stendendo tra marzo e maggio 1918 una documentata memoria difensiva, La 2ª armata e gli avvenimenti dell’ottobre 1917 (pubblicata nel 1967 da R. De Felice con il titolo Caporetto perché?) e stringendo o rinnovando contatti con esponenti interventisti (ricordiamo tra gli altri Bissolati, Chiesa, Mussolini, Papini, Prezzolini, il gen. Marazzi e i fedelissimi A. Soffici e A. Casati). Doveva però lottare contro il crescente isolamento, che raggiunse il culmine nell’estate 1919 con la pubblicazione della relazione della Commissione d’inchiesta.
Volendo salvare le responsabilità delle forze di governo senza compromettere l’esercito né discutere la condotta della guerra, la Commissione rigettava la colpa di Caporetto su alcuni generali, e in primo luogo su Cadorna e il C., accusandoli di aver logorato le truppe con sforzi eccessivi e di aver male impostato e condotto la battaglia difensiva. Queste accuse non erano infondate, ma acquistavano un ingiusto risalto dalla copertura di molte altre responsabilità politiche e militari e dalla mancanza di una valutazione complessiva delle condizioni in cui la guerra era stata decisa e portata avanti. Al governo Nitti premeva però di chiudere le polemiche col minor danno possibile; perciò il 3 sett. 1919 fu annunciato il collocamento a riposo di Cadorna e del C. (e di altri generali di minor rilievo), nominativamente indicati come i veri responsabili del disastro.
Contro questa condanna morale il C. condusse una lunga e appassionata battaglia. Subito dopo il collocamento a riposo aveva indirizzato al governo un memoriale difensivo, chiedendo un giudizio in contraddittorio; faceva poi seguire una petizione al Senato per ottenere una nuova inchiesta. Nel 1920 si rivolse all’opinione pubblica con due libri (editi dalla casa Treves di Milano): Per la verità, specialmente diretto contro la relazione della Commissione d’inchiesta, e Note di guerra, in cui era ripresa criticamente tutta la sua esperienza bellica, con l’appoggio di una ricca documentazione, per la prima volta resa nota al pubblico con tanta larghezza. Contemporaneamente il C. prendeva parte attiva al dibattito sulla riorganizzazione dell’esercito, scrivendo nell’inverno 1919-20 sul Giornale del popolo otto articoli (poi riuniti in volume all’inizio del 1920 nelle edizioni de La Voce, col titolo L’ordinamento dell’esercito e la prefazione di A. Soffici) aspramente polemici verso le gerarchie militari.
Il C. criticava duramente lo Stato Maggiore e l’intera “classe militare”, accusata di conservatorismo e spirito di casta; chiedeva addirittura “un regime di liquidazione, sia pure graduale” per l’esercito permanente tradizionale e riponeva ogni fiducia nell’avvento della nazione armata e nella valorizzazione di tutte le forze vive del paese, a cominciare dagli ufficiali di complemento. Queste posizioni furono coerentemente sviluppate negli anni seguenti con un’attiva battaglia a favore di tutti i tentativi di rinnovare le istituzioni militari, portata avanti su vari giornali, tra cui ricordiamo Il Resto del Carlino e nel 1922 Il Secolo di Milano.
L’atteggiamento critico verso gli ambienti militari e politici dominanti e la profonda fede nella necessità di un rinnovamento della vita italiana, di cui fossero protagonisti gli ex combattenti, spinsero il C. ad aderire al fascismo già nel 1920, anche se alcuni fogli fascisti non gli avevano risparmiato attacchi per la rotta di Caporetto. Non ebbe però responsabilità o cariche nel partito, anche se nel 1922 Mussolini lo incaricò di un sondaggio presso Nitti in vista della costituzione di un governo di unione nazionale. La sua adesione al fascismo culminò con la partecipazione in camicia nera alla grande parata del 31 ott. 1922 per festeggiare il successo della marcia su Roma. Nel febbraio 1923 il Gran Consiglio del partito fascista sancì l’incompatibilità tra l’iscrizione al partito e quella alla massoneria; la decisione ebbe applicazione graduale, ma il C., che era sempre attivo e molto influente nella massoneria di palazzo Giustiniani, non esitò a restituire subito la tessera fascista. Non passò però all’opposizione, tanto che nell’inverno 1923-24 svolse una missione informativa riservata in Germania per conto di Mussolini.
Nel frattempo giungeva al termine l’opera di una Commissione nominata dal ministro della Guerra nell’aprile 1922 su istanza del Senato, cui il C. aveva richiesto il riesame delle sue responsabilità nella sconfitta di Caporetto. La nuova Commissione, pur accettando il quadro d’insieme fornito dalla precedente Commissione d’inchiesta nel 1919, alleggerì di molto gli addebiti mossi al C., facendo salva la sua lealtà di comandante e i suoi sentimenti di umanità e interesse per i soldati e sostenendo l’impossibilità di attribuire la responsabilità di un così grave disastro soltanto ad alcuni uomini. Queste nuove conclusioni non vennero però rese pubbliche, perché il governo fascista (secondo quanto testimonia la figlia del generale, Laura Borlenghi Capello) condizionò la riabilitazione del C. alla sua rottura con la massoneria e ad una sua pubblica dichiarazione di adesione al fascismo. Il C. preferì rifiutare nettamente, preferendo l’isolamento (nel novembre del 1924 anche Cadorna fu promosso maresciallo da Mussolini) al rinnegamento dei suoi principi; e le conclusioni della seconda Commissione d’inchiesta furono pubblicate solo nel 1946 dalla figlia Laura.
Il delitto Matteotti, lo strangolamento delle libertà politiche e l’inasprirsi dell’offensiva fascista contro la massoneria portarono gradualmente il C. ad una opposizione sempre più ferma. Anche in questo rifiutò mezzi termini e nei primi mesi del 1925 si adoperò insieme con l’esponente socialdemocratico Tito Zaniboni per la creazione di una rete insurrezionale antifascista, denominata “Pace e libertà” e inizialmente sostenuta dalla massoneria. Si convinse però presto della mancanza di basi dell’impresa e si trasse in disparte. Invece Zaniboni, incoraggiato da agenti provocatori della polizia, si diede a organizzare un attentato a Mussolini. Fu arrestato il 4 nov. 1925, prima di aver potuto dare esecuzione ai suoi propositi; il giorno seguente pure il C. fu arrestato e accusato di complicità nella preparazione dell’attentato, senza che nulla di concreto potesse essere provato a suo carico. Il processo, celebrato nell’aprile 1927 dinanzi al Tribunale speciale e dominato dalle esigenze propagandistiche del regime, si concluse con la condanna del C. a trent’anni di reclusione e la sua radiazione dai ruoli dell’esercito. Già prima del processo, la propaganda fascista non aveva esitato a farlo oggetto di infamanti accuse vecchie e nuove, che non potevano non lasciare traccia nella produzione pubblicistica e storiografica sulla guerra mondiale.
Dopo una serie di penosi trasferimenti in varie carceri comuni, in seguito al peggioramento delle condizioni di salute alla fine del 1928 il C. fu destinato a una clinica di Formia, dove trascorse anni relativamente sereni nonostante la stretta vigilanza. Nel 1935 fu trasferito a Roma e all’inizio del 1936 rimesso in libertà con un provvedimento di fatto, benché la condanna continuasse ad essere formalmente in vigore. A suo favore sembra si adoperassero alte personalità militari, Cadorna e poi Badoglio, con molta discrezione però. Gli ultimi anni furono amareggiati dall’impossibilità di riavere la divisa ed i gradi di un tempo.
Il C. morì a Roma il 25 giugno 1941.
[2] Battaglia di Caporetto. Nome con cui si indica comunemente la dodicesima battaglia dell’Isonzo (24 ottobre 1917), durante la Prima guerra mondiale. Le divisioni austro-tedesche inflissero presso Caporetto, centro dell’odierna Slovenia, una pesantissima sconfitta alle truppe italiane, guidate dal generale Cadorna, le quali furono costrette a ritirarsi, attestandosi poi sul Piave (9 nov. 1917). Centinaia di migliaia di prigionieri caddero in mano al nemico, insieme a migliaia di cannoni e a grandi depositi di materiali da guerra e alimentari. L’8 nov. Cadorna fu esonerato e sostituito dal generale A. Diaz. La rotta di Caporetto fu determinata dalla mancanza di idee chiare sul piano strategico, da un’insufficiente visione particolare e d’insieme delle operazioni condotte dai tedeschi in altri teatri di guerra, dall’omissione di un esame approfondito delle proprie possibilità. La crisi segnò però una stretta decisiva nella guerra italo-austriaca, ponendo fine a un determinato criterio di condotta bellica in favore di uno nuovo, più avveduto e di più larga ispirazione. La rotta subita dalle truppe italiane provocò un vero e proprio trauma nell’immaginario collettivo e nella memoria storica del Paese. Ne seguì inoltre un’inchiesta, volta a individuare le responsabilità della sconfitta.(fonte)
[3] Luigi Cadorna. Nato a Pallanza il 4 sett. 1850, unico figlio maschio del generale Raffaele e di Clementina Zoppi, divenne allievo a dieci anni del Collegio militare di Milano, a quindici dell’Accademia militare di Torino; ne uscì nel 1868 primo classificato e sottotenente nel corpo di Stato Maggiore, e passò subito alla Scuola di guerra, dove rimase fino alla promozione a tenente nel 1870. Prestò servizio in un reggimento di artiglieria da campagna, poi al comando della divisione di Firenze, tenuto allora dal padre; capitano nel 1875, fu trasferito a Roma al comando del corpo di Stato Maggiore, dove fu tra i compilatori di varie monografie sul territorio di confine austriaco, che percorse a piedi. Maggiore nel 1883, fu per tre anni comandante di battaglione nel 62º reggimento di fanteria in Alba, poi fu al comando del corpo d’armata di Verona, agli ordini del generale Pianell, che molto lo stimava e lo volle ancora presso di sé come capo di Stato Maggiore della divisione di Verona. Colonnello nel 1892, il C. comandò per quattro anni il 10º reggimento bersaglieri (a Cremona e poi a Napoli), che egli definì il suo più bel comando fino alla guerra; fu poi capo di Stato Maggiore del corpo d’armata di Firenze, dove prestò servizio sotto Baldissera, il più rinomato dei generali italiani.
In più edizioni, a partire dal 1898 (ricordiamo quella definitiva del 1907, stampata a Napoli), diede alle stampe un libretto sulla tattica e l’istruzione della fanteria, intitolato appunto Istruzione tattica, che nel suo nucleo centrale risaliva a un articolo già pubblicato sulla Rivista militare ital., XXXIII (1888), pp. 5-22. In queste pagine osservava che un movimento offensivo si sarebbe sempre risolto in un attacco frontale, reso costosissimo dalle moderne armi se non ben preparato e condotto; riteneva però che il coordinamento delle varie armi, lo sfruttamento del terreno da parte delle catene di tiratori avanzanti e una fredda determinazione del comandante avrebbero permesso di effettuare con successo anche un attacco frontale. Erano però necessari comandanti autorevoli, quadri affiatati, truppe disciplinate: e appunto all’istruzione dei reparti era dedicata l’ultima parte, in cui si raccomandavano esercitazioni di quadri a partiti contrapposti sul terreno e sulla carta. Il libretto fu assai favorevolmente accolto da esperti ufficiali, fra cui il Baldissera, che ebbe parole di elogio per l’autore. Nel 1902questi pubblicava sulla Rivista militare ital. (XLVII, pp. 1783-1835, 1931-1970, 2131-2181)uno studio Da Weissemburg a Sedan nel 1870, in cui veniva discussa la condotta tattica dei reparti prussiani nella guerra con la Francia.
Maggiore generale nel 1898, il C. comandò per sette anni la brigata Pistoia ad Alessandria e poi all’Aquila; tenente generale nel 1905, ebbe il comando della divisione di Ancona (1905-07) e di quella di Napoli (1907-09).
Nel 1906-08 si poneva il problema di dare un successore al capo di Stato Maggiore dell’esercito, gen. Saletta, ormai anziano, e il nome del C. era fatto da più parti, tra gli altri dal gen. Baldissera che lo propose per tre volte al re che lo aveva chiamato a consiglio. Giocava contro di lui la sua fama di energia senza compromessi e perciò l’8 marzo 1908 il gen. U. Brusati, primo aiutante di campo generale del re, gli scriveva chiedendogli di smentire le voci che gli attribuivano l’intenzione di non accettare controlli di sorta nell’esercizio del comando. Il 9 marzo il C. gli rispondeva di avere acquisito dal padre la convinzione che l’unità di comando fosse assolutamente necessaria alla vittoria; pertanto, poiché il capo di Stato Maggiore era il comandante responsabile dell’esercito, non doveva tollerare intromissioni nella preparazione di pace e ancor più nelle operazioni belliche, pur facendo salva l’autorità formale del sovrano. Con queste parole egli giocava coscientemente le sue probabilità di successo, perché gli ambienti di corte non avrebbero certo rinunciato a ingerirsi negli affari militari. Poco dopo, infatti, apprendeva la nomina all’alto incarico del gen. A. Pollio, che peraltro doveva dare ottima prova.
Nel 1910 il C. assumeva il comando del corpo d’armata di Genova e, due anni più tardi, era designato per il comando della 2a armata in caso di guerra, con sede sempre in Genova. In questo periodo egli si dedicò all’approntamento delle fortificazioni della frontiera con la Francia e allo studio della cooperazione tra fanteria e artiglieria, che gli appariva necessaria per lo sfondamento delle difese nemiche. Nel 1913 veniva nominato senatore del Regno.
Il 6 luglio 1914 una riunione dei comandanti d’armata lo designava come nuovo capo di Stato Maggiore dell’esercito, al posto del gen. Pollio, scomparso immaturamente il 28 giugno. Il 27 luglio egli assumeva l’alto incarico, mentre stava per scatenarsi la successione delle mobilitazioni generali delle nazioni europee che doveva segnare l’inizio della guerra mondiale. Il giudizio del nuovo capo di Stato Maggiore sull’esercito era duro, e in termini ancora più severi egli si espresse nel dopoguerra, parlando di una crisi morale che aggravava la scarsezza di materiali e l’insufficienza dei quadri. Tuttavia egli non esitò a predisporre le operazioni offensive contro la Francia previste dai piani vigenti, che il silenzio del governo gli faceva credere sempre validi. Dopo la dichiarazione di neutralità il C. chiedeva l’immediata mobilitazione generale, che sola poteva mettere l’esercito in condizione di farsi valere: ad essa si oppose il governo, perché tale provvedimento avrebbe quasi inevitabilmente portato a un prematuro intervento. Non cessando di chiedere una politica di forza, il C. dava mano ai provvedimenti più urgenti per l’esercito, ma solo in ottobre, quando Salandra ebbe reso noto il rinvio dell’intervento a primavera, fu possibile impostare una organica preparazione su larga scala.
Il programma Cadorna-Zupelli, attuato dall’ottobre 1914 al maggio 1915, prevedeva la ricostituzione dei reparti dislocati in Libia e in Albania, pari alla forza di circa quattro divisioni, il completamento dell’equipaggiamento e dell’armamento individuale, la trasformazione delle batterie da campagna da sei a quattro pezzi, tutti a deformazione, la creazione di una modesta artiglieria pesante campale e l’ampliamento del parco d’assedio, la nomina di nuovi ufficiali con corsi accelerati (cui si presentarono molti tra gli interventisti). Contemporaneamente il C. chiedeva la mobilitazione industriale del paese per la guerra, con obiettivi per il momento modesti, e curava la riedizione del suo libretto di tattica (pubblicato a Roma), che nel febbraio 1915 fu distribuito a tutti gli ufficiali, col titolo Attacco frontale ed ammaestramento tattico: l’opuscolo univa ottimi principi a una visione dei combattimenti ormai superata, teneva insufficiente conto della guerra in corso (ma non era sempre facile afferrarne la novità anche per gli stessi combattenti) e incoraggiava, oltre le intenzioni dell’autore, un certo schematismo di mosse, che avrebbe giustificato in ufficiali impreparati l’assunzione a dogma del principio dell’attacco frontale anche dopo sanguinosi insuccessi. Il libretto fu molto criticato nel dopoguerra: in realtà, era tutta la dottrina prebellica che si rivelava superata dalla guerra di trincea.
Il 24 maggio 1915 il C. iniziava le operazioni contro le truppe austro-ungariche con trentacinque solide divisioni e un armamento purtroppo inadeguato alle crescenti esigenze della guerra di trincea. Nei trenta mesi in cui tenne il comando dell’esercito il suo comportamento fu rettilineo, ispirato a principî molto chiari e meditati: la necessità di un’assoluta unità di comando che non ammetteva deroghe né controlli, un elevatissimo senso del dovere che tutto sacrificava alla vittoria, la convinzione che il paese dovesse concorrere allo sforzo bellico con una totale adesione alle richieste dell’esercito in uomini e mezzi. L’impostazione strategica della guerra italiana (cui non contribuirono né il re né il governo, secondo la prassi) era semplice: impegnare il maggior numero possibile di divisioni austro-ungariche e distruggerle. Il C. rifiutava cioè di indirizzare lo sforzo italiano su obiettivi territoriali e intendeva progredire oltre l’Isonzo e le Alpi Giulie verso Lubiana, nella direzione più sensibile per il nemico; concentrò quindi le sue forze nel Friuli, ordinando uno schieramento difensivo nel Trentino e permettendo offensive locali nel Cadore e nella Carnia (che però causarono la dispersione delle scarse artiglierie pesanti). A questo piano si attenne anche quando fu evidente che i guadagni territoriali erano limitatissimi e molto costosi e che la guerra si riduceva a logoramento. Egli indirizzò quindi i suoi sforzi a ottenere nuove truppe e soprattutto nuovi materiali bellici, per rinnovare le “spallate” sull’Isonzo (undici battaglie complessive). Né si lasciò distrarre dall’offensiva austro-ungarica del Trentino (maggio 1916), da cui fu sostanzialmente sorpreso. Arrestate le penetrazioni nemiche con truppe tolte alle riserve, ristabilita una linea italiana, il C. concentrava nuovamente le sue forze sull’Isonzo e strappava al nemico Gorizia (agosto 1916), con la vittoria più sentita dall’opinione pubblica. Nel 1917 rinnovava i suoi assalti oltre l’Isonzo, e con truppe più provviste di mezzi riusciva a ottenere successi considerevoli (battaglia della Bainsizza, agosto del 1917) che spingevano l’Austria-Ungheria sull’orlo del collasso.
Assai ampia ed aderente alla situazione era l’impostazione che il C. dava ai rapporti con gli alleati e i teatri secondari d’operazioni. In contrasto con il governo, egli avrebbe voluto ridurre le forze italiane in Libia e Albania e accrescerle in Macedonia, dove potevano rappresentare un reale pericolo per il nemico. Era pure favorevole al più stretto coordinamento con gli eserciti alleati, cercando nel 1915 l’appoggio dei Russi e dei Serbi, scatenando più di una offensiva concordata con gli Anglo-francesi, proponendo nel 1917 il concentramento degli sforzi dell’Intesa contro l’Austria-Ungheria, punto debole della coalizione nemica. Anche in questi progetti fu osteggiato dal governo, legato a una concezione più ristretta della guerra.
La guerra di trincea era guerra di logoramento, e il C. la condusse con un’energia che non ammetteva ostacoli né debolezze, dando mano a una severa selezione dei quadri (furono esonerati 206 generali e 255 colonnelli) e a un ampliamento dell’esercito senza precedenti. I 548 battaglioni di fanteria del 1915 diventavano 867 nel 1917, con un armamento immensamente superiore (per es. 3.000 pezzi di medio calibro invece di 246 e 5.000 di piccolo calibro invece di 1.772).
Tuttavia egli non seppe ottenere il massimo rendimento da questi nuovi mezzi sul campo di battaglia: le truppe furono addestrate solo all’attacco frontale in masse compatte, senza conoscere né avvolgimento né infiltrazione, le grandi unità insufficientemente amalgamate per i continui scambi di reparti e per i siluramenti, trasferimenti e promozioni di alti ufficiali, troppi comandanti giudicati solo sull’energia con cui sapevano ributtare truppe esauste ad un ennesimo assalto. Inoltre il C. chiuso in una aristocratica concezione del dovere, non comprendeva tutte le esigenze molteplici del nuovo esercito formato da milioni di soldati semi improvvisati; egli aveva del combattente e della sua disciplina una concezione troppo rigida e astratta, che lo portava a non curare abbastanza il benessere materiale e morale delle truppe (turni di riposo, vitto e licenze, propaganda sugli scopi di guerra, assistenza alle famiglie, ecc.) e a sospettare mene sovversive e disfattistiche in ogni segno di stanchezza. E così, dinanzi a casi di ribellione o di cedimento di reparti nel 1917, il C. non si soffermava sulla tremenda tensione cui gli uomini erano sottoposti, ma ordinava fucilazioni sommarie e denunciava l’attività dei partiti contrari alla guerra e la debolezza del governo. In realtà, egli era tremendamente solo nella condotta della guerra: il dogma dell’unità di comando lo portava infatti a non volere intorno a sé collaboratori troppo autorevoli, con i quali suddividere le responsabilità, e a non accettare controlli né consigli, neppure quelli assai timidi del re. Al Comando supremo il gen. Porro, sottocapo di Stato Maggiore, era confinato in incarichi secondari e tutto il lavoro gravava su di un pugno di giovani ufficiali, di grande valore, ma privi di autorità ed esperienza, nessuno dei quali aveva comandato un reparto in trincea. Ne derivava l’isolamento del C., privo di contatti con la truppa, non assistito da un adeguato servizio di informazioni, spesso non in grado di assicurare l’esecuzione dei suoi ordini. Si noti infatti che alcuni dei più gravi errori tattici, come la continuazione degli attacchi contro un nemico ormai rinfrancato, avvenivano contro le intenzioni del C., il quale, non disponendo di ufficiali di collegamento e di dipendenti più affiatati, poteva più facilmente esonerare un comandante che controllarne l’operato. In complesso, egli aveva saputo formare un esercito immenso, armarlo con relativa ricchezza e guidarlo con fermezza e fede, ma non comprenderne appieno tutte le debolezze e le caratteristiche e quindi non valorizzarne tutte le risorse.
I rapporti tra Comando supremo e governo, poi, furono male impostati e peggio sviluppati. Prima del conflitto si riteneva inevitabile una netta separazione di responsabilità tra potere politico e potere militare: a questi principi s’ispirarono il C., Salandra, Sonnino, Boselli, anche quando l’estensione crescente dello sforzo bellico ne dimostrava la fallacia. E già si è detto che il piano di guerra venne elaborato senza ingerenze politiche, mentre il patto di Londra e le operazioni oltremare furono condotte senza richiedere né accettare il parere del capo di Stato Maggiore. Questi si veniva quindi confermando nell’opinione che a lui solo spettasse segnalare il fabbisogno dell’esercito in uomini e materiali, e che il governo non dovesse che adeguarvisi; e in realtà la lentezza con cui gli uomini politici responsabili afferravano il carattere totale e le nuove esigenze del conflitto impediva loro di rivendicare l’effettiva direzione della guerra. Nel vuoto di potere si inserì quindi l’azione decisa del C., che diede impulso allo sforzo nazionale e alla mobilitazione industriale esautorando il ministero della Guerra. Contemporaneamente egli impediva al governo qualsiasi ingerenza nella condotta delle operazioni e alle sue spalle sviluppava contatti con elementi politici interventisti, per imprimere più vigoroso ritmo alla preparazione bellica.
Grandi campagne di stampa ne innalzavano la figura, con un’esaltazione sempre meno misurata: la sua posizione poteva così essere travisata al punto che, nell’estate 1917, gli veniva chiesto di capeggiare un colpo di Stato di estrema destra per instaurare una dittatura militare capace di portare alla vittoria. Il C. rifiutava, ma l’episodio non poteva certo migliorare i suoi rapporti col governo. Si alimentava una incresciosa situazione di sfiducia reciproca, che trovava espressione nelle lettere con cui il C. nel giugno-agosto 1917 rigettava sulla debole politica interna di Orlando la responsabilità degli episodi di indisciplina e stanchezza verificatisi tra le truppe.
Il 24 ott. 1917 la 14a armata austro-tedesca sfondò le linee italiane, e da Caporetto progredì rapidamente verso la pianura veneta. L’offensiva non giungeva inattesa al Comando supremo, che il 18 settembre aveva diramato istruzioni di massima per il passaggio allo schieramento difensivo; ma assolutamente imprevista fu la rapidità dell’avanzata nemica, che toglieva alle lontane e scarse riserve strategiche italiane la possibilità di un efficace intervento. Senza soffermarsi ad analizzare le molteplici cause del crollo delle linee italiane (in gran parte imputabili ai comandi italiani), il C. attribuì la rotta a uno sciopero militare, a un collasso delle truppe provocato dalla propaganda neutralista, e il 27 ottobre diramò un bollettino (fermato dal governo, ma conosciuto all’estero) in cui si parlava di “mancata resistenza di reparti della 2a armata vilmente ritiratisi senza combattere ed ignominiosamente arresisi al nemico”. Lo stesso giorno telegrafava al presidente del Consiglio: “l’esercito cade non sotto i colpi del nemico esterno, ma sotto i colpi del nemico interno, per combattere il quale ho inviato al governo quattro lettere che non hanno ricevuto risposta”. Contemporaneamente egli esitava a dare l’ordine di ripiegamento, che pure la sorpresa strategica rendeva necessario, e diramava gli ordini relativi solo il 27 mattina. Il ritardo aggravava le condizioni della ritirata, che si svolgeva in crescente disordine. In quei giorni furono confermati i difetti di organizzazione del Comando supremo: il C. si trovò troppo solo, senza informazioni aggiornate sulla situazione (e quindi continuò a credere al collasso di tutta la 2a armata) e senza mezzi per dirigere i movimenti di ritirata (furono perciò possibili gravi insubordinazioni di comandanti, che concorsero ad aumentare le perdite). Ancora il 3 novembre scriveva al presidente del Consiglio: “siamo di fronte ad una insanabile crisi morale”; ma qualche giorno dopo, raggiunto il Piave con l’esercito dimezzato ma ancora valido, egli riprendeva fiducia nei soldati e lanciava l’ordine di resistenza ad oltranza: “nulla è perduto se lo spirito della riscossa è pronto, se la volontà non piega”.
Il suo esonero era però già stato deciso. Il nuovo governo costituitosi il 30 ottobre (Orlando presidente, Alfieri ministro della Guerra) aveva già in animo il provvedimento, più ancora che per la sconfitta (una sostituzione rappresentava un salto nel buio), per la convinzione che col C. non fosse possibile instaurare quella intima collaborazione tra governo e Comando supremo che pareva necessaria. Erano già stati designati Diaz e Giardino col favore del re, ma ogni decisione era stata rinviata nel tempo, per attendere la stabilizzazione del fronte (e quindi il 30 ottobre Orlando telegrafava al C. la sua fiducia). Ma il 6 novembre nel convegno di Rapallo gli Anglo-francesi ponevano come condizione della concessione delle loro truppe la sostituzione immediata del C., cui addebitavano il disordine della ritirata e il cattivo funzionamento del Comando supremo. Il 9 novembre il C. era perciò sostituito con Diaz e nominato membro del Consiglio superiore di guerra interalleato con sede a Versailles. La buona prova del nuovo Comando supremo durante l’ultimo anno di guerra avrebbe finito di comprovare l’opportunità dell’esonero. Accanto ai limiti accennati, è però necessario riconoscere al C. la grandezza della fede, l’ampiezza della visione strategica, la cognizione delle necessità della guerra moderna e infine l’energia con cui condusse due anni e mezzo di sanguinosi combattimenti.
Nel nuovo incarico, accettato solo per senso di dovere, il C. si adoperò con acutezza e larghezza di idee a promuovere una direzione unitaria degli alleati, avendo a colleghi i generali Foch, francese, e Wilson, britannico. Ma il 17 febbr. 1918 fu improvvisamente richiamato in Italia e collocato a disposizione della commissione d’inchiesta nominata dal governo Orlando per far luce sul disastro di Caporetto. Si iniziava così un durissimo periodo in cui il C. sarebbe stato indicato all’opinione pubblica come il principale responsabile della sconfitta e di ogni aspetto doloroso della guerra. Le conclusioni della commissione, apparse a fine luglio 1919, muovevano al C. severe censure, che acquistavano ingiusto risalto dal silenzio con cui si coprivano le responsabilità di altri esponenti militari e politici: e subito nel paese si scatenavano violentissime polemiche di stampa, in cui da entrambe le parti si perdeva il senso della realtà, passando da una vilissima denigrazione dell’ex comandante supremo a una faziosa esaltazione. Con un gesto che implicitamente sanzionava le accuse, nel settembre 1919 il C., che un anno prima era passato in posizione ausiliaria per ragioni d’età, fu collocato a riposo.
Le polemiche non lo indussero a uscire dal suo sdegnoso silenzio, pur se in manifestazioni private egli esprimeva simpatie per i movimenti di ex interventisti. La risposta alle accuse fu affidata ai due volumi di memorie: La guerra alla fronte italiana fino all’arresto sulla linea della Piave e del Grappa (Milano 1921), in cui il C. tracciò con chiarezza e limpido stile la storia del conflitto come egli l’aveva vissuto, senza concedere nulla alle polemiche. Alcuni problemi relativamente secondari, concernenti specialmente i suoi contrasti col governo sui teatri d’oltremare, furono poi trattati nelle Altre pagine sulla guerra mondiale (Milano 1925); meno interessanti le Pagine polemiche (Milano 1950), pubblicate postume dai figli, in cui si ribadiva la versione del C. sulla rotta di Caporetto, facendo risalire pur sempre le maggiori responsabilità al governo e alle truppe. Ricordiamo ancora altre opere storiche, come la biografia del padre (Il gen. Raffaele Cadorna nel Risorgimento italiano, Milano 1922), assai ricca di documentazione, e l’introduzione a Le più belle pagine di Raimondo Montecuccoli, da lui raccolte (Milano 1922). Inoltre il volume di Lettere famigliari (Milano 1967), selezione delle lettere degli anni di guerra curata dal figlio Raffaele.
Negli anni del dopoguerra, smorzatesi le polemiche nel paese, la valutazione della figura e dell’opera del C. continuò a essere contrastata: uno schieramento che andava dai nazionalisti al Corriere della Sera e al Mondo si batteva per una completa riabilitazione, mentre fascisti, giolittiani, popolari e le sinistre concordavano nell’avversare un provvedimento che avrebbe loro suonato come glorificazione della guerra regia e non di popolo. Il 4 nov. 1924 Mussolini volle troncare le discussioni sulla guerra nominando il C. e Diaz marescialli d’Italia; poco prima una sottoscrizione nazionale aveva offerto al C. una villa nella sua Pallanza. Egli riprese una attività pubblica in Senato (dove rientrò il 30 marzo 1925 con un discorso contro il ministro Di Giorgio, che fece riproporre il suo nome per i più alti comandi), nell’esercito e con viaggi all’estero.
Morì il 21 dic. 1928 in Bordighera: gli fu eretto nel 1932 un mausoleo a Pallanza.(fonte)
[4] Il Comando Supremo Militare Italiano era l’organo di vertice delle forze armate italiane, tra il 1915 e il 1920, durante il Regno d’Italia.
Istituito durante la prima guerra mondiale, il 24 maggio 1915, con sede operativa a Villa Volpe a Fagagna e dal mese di giugno nel Liceo classico Jacopo Stellini di Udine. Il Comando Supremo del Regio Esercito fu sciolto il 1º gennaio 1920 e parte delle sue competenze passarono allo Stato Maggiore del Regio Esercito.
Tra il 1941 e il 1945 fu istituito il Comando Supremo italiano.
Era suddiviso in tre organi principali, l’Ufficio del Capo di stato maggiore dell’Esercito Italiano Tenente Generale Luigi Cadorna, il Riparto Operazioni e il Quartier generale, composti da un certo numero di uffici ciascuno.
L’8 novembre 1917, dopo la Battaglia di Caporetto, la sede, dopo aver ripiegato dal 27 ottobre a Palazzo Revedin di Treviso, poi a Palazzo Dolfin di Padova, poi nella villa di Bruno Brunelli Bonetti a Tramonte di Teolo è stabilita all’Hotel Trieste di Abano Terme agli ordini del Generale Armando Diaz.(fonte)
[5] Franz Conrad von Hötzendorf. Feldmaresciallo austriaco, nato l’11 novembre 1852 a Penzing presso Vienna, morto a Mergentheim il 25 agosto 1925. Nel 1906 fu nominato capo di Stato maggiore. Tedesco di stirpe, egli era prettamente austriaco per sentimento, e considerava un furto le rivendicazioni dell’Italia nel 1859 e nel 1866; e sotto lo stesso punto di vista considerava le agitazioni interne ed esterne delle varie nazionalità della duplice monarchia. Perciò egli vide l’unico mezzo di salvezza nella guerra preventiva contro l’Italia (da lui considerata come il nemico tradizionale) e contro la Serbia, sede dell’irredentismo slavo: nel 1911 il ministro Aehrenthal, in seguito a un nuovo tentativo d’indurre alla guerra contro l’Italia impegnata a Tripoli, ottenne dall’imperatore che si ponesse fine a una politica dallo stesso ministro qualificata “di banditismo”, e il C. fu allontanato dalla carica di capo di Stato maggiore; alla quale fu però richiamato dopo la morte dell’Aehrenthal (1912).
Il C., rimase spesso un solitario, chiuso nella propria superiorità intellettuale, lontano dalla realtà: fino a vedere, ad esempio, continui disegni di aggressione da parte dell’Italia, la quale invece sino a pochi anni prima della guerra mondiale non aveva avuto, verso oriente, che timidi progetti di mobilitazione a carattere difensivo.
Allo scoppiare della guerra europea egli scrisse a Cadorna che il precedente capo di Stato maggiore, Pollio, gli aveva promesso di mandare truppe in Austria: il C. stesso nelle sue memorie, minute talvolta fino al superfluo, si guarda bene dal precisare dove il Pollio avrebbe fatto simile promessa, in realtà inesistente.
Anche in guerra il C. si tenne, per abitudine, fuori del contatto con i comandi dipendenti: il generale Krauss, capo di Stato maggiore del comando della fronte verso l’Italia, durante i 27 mesi trascorsi in tale carica non vide mai il C.: così si spiega come questi non conoscesse a sufficienza né i comandi né le truppe. Tali caratteristiche negative, e i preconcetti teorici spiegano gl’insuccessi che il C. ebbe nel campo della realtà. Fu quasi sempre in disaccordo con lo Stato maggiore germanico: tipico il dissenso col Falkenhayn nel maggio 1916, contro il parere del quale attuò l’offensiva del Trentino, con grave danno per le operazioni alla fronte russa.
Dopo la morte di Francesco Giuseppe, il nuovo imperatore volle assumere personalmente la direzione delle operazioni, ma non trovò un collaboratore gradito nel C., il quale d’altra parte aveva perduto molto del suo prestigio presso l’esercito in seguito all’insuccesso dell’offensiva del giugno 1916 contro l’Italia. L’imperatore Carlo lo mandò a comandare il gruppo di armate del Tirolo. La battaglia del Piave (v.) nel giugno del 1918, nella quale il C. sperava di attuare la sua antica concezione di scendere dagli Altipiani per prendere alle spalle il grosso dell’esercito italiano, fu un disastroso insuccesso per il maresciallo. L’imperatore lo esonerò dal comando, colmandolo tuttavia di onori. Il C. si ritrasse a vita privata e negli ultimi tempi attese a scrivere le sue memorie (Aus meiner Dienstzeit), dal 1906 fino a tutto il 1914, troncate dalla sua morte. Traspare in esse il malanimo contro l’Italia, diventato nel C. una seconda natura, ma le memorie sono un documento prezioso per la nostra storia mettendo in luce i progressi del nostro esercito negli anni precedenti la guerra.
L’odio tolse al C. la serenità necessaria per apprezzare al giusto valore gli avversarî e questa fu non ultima ragione per la quale il successo raramente gli arrise. Si debbono però riconoscergli grandi doti d’intelletto, di operosità e di carattere.(fonte)
[6] Edoardo Monti (Como, 19 luglio 1876 – 27 ottobre 1958) è stato un generale italiano.
Sottotenente di artiglieria nel 1896, frequentò la scuola di guerra e passò nel corpo di Stato Maggiore. Partecipò alla guerra libica del 1911-12 ed a tutta la guerra contro l’Austria, divenendo colonnello nel 1917. Fu successivamente Capo di Stato Maggiore del settore di Tarvisio e della divisione di Gorizia (1921), Comandante del 15º Reggimento artiglieria da campagna (1923) e poi (1926) Capo di Stato Maggiore di Corpo d’Armata di Bari. Generale di brigata nel 1928, fu ispettore di mobilitazione della divisione di Gorizia e nel 1929 passò al comando del corpo di Stato Maggiore. Con il grado di Generale di divisione comandò la 14ª Divisione fanteria “Isonzo” a Gorizia negli anni 1931-34. Trasferito a Cagliari assunse il comando del Corpo d’Armata della Sardegna con il grado di Generale di Corpo d’Armata e lo resse dal 1935 al 1936. In Bologna nel 1937 assunse il comando di quel Corpo d’Armata fino al 17 luglio 1939. Nominato designato d’Armata si trasferì a Como, sua città natale; in Milano assunse il Comando dell’Armata “S”, unità puramente cartacea, incaricata di studiare la difesa del confine settentrionale dal Monte Dolent al Cadore.
L’11 novembre 1939 trasmise allo Stato Maggiore del Regio Esercito una “Memoria operativa nell’ipotesi di violazione della neutralità svizzera da parte della Francia”. Il 15 dicembre 1939 ricevette direttamente da Mussolini l’incarico di sovrintendente alla fortificazione del “Vallo Alpino del Littorio” alla frontiera germanica; all’interno dell’Armata “S” l’ufficio preposto prese il nome di “Comando Presidio Monti”. Nel settembre 1940 il Comando venne sciolto e Monti continuò, sotto forma di consulenza, la sua collaborazione ai nuovi uffici preposti alla costruzione del “Vallo” fino al 19 luglio 1942, quando venne collocato nella riserva. Il 10 settembre del 1942 venne ricevuto a Palazzo Venezia da Mussolini il quale volle complimentarsi con lui, in modo particolare, per la condotta durante l’incarico di sovrintendente alla costruzione del Vallo Littorio alla frontiera germanica. Terminato l’importante incarico fu Presidente della Casa militare per i veterani in Turate (CO) fino alla morte. Poco dopo la fine della guerra fece parte di un giurì per indagare sulla responsabilità in ordine alla mancata difesa della piazza di Roma durante i tragici giorni susseguenti l’8 settembre 1943.
Ruolo nella realizzazione del Vallo Alpino. Prima dell’importante incarico di sovrintendente alla costruzione del Vallo Littorio alla frontiera germanica assegnatogli da Mussolini, di cui si è riferito nella biografia, il generale Monti aveva firmato in qualità di Sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito la Circolare 300, emessa il 21 gennaio 1932, con cui approvava le aggiunte e varianti alla Circolare 200 ed alla Circolare 800 compilate dall’Ispettorato dell’Arma del Genio.(fonte)
[7] Alberto Emanuele Lumbroso Nacque a Torino il 1o ott. 1872, in una famiglia israelita, unico figlio di Giacomo e di Maria Esmeralda Todros, di nazionalità francese.
Il nonno paterno, Abramo, protomedico del bey di Tunisi, aveva ottenuto nel 1866 da Vittorio Emanuele II il titolo di barone per meriti scientifici e per speciali benemerenze. Il padre del L., Giacomo, era nato a Bardo, in Tunisia, nel 1844. Ellenista e papirologo di fama internazionale, dal 1874 socio della Deutsche Akademie der Wissenschaften, influenzò fortemente l’educazione e la formazione intellettuale del Lumbroso. Trasferitosi a Roma intorno al 1877, divenne accademico dei Lincei (1878) e pubblicò la sua opera principale, L’Egitto al tempo dei Greci e dei Romani (Roma 1882), ottenendo nello stesso 1882 la cattedra di storia antica all’Università di Palermo. Con il medesimo insegnamento, nel 1884, si trasferì a Pisa, quindi, nel 1887, nuovamente a Roma dove insegnò storia moderna alla “Sapienza” (vedi le Lezioni universitarie su Cola di Rienzo, ibid. 1891). Giacomo morì a Rapallo nel 1925.
I trasferimenti del padre lasciarono notevoli tracce nella formazione del giovane L.; tra le sue prime esperienze romane si ricordano la frequentazione delle case di T. Mamiani e di Q. Sella, dove divenne amico di S. Giacomelli, nipote di questo; in Sicilia rimase affascinato da G. Pitrè e, nell’Archivio per lo studio delle tradizioni popolari da lui diretto, pubblicò nel 1896 il suo primo articolo.
Nel periodo pisano il L. continuò con successo gli studi e sviluppò una notevole passione per la cultura erudita, collezionando autografi, raccogliendo motti, proverbi e notizie folkloristiche, sempre in perfetta sintonia con il padre. Tornato a Roma si diplomò al liceo classico E.Q. Visconti, si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza e si appassionò al periodo napoleonico, laureandosi, intorno al 1894, con una tesi su Napoleone I e l’Inghilterra (poi rielaborata e pubblicata in volume: Napoleone I e l’Inghilterra. Saggio sulle origini del blocco continentale e sulle sue conseguenze economiche, Roma 1897). Gli studi napoleonici occuparono interamente il L. fra l’ultimo decennio dell’Ottocento e il primo del Novecento. La frequentazione di ambienti intellettuali ed eruditi italiani (soprattutto romani, torinesi e, più tardi, napoletani) e francesi, l’assoluta familiarità con la lingua della madre e lo sviluppo di un talento compilativo dimostrato fin dalla prima giovinezza portarono il L. alla realizzazione di un gran numero di pubblicazioni.
Tra il 1894 e il 1895 uscirono i cinque volumi del Saggio di una bibliografia ragionata per servire alla storia dell’epoca napoleonica (Modena), circa mille pagine dedicate alle lettere “da A a Bernays” (l’opera resterà incompiuta) e tra il 1895 e il 1898 le sei serie della Miscellanea napoleonica (Roma-Modena), altra cospicua opera erudita di oltre millecinquecento pagine che raccoglieva memoriali, lettere, canzoni, accadimenti notevoli e minuti forniti da studiosi europei e introdotti dal L.; nella Bibliografia dell’età del Risorgimento V.E. Giuntella li definì “saggi bibliografici che, sebbene arretrati, possono ancora essere utilmente consultati” (I, Firenze 1971, p. 405).
L’interesse per il periodo napoleonico portò il L. a Napoli, in cerca di notizie e documenti su Gioacchino Murat. Suo interlocutore privilegiato in quella città fu B. Croce: il L. frequentò la casa del filosofo negli ultimi anni del secolo e i rapporti epistolari tra i due si protrassero a lungo.
I maggiori lavori napoletani del L. furono la Correspondance de Joachim Murat, chasseur à cheval, général, maréchal d’Empire, grand-duc de Clèves et de Berg (julliet 1791 – julliet 1808 [sic]), (prefaz. di H. Houssaves, Turin 1899 e L’agonia di un Regno: Gioacchino Murat al Pizzo (1815), I, L’addio a Napoli, prefaz. di G. Mazzatinti, Roma-Bologna 1904.
Alla fine del secolo il L. fu organizzatore e presidente operativo del Comitato internazionale per il centenario della battaglia di Marengo (14 giugno 1800-1900): chiamò alla presidenza onoraria G. Larroumet, professore della Sorbona e accademico di Francia, ottenendo la partecipazione onoraria di noti intellettuali tra cui G. Carducci, B. Croce, G. Mazzatinti, C. Segre, A. Sorel, le cui lettere di adesione furono via via pubblicate nel Bulletin mensuel du Comité international; nel 1903, accompagnato da una lettera-prefazione di Larroumet, fu edito il primo tomo, poi rimasto senza seguito, dei Mélanges Marengo (s.l. [ma Frascati] né d.).
Ancora una volta il L. usa uno stile cronachistico, cerca e pubblica ogni genere di fonte, prediligendo quelle dirette. A tale scopo rintraccia figli e nipoti dei personaggi che descrive; caso emblematico quello dei “Napoleonidi”: e infatti, grazie ai suoi lavori e alle sue frequentazioni parigine, divenne “Bibliothécaire honoraire de S.A.I. le prince Napoléon” [Vittorio Napoleone]; pubblicò poi Napoleone II, studi e ricerche. Ritratti, fac-simili di autografi e vari scritti editi ed inediti sul duca di Reichstadt (Roma 1902), Bibliografia ragionata per servire alla storia di Napoleone II, re di Roma, duca di Reichstadt (ibid. 1905) e – più tardi – redasse le voci su Napoleone I e i Napoleonidi per il Grande Dizionario enciclopedico UTET (1937, VII, pp. 1100-1150). A coronamento dei suoi interessi per i Bonaparte, nel 1901 il L. fondò e diresse la Revue napoléonienne, bimestrale (ma, dal 1908, mensile) che uscì fino al 1913, coinvolgendo nell’iniziativa un gran numero di studiosi italiani e francesi.
L’interesse per la cultura d’Oltralpe lo portò a pubblicare anche lavori su Voltaire (Voltairiana inedita, Roma 1901), Stendhal (Stendhaliana: da Enrico Beyle a Gioacchino Rossini, Pinerolo 1902) e soprattutto Maupassant (Souvenirs sur Guy de Maupassant: sa dernière maladie, sa mort. Avec des lettres inédites communiquées par madame Laure de Maupassant et des notes recueillies parmi les amis et les médecins de l’écrivain, Genève-Rome 1905), scritto durante un lungo soggiorno parigino.
Nel 1898 il L. era intanto diventato consigliere della Società bibliografica italiana e probabilmente nel contesto culturale della Società conobbe Carducci, cui dedicò, postuma, una Miscellanea carducciana (con prefaz. di B. Croce, Bologna 1911), raccolta di notizie critiche, biografiche e bibliografiche sul poeta.
Nel 1897 aveva sposato Natalia Besso, dall’unione con la quale nacquero Maria Letizia (1898) e Ortensia (1901). Nel 1901 l’intera famiglia abbracciò la religione cattolica. Nel 1904 il L. donò la sua ricca biblioteca napoleonica (circa trentamila volumi e opuscoli) alla Biblioteca nazionale di Torino, da poco distrutta in un incendio. Nel 1907 assunse, con A.J. Rusconi, la direzione della Rivista di Roma e, a partire dal 1909, ne divenne direttore unico.
La direzione della Rivista rappresentò una svolta nei suoi interessi e nei suoi studi, che da internazionali ed eruditi divennero più “patriottici”, legati a eventi del Risorgimento e della storia italiana (in particolare il L. sì appassionò alla riabilitazione dell’ammiraglio C. Pellion di Persano e, oltre agli articoli apparsi nella Rivista, sull’argomento pubblicò La battaglia di Lissa nella storia e nella leggenda: la verità sulla campagna navale del 1866 desunta da nuovi documenti e testimonianze, Roma 1910, seguita da ulteriori approfondimenti, tra cui Il carteggio di un vinto, ibid. 1917). Tra coloro chiamati dal L. a collaborare alla Rivista – che dal primo momento egli volle “crispina, salandrina e antigiolittiana” e, dopo la guerra, “antibonomiana e antinittiana” (Premessa, s. 3, XXXII [1928], 1) – D. Oliva, E. Corradini, L. Ferderzoni, A. Dudan.
Dal 1909 G. D’Annunzio collaborò alla Rivista di Roma. Il contatto diretto portò in breve tempo il L., inizialmente piuttosto critico nei confronti del poeta (si veda del L. Plagi, imitazioni e traduzioni, in Id., Scaramucce e avvisaglie. Saggi storici e letterari di un bibliofilo(, Frascati 1902, pubblicazione che Croce aveva particolarmente apprezzato), a divenirne ammiratore e paladino, fino a entrare in forte polemica sia con lo stesso Croce sia con G.A. Borgese; nel 1913, nel cinquantesimo anniversario di D’Annunzio, volle dedicargli l’intero n. 6 della Rivista; nello stesso anno il L. fu attivo nel Comitato pro Dalmazia italiana e, nel 1914, diede vita a un Comitato pro Polonia del quale offrì la presidenza onoraria al poeta.
Approssimandosi la guerra, la Rivista di Roma svolse campagne in favore dell’intervento e, nel 1915, lo stesso L. partì volontario col grado di sottotenente. Promosso tenente, dal 1916 al 1918 fu addetto militare aggiunto presso l’ambasciata italiana ad Atene e, al termine del conflitto, fu insignito del cavalierato nell’Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro per benemerenze acquisite in guerra.
Nel 1924, ormai di fatto separato dalla moglie, il L. si trasferì a Genova dove riprese la pubblicazione della Rivista di Roma, sospesa nel biennio 1922-23, che diresse fino al 1932. A Genova ebbe due figli, Emanuele e Maria Tornaghi, nati nel 1918 e nel 1919 da Adriana Tornaghi, con la quale aveva a lungo convissuto.
Dopo la morte del padre, il L. ne pubblicò la bibliografia (in Raccolta di scritti in onore di Giacomo Lumbroso, Milano 1925); fin dal 1923 aveva collaborato con Critica fascista, e nel 1929 inviò suoi libri a B. Mussolini e chiese l’iscrizione al Partito nazionale fascista. I lavori più consistenti del L. negli anni Venti e Trenta furono dedicati principalmente alla Grande Guerra e a personaggi della casa reale.
Bibliografia ragionata della guerra delle nazioni: numeri 1-1000 (scritti anteriori al 1 marzo 1916), Roma 1920; Le origini economiche e diplomatiche della guerra mondiale, dal trattato di Francoforte a quello di Versailles, I-II, Milano 1926-28; Carteggi imperiali e reali: 1870-1918. Come sovrani e uomini di Stato stranieri passarono da un sincero pacifismo al convincimento della guerra inevitabile, ibid. 1931; Cinque capi nella tormenta e dopo: Cadorna, Diaz, Emanuele Filiberto, Giardino, Thaon di Revel visti da vicino, ibid. 1932; Da Adua alla Bainsizza a Vittorio Veneto: documenti inediti, polemiche, spunti critici, Genova 1932; Fame usurpate: il dramma del comando unico interalleato, Milano 1934.
Fra gli ultimi volumi pubblicati dal L. si ricordano ancora: Carlo Alberto re di Sardegna. Memorie inedite del 1848, con uno studio sulla campagna del 1848 e con un’appendice di documenti inediti o sconosciuti tradotti sugli autografi francesi del re da Carlo Promis (s.l. 1935) nonché, per i “Quaderni di cultura sabauda”, I duchi di Genova dal 1822 ad oggi (Ferdinando, Tommaso, Ferdinando-Umberto), ed Elena di Montenegro regina d’Italia (entrambi Firenze 1934).
Grazie al suo prestigio personale e all’adesione al cattolicesimo risalente al 1901, i Lumbroso furono discriminati dall’applicazione delle leggi razziali del 1938, ma il L. non pubblicò più. Il L. morì a Santa Margherita Ligure l’8 maggio 1942.(fonte)
[8] Luigi Segato (Belluno, 1856 – Torino, 1940) è stato un generale italiano, che ricoprì l’incarico di Sottosegretario di Stato alla guerra nel terzo governo di Giovanni Giolitti dal 2 gennaio al 13 dicembre 1908. Durante il corso della prima guerra mondiale fu comandante del XII, del IX e del I Corpo d’armata.
Nacque a Belluno nel 1856. Arruolatosi nel Regio Esercito frequentò la Regia Accademia Militare di Artiglieria e Genio di Torino da cui uscì con il grado di sottotenente assegnato all’arma di artiglieria nel 1876. Successivamente frequentò la Scuola di guerra e quindi passò in servizio presso il Corpo di Stato maggiore. Insegnò “arte militare terrestre” la Regia Accademia Navale di Livorno e quindi prestò servizio come maggiore presso il 20º Reggimento fanteria. Dal 1895 al 1899 insegnò “comunicazioni” presso la Scuola di guerra dell’esercito. Colonnello nel 1900, comandò il 75º Reggimento fanteria. Due anni dopo fu Capo di stato maggiore di Corpo d’armata e dal 1904 al 1906 comandò in seconda la Scuola di guerra. Maggior generale comandante la Brigata Calabria nel 1906, all’inizio del 1908 fu nominato Sottosegretario di Stato alla guerra nel terzo governo di Giovanni Giolitti. Passò poi a comandare la Brigata Palermo venendo promosso tenente generale nel 1911, e poi comandò la Scuola di guerra sino al 1914, anno nel quale assunse il comando della Divisione militare di Torino. Comandante il XII Corpo d’armata schierato in Carnia nel 1915, alla testa di esso entrò in guerra contro l’Impero austro-ungarico il 24 maggio dello stesso anno. Assunse poi il comando del IX Corpo d’armata, sostituendo il generale Pietro Marini il 20 giugno. Decorato con una Medaglia d’argento al valor militare, il 29 ottobre fu sostituito, ufficialmente per motivi di salute, dal generale Oscar Boffi. In realtà la sua sostituzione fu voluta da Luigi Cadorna a causa di un suo rapporto indirizzato al Comando Supremo in cui riferiva il deplorevole stato morale e disciplinare delle sue truppe. Divenuto comandante del I Corpo d’armata operante nel settore del Cadore il 4 marzo 1916, in sostituzione di Settimio Piacentini, mantiene l’incarico sino al 12 maggio 1917, quando è sostituito da Gaetano Giardino. Nel 1917 divenne comandante del Corpo d’armata territoriale di Bologna, mantenendolo fino alla fine del conflitto. Transitò in posizione ausiliaria nel 1919. Con Regio Decreto del 12 dicembre 1923 fu nominato generale di corpo d’armata e qualche anno dopo passò nella riserva. Decorato con la Gran croce dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro si spense a Torino nel corso 1940.(fonte)
[8] Francobollo Poste Italiane – 50 cent. Regno Vittorio Emanuele. Serie imperiale. (annullo 1931). La Serie Imperiale è una serie di francobolli emessa dal Regno d’Italia nel periodo tra il 1929 e il 1942, e successivamente modificata nel periodo della Luogotenenza di Umberto II dal 1944 al 1946. Questa serie di francobolli è stata largamente utilizzata nell’arco di oltre quindici anni e se ne conosce il suo uso anche nei primissimi anni della Repubblica (si veda “uso tardivo dei francobolli del Regno” in periodo della Repubblica nel catalogo Sassone). Analoghi valori, in genere sovrastampati, vennero emessi per le Colonie, le Occupazioni della seconda Guerra Mondiale e nel periodo della Repubblica Sociale Italiana.
Le vignette emesse nel periodo del Regno (1929-42) erano contraddistinte dalla presenza di fasci littori posti ai due lati, e riproducevano vari soggetti, a partire dallo scudo di Savoia effigiato nel c.2, proseguendo con la lupa capitolina, Vittorio Emanuele III in varie pose su diversi valori, Giulio Cesare, l’imperatore Augusto e l’Italia turrita.
Nel periodo della Luogotenenza vengono rimossi i fasci e la filigrana corona viene prima tolta e poi sostituita dalla filigrana Ruota Alata, successivamente di largo uso nel periodo della Repubblica; vi furono emissioni di diverse città, con soggetti e colori variati. Si conoscono anche falsificazioni dell’epoca sul valore da c.50 effettuate in Italia (S. Giuseppe Vesuviano e Milano), o sul valore da c.25 eseguita in Inghilterra che, nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, aveva il preciso intento di indebolire l’economia Italiana.
Furono emesse anche Cartoline Postali e Biglietti Postali riproducenti francobolli della serie.
I francobolli base hanno i seguenti valori: 2 centesimi, 5 centesimi, 7,5 centesimi, 10 centesimi, 15 centesimi, 20 centesimi, 25 centesimi, 30 centesimi, 35 centesimi, 50 centesimi, 75 centesimi, 1 lira, 1,25 lire, 1,75 lire, 2 lire, 2,55 lire, 3,70 lire, 5 lire, 10 lire, 20 lire, 25 lire, 50 lire; visto il periodo di guerra però la serie venne utilizzata anche da Regno del Sud, Repubblica Sociale Italiana e vari altri (esclusi i valori emessi da CLN o altre amministrazioni come occupazione italiana d’Albania), con o senza sovrastampe ed in totale i diversi valori di affrancatura emessi tra francobolli, interi e biglietti sono circa 400; il suo utilizzo venne tollerato anche durante il periodo della Repubblica, dopo il 2 giugno 1946.(fonte)
[9] Nel 1876 iniziò la sperimentazione di una macchina bollatrice delle Officine Dani di Firenze che imprimeva simultaneamente in un solo colpa un numerale posto tra due gruppi di tre linee orizzontali sul francobollo, ed a fianco un datario a cerchio grande. A Firenze vennero anche effettuati test con altri tipi di numerali, non abbinati però solidamente al datario.
Superata questa nuova fase di sperimentazione, si decise di adottare il c.d. “numerale a sbarre” abbinato ad un nuovo tipo di datario a cerchio grande. Ai nuovi uffici si continuò ad attribuire nuovi numeri, fino al 4473.
Cerchio grande tipo “italiano”. Entrò in uso dal 1877, contemporaneamente ai numerali a sbarre che accompagnava per indicare località di partenza e data. In combinazione ai numerali di norma non è apposto sul francobollo, mentre lo si riscontra di solito come annullatore unico nelle circolari a stampa. Diametro 26-27 mm.
Esistono vari sotto-tipi, i principali sono caratterizzati dall’assenza o presenza della stelletta in basso al centro. Nella parte bassa si trova anche, se necessaria, l’indicazione della succursale. In un secondo tempo (dal 1887), vennero anche forniti cerchi grandi con l’indicazione in basso della provincia.
In molti uffici rimasero in uso come unico annullatore dopo la sparizione dei numerali, talora fino agli anni ’10 (in qualche caso all’inizio degli anni’20).
Numerale a punti. In uso dal 1 maggio 1866 (in alcuni uffici minori da aprile) al 1877, poi sostituito dal numerale a sbarre. Ispirato agli annulli in uso in altri paesi, come l’Inghilterra, al fine di lasciare una traccia più pesante sui francobolli e scoraggiare così il riutilizzo. Contestualmente venne fornito un inchiostro di “migliore qualità”.
Recava il numero distintivo dell’ufficio postale. Utilizzato come annullatore abbinato ai datari di tipo “doppio cerchio” o “cerchio piccolo”.
Il sistema di annullamento prevedeva che quindi una doppia bollatura di ogni missiva: il datario a doppio cerchio e cerchio semplice venisse apposto sulla busta in modo da essere interamente leggibile, mentre il numerale doveva annullare pesantemente l’affrancatura.
Bolli di foggia analoga ai numerali a punti ma con lettere o numeri romani furono utilizzati per uffici di tipo particolare (posta militare della terza guerra d’indipendenza e della presa di Roma, ufficio postale di San Marino).(fonte)