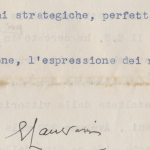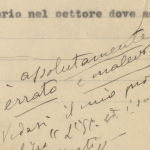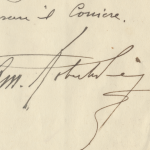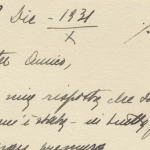COMANDO MILITARE MARITTIMO IN SICILIA
MESSINA
L’AMMIRAGLIO
Messina 25-4-32
Gentilissimo Barone
Rispondo alla sua cartolina.
Se crede utile pubblicare le mie
modeste note col mio nome, faccia
pure, preferibilmente come lettera
a lui scritta in risposta a una
domanda
Ho tolto qualche frase e corretto
qualche parola e le invio la nuova
versione se è in tempo.
Mi creda creda
afferm
-Guido Vannutelli[1]
(apr. 1932)
IL CONTRAMMIRAGLIO GUIDO VANNUTELLI
COMANDANTE MILITARE MARITTIMO IN SICILIA
Le invio le promesse note
sull’Articolo del gen. Monti[2]
Cordiali Saluti
Guido Vannutelli
CIRCA UN’ASSERITA MANCATA OFFENSIVA ITALIANA SULL’ALTOPIANO D’ASIAGO
DURANTE LA BATTAGLIA DEL GIUGNO 1918
============
Premetto che a me non consta che il Comando Supremo italia=
no preparasse un’offensiva 0 di cui lo sforzo principale
avrebbe dovuto essere compiuto dalla 6a armata (gen. Mon=
tuori[3]) contro il Conrad[4] = mentre gli austriaci stavano or=
ganizzando la loro offensiva del giugno ’18. = Tanto meno mi
consta che tutto da parte nostra fosse predisposto.
Cadrebbe pertanto senz’altro la critica della manca=
ta esecuzione di questa asserita offensiva. Giova, comunque,
precisare alcuni dati di fatto.
Un’offensiva sull’altipiano di Asiago venne effet=
tivamente progettata dal nostro Comando Supremo, dopo la bat=
taglia del Piave, per l’estate=autunno 1918, con lo scopo di
conquistare l’orlo settentrionale dell’altopiano medesimo
e tagliare la val Sugana all’avversario, come pure venne pro=
gettata altra operazione tendente alla conquista del massic=
cio del Col Santo, per dare maggiore profondità all’occupazio=
ne del Pasubio e tendere possibilmente all’altopiano di Fol=
garia.
Ma tali operazioni furono studiate e in parte predi=
sposte a puro titolo di concorso all’offensiva degli alleati
sulla fronte occidentale: esse, dii fatto, non potevano eviden=
temente condurre a risultati decisivi, destinate, com’erano, a
logorarsi contro posizioni potentemente organizzate a difesa
e adatte a grandi schieramenti di artiglieria.
Nell’ipotesi più favorevole, l’azione sull’altipiano di
Asiago non avrebbe inflitto all’avversario uno scacco tale
da diminuirne sensibilmente e per un certo tempo l’efficen=
za: in definitiva, l’operazione si sarebbe ridotta a un loca=
= 2 =
le miglioramento della nostra fronte di difesa.
Per contro, l’esercito italiano si sarebbe venuto a tro=
vare senza alcuna riserva fresca e con forti perdite da ri-
pianare, in condizioni tali, cioè, di grave crisi di fronte a
una controffensiva nemica. Diciamo di più: l’offensiva sul=
l’altopiano avrebbe compromesso Vittorio Veneto.
Ma a prescindere da questo converrà chiederci se, il nostro Comando Supremo
era in grado di passare alla controffensiva sulla fronte mon=
tana non appena contenuto e ributtato l’attacco nemico dalla
6a. e 4 a. armata, quando ancora la fronte del Piave risultava
gravemente minacciata.
Per rispondere a questa domanda, basterà dire che a batta=
glia finita, noi non disponevamo che di sole sei divisioni
intatte. Si poteva con tali unità tentare operazioni di vasto
raggio, che avrebbero richiesto non solo ben altre forze, ma
ancora mezzi logistici assolutamente non disponibili?
Sta di fatto che se l’avversario aveva avuto nella batta=
glia perdite calcolate allora a 200.000 uomini, l’esercito no=
stro aveva subito un logoramento di circa 90.000 uomini, il
che aveva richiesto l’impiego di quasi tutti i complementi
disponibili.=
Il Comando Supremo italiano era perfettamente consapevo=
le del sommo interesse di passare senz’altro ad una offensi=
va in grande, sfruttando la sconfitta avversaria; ,ma per ciò
fare, gli occorreva una massa di manovra che assicurasse ri=
sultati decisivi. Ora, contenuta e poi ributtata l’offensiva
austriaca, noi eravamo bensì in piena efficienza difensiva, ma
assolutamente non in grado di passare all’attacco per svilup=
pare offensivamente il successo ottenuto nella battaglia di=
fensiva.
In ogni modo, quale sarebbe stata la probabile direttrice
= 3 =
di questa nostra offensiva di giugno ? Sembra non esser
lontana dal vero l’ipotesi più logica di una manovra tenden=
te a separare la fronte avversaria montana da quella del
Piave : in altre parole, la manovra attuata quattro mesi
dopo a Vittorio Veneto. = Solo un’operazione del genere
avrebbe potuto portare a risultati decisivi e non già un
attacco sulla fronte montana che, fra l’altro, si presentava
nelle condizioni logoranti delle battaglie carsiche.
Concludiamo. Il Comando Supremo italiano doveva im=
pegnare la battaglia risolutiva della guerra nelle condi=
zioni di maggior sicurezza di vittoria, ciò che fece a Vit=
torio Veneto . .=
Se subito dopo la battaglia del Piave o, peggio ancora,
durante la battaglia stessa, fosse passato a una grossa of=
fensiva, non solo non avrebbe conseguito risultati apprezza=
bili ai fini della messa fuori causa dell’Austria (obietti=
vo della guerra), ma si sarebbe messo in istato tale da non
poter poi nell’ottobre successivo intraprendere o almeno
portare a glorioso compimento la grande manovra di Vitto=
rio Veneto. Le conseguenze che ne avrebbero derivate appaio=
no troppo evidenti perché abbisognino d’essere illustrate.
E vada la riconoscenza della Nazione al maresciallo Ba=
doglio[5], al quale si deve se proprio il disegno offensivo sul=
m’altopiano di Asiago, progettato e predisposto per l’estate=
autunno 1918, non venne attuato. Egli si oppose nettamente
alle insistenze del Presidente del Consiglio[6] per l’esecuzio=
ne dell’operazione. “ Dìa l’ordine per iscritto”= disse il
Sottocapo di Stato maggiore.= Ma il Presidente, il quale al=
legava impegni assunti con gli Alleati, se ne guardò bene.
E la grande vittoria fu salva ! =
Barone Dott. Alberto Lumbroso[7]
Rivista di Roma
12 A Via Marcello Durazzo
Genova
MESSINA CORRISPONDENZE – tre francobolli Cent 50
GENOVA SEZIONI RIUNITE
Note
[1] Appunti su Guido Vannutelli:
ANNUARIO UFFICIALE DELLE FORZE ARMATE DEL REGNO D’ITALIA.
ANNO 1934 -XII
II
REGIA MARINA
p. 50
CONSIGLIO D AMMINISTRAZIONE PER I FUNZIONARI CIVILI
S. E. il Ministro o S. E. il Sottosegretario di Stato presidente
Vannutelli Guido ammiraglio di divisione Direttore generale del Personale e dei Servizi militari membro.
….(fonte)
Si aggiungano 35.653 quadrupedi, 3.683 automezzi e 26 unità della divisione navale al comando dell’ammiraglio Guido Vannutelli, e si avrà un’idea della macchina bellica a disposizione di De Bono.
da Gli italiani in Africa Orientale – II. La conquista dell’Impero
Di Angelo Del Boca
——————–
tra le opere dell’Ammiraglio Guido Vannutelli ricordiamo:
Il mediterraneo e la civiltà mondiale
dalle origini all’ impero fascista della nuova Italia
Licinio Cappelli Editore Bologna , 1936
Sul Mirabello a Fiume, 1940
“La sera del 9 settembre 1919 l’esploratore ‘Mirabello’, del quale avevo il comando col grado di capitano di fregata, ebbe l’ordine di partire per Pola, dove giunse nel pomeriggio del 10, passando agli ordini dell’Ammiraglio comandante dell’Alto Adriatico. Il mattino del 12 proseguì per Fiume (…).” Dall’incipit del primo capitolo. (fonte)
——————–
Da LA RIVENDICAZIONE FASCISTA DELLA CORSICA (1938-1943) di Marco CUZZI
Per circa due anni, dall’autunno 1919 all’estate 1921, il viaggiatore Carlo Mirabello fu spettatore, nel porto di Fiume, degli avvenimenti dell’impresa dannunziana. Posizionato dalla Reale Marina nella città non ancora unita insieme alla corazzata Dante, in quei tumultuosi mesi il Mirabello giocò un ruolo di rilievo. Il suo capitano era il Capo Flottiglia Guido Vannutelli, il quale in seguito come ammiraglio avrebbe comandato la Divisione Navale in AOI durante la guerra d’Etiopia. In questo poco conosciuto libro, redatto quasi come un resoconto ufficiale ma non per questo privo di riflessioni personali, Vannutelli narra giorno per giorno gli avvenimenti fiumani. La particolarità del testo consiste nel fatto che, benché pubblicato nel 1940, non può certamente essere definito celebrativo. È vero, l’impresa a Fiume è descritta come il risultato della Vittoria mutilata alla quale solo il nuovo regime avrebbe reso giustizia (almeno così si legge nella fervida dichiarazione dell’ultima pagina), ma in realtà non mancano considerazioni critiche. Vannutelli dipinge accuratamente lo stato d’animo dei militari di Marina (e non solo) divisi tra la simpatia per la causa fiumana e il senso del dovere, sempre tuttavia fedeli agli ordini di governi che in cuor loro disprezzavano. L’autore non tralascia di narrare gli aspetti più sfavorevoli dell’episodio: le violenze fra connazionali, l’inefficacia di alcuni proclami, i ripetuti tentativi (anche forzati) da parte dei legionari di reclutare seguaci tra i marinai, la sorpresa per la defezione di alcune unità (ad esempio, il Nullo e il Bertani). Oltre che per questa sincerità intellettuale – certamente non comune nel 1940 – il libro merita attenzione per la minuziosa narrazione delle vicissitudini a bordo, delle operazioni navali (in particolare il bombardamento nella “Giornata di sangue” da parte del Doria) e dei numerosi protagonisti, fra i quali – sebbene non menzionati esplicitamente – Cagni e Millo. Con piacere segnalo questa opera in occasione delle celebrazioni del centocinquantesimo anniversario della nascita del Poeta.
Nei progetti iniziali della Commissione italiana per l’armistizio con la Francia (Ciaf), la Corsica sarebbe stata inserita tra le aspirazioni apparentemente irrinunciabili. Tuttavia, le lunghe trattative di Villa Incisa e poi l’infinita vertenza della Ciaf avrebbero visto la rivendicazione corsa in una posizione sempre più sfumata. Una delegazione della Ciaf giunse in Corsica nel luglio 1940 e apparentemente il tema trattato con le locali autorità vichysois sembrò più orientato verso la smilitarizzazione dell’isola, secondo le clausole di Villa Incisa. I delegati italiani apparvero quindi molto rispettosi dell’autorità francese, prendendo le distanze dall’estremismo dei seguaci di Giovacchini o di Guerri. Tuttavia, come ricorda Rainero « Non si creda che la rinuncia all’annessione immediata della Corsica sia passata tra le decisioni più facili del regime ; la rivendicazione rimase quasi « a futura memoria », in attesa di un regolamento della pace […] ».
D’altronde non a caso il maresciallo Badoglio, soltanto due mesi dopo la visita della delegazione della Ciaf sull’isola, sottopose a Mussolini un progetto per l’invasione della Corsica mediante due divisioni, provenienti rispettivamente da Livorno e dalla Sardegna33. Il piano si sarebbe sviluppato nei mesi successivi. Nell’incontro tra i capi di stato maggiore della marina italiana e tedesca, tenutosi a Merano il 13 e 14 febbraio 1941, l’ammiraglio Riccardi disse chiaramente al suo collega germanico Raeder che lo stato maggiore della marina aveva predisposto un piano per l’occupazione dell’isola, suscitando peraltro disapprovazione da parte tedesca : l’occupazione della Corsica non solo era considerata dal Terzo Reich inutile, ma anzi dannosa nella strategia globale del conflitto, e avrebbe spinto definitivamente Vichy (e senz’altro l’intero Nordafrica francese, ancora tentennante) tra le braccia dei britannici.
Irritati delle opinioni dell’alleato, ma impossibilitati a prescindere da queste visti i rapporti di forza all’interno dell’Asse, i comandi italiani proseguirono nel perfezionamento solo teorico del piano, in attesa di tempi più favorevoli, e lo trasformarono in un progetto interforze tra marina ed esercito. Il nuovo piano, redatto dall’ammiraglio Vannutelli (che avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di comandante dell’eventuale contingente d’occupazione), escludeva significativamente l’impiego dei separatisti di Rocca e tanto meno degli irredentisti di Giovacchini, entrambi considerati infidi e pasticcioni. Pur prevedendo ampie tutele all’« etnia corsa » (riconoscimento dei diritti acquisiti degli impiegati corsi, uso del dialetto corso nei processi eccetera), l’isola sarebbe stata governata da un viceré (come l’Albania) o da un alto commissario (come la Slovenia) con pieni poteri esecutivi e due sotto-governatorati ad Ajaccio e a Bastia, corrispondenti alle due zone (le « Bande ») in cui veniva tradizionalmente suddivisa l’isola tirrenica35. La stessa Ciaf aveva previsto nel 1942 un piano d’occupazione della Francia che prevedeva sia nella versione di massima che in quella di minima un saldo insediamento delle autorità militari e civili italiane in tutti i gangli amministrativi e politici dell’isola.
35 Amm. Div. Vannutelli, « Programma per la Corsica », 9 novembre 1941, in ACS, PCM (1940-1943), G 23/2 30582.(fonte)
——————–
DOCUMENTO N. 34
ALLEGATO 724 AL DIARIO STORICO
Riccardi, Sottosegretario di Stato Ministero Marina, a Comando Supremo
Roma, 9 novembre 1941
Prot. n. 15331
Allegati 1
Oggetto Programma per la Corsica.
Rimetto, per conoscenza, copia di uno studio sommario, dal titolo «Programma per la Corsica» compilato dall’Ammiraglio di Divisione R.N. Guido Vannutelli, che ha tenuto per circa 14 mesi la carica di Capo della Delegazione di Aiaccio della Commissione di Armistizio con La Francia.
Vannutelli. capo Delegazione mista di Armistizio Corsica.
Aiaccio, ottobre 1941
Oggetto: Programma per la Corsica
La Corsica è annessa nel modo più intimo all’ambiente geografica italiano, e i suoi caratteri etnici, linguistici, culturali. religiosi ed economici sono prettamente italici pur essendo tinti di autonomi.mo e di particolarismo.
Nel quadro strategico, poi, essa rispetto alla nostra penisola costituisce il complemento tirrenico indispensabile per la vitale sicurezza del suo fianco volto verso l’occaso.
In conseguenza II nostro programma non può essere che quello di ottenere in ogni modo la riunione della Corsica all’Italia
…
Nel giugno 1940 noi abbiamo affrontato un conflitto con la Francia che e stato parziale e a pronta conclusione, sicché nel suo brevissimo sviluppo non abbiamo potuto operare per risolvere il problema corso.
È seguito un armistizio che, per circostanze di cui è inutile fare qui l’esame, è risultato incompleto nei riguardi dell’isola.
Poi fra la fine del 1940 e durante il 1° semestre del 1941 l’andamento incerto della guerra mediterraneo ha ostacolato ed impedito l’indispensabile nostra azione di completamento delle norme armistiziali per la Corsica., mentre In essa veniva sviluppata una effervescenza artificiale degli spiriti a noi avversi, volta ad appoggiare per una futura resistenza il debole apparecchio difensivo rimastole dopo il disarmo della Francia.
Ora. se non si riuscirà a smorzare o ad attenuare il lievitamento di alcune correnti corse eccitate dall’azione francese, la occupazione militare, cui dovremo in ogni caso addivenire, potrebbe incontrare difficoltà assai intense che ci obbligherebbero ad un prolungato e vasto impiego di forze, con ripercussioni disastrose pel successivo processo di amalgamazione al quale si deve tendere.
…
È opportuno accennare agli elementi della situazione.
Dopo II 1769 la Francia, che aveva spossessato Genova e donato violentemente Pontenovo l’eroico sforzo verso l’indipendenza isolana guidato da Pasquale Paoli, giunse alla tanto agognata dominazione sulla Corsica.
Senonché la sua amministrazione, (essenzialmente sfruttatrice), ha sempre avuto caratteri negativi, né poteva essere altrimenti mancando qualsiasi omogeneità psicologica tra Côrsi e Francesi. Essa ha portato alla corruzione della fierezza congenita degli abitanti e alla degenerazione della loro naturale economia fondata sull’agricoltura e sull’allevamento pastorizio, imponendo alla Corsica un asservimento assoluto alla Francia continentale, isolandola dall’Italia e creandovi un artificioso benessere fondato sulla classe impiegatizia e sulle pensioni statali. Oltre che attirare grandi masse di Côrsi nei ranghi della sua amministrazione nelle colonie e nel continente, la Francia ha favorito nell’isola il moltiplicarsi del clientelismo politico, fiaccando le aspirazioni verso un sereno esercizio della giustizia e adibendo le forze statali, amministrative e di polizia, al servizio e alla protezione degli abusi e delle prepotenze.
Ha poi lasciato inquinare dal settarismo la funzione educatrice della gioventù, mirando principalmente, benché finora con risultati incompleti, a sostituire alle nazionali la lingua e la cultura francesi.
In tal modo ha disorientato e disperso le energie vitali del Côrsi distogliendoli dall’operare secondo le loro migliori tendenze per l’avvenire dell’isola.
Però il periodo di 170 anni di dominazione trascorso fino ad oggi dimostra che essa non è riuscita a provocare tra gli isolani una sensibile adesione alla vita francese sa non nei pochi centri cittadini e nelle minoranze legate agli stipendi statali, né a soffocare mortalmente i primigenii inconfondibili caratteri della stirpe, mentre tutti I problemi economici, sociali e di progresso civilizzatore dell’isola sono stati tenuti indietro.
Tale bilancio è palese, e tutti i provvedimenti qui presi in tempo di armistizio rilevano nello stato dominatore una scarsa sicurezza dl prestigio e una inquieta diffidenza che lo spingono ad accentuare fino al parossismo I sistemi di grossolana polizia e la pratica delle promesse evanescenti nel futuro.
…
Da parte dell’Italia, oltre all’evidente affinità nazionale e ai temporanei diritti dell’armistizio vi sono due fattori da prendere in esame: la incerta pressione dei cittadini italiani tuttora residenti in Corsica e la limitatissima Influenza del minuscolo «Partito Autonomista Côrso», volto tendenzialmente all’irredentismo.
Nell’isola dopo I rimpatri rimangano da 5 a 6 mila Italiani regnicoli, in maggioranza diligenti lavoratori ma di modesta levatura e rassegnati alla funzione di iloti nella quale l’amministrazione francese ha saputo confinarli. Contro una piccola parte di essi, più risoluti a conservare l’italianità, sono state esercitate le sevizie dei campi di concentramento che li hanno fiaccati, mentre la grande maggioranza si è adattata, per opportunismo, ad una formale indifferenza patriottica. Nella massa a distinguono i comunisti e I cosiddetti fuorusciti, nei quali la polizia francese alimenta l’adesione alla Francia eccitando la loro avversione contro la moderna Italia e contro il Fascismo per la paura di divenire oggetto di persecuzioni in una Corsica Italiana. In complesso non vi é da contare molto sui nostri connazionali dell’isola.
Anche contro I pochi autonomisti Côrsi si e scatenata l’opera della polizia e dei politicanti francesi, riuscendo a concentrare contro di essi gli odii dei partiti locali, e riservando loro, durante la guerra e dopo, un trattamento feroce quale poteva essere immaginato da bolscevichi verniciati di civiltà occidentale. Il martirio che hanno subito gli autonomisti merita profonda riconoscenza e ampie ricompense nazionali, ma per loro scarso seguito non è possibile basare la nostra futura azione di assorbimento su di essi che sarebbero naturalmente portati alla rivalsa delle persecuzioni e delle ostilità subite, e quindi a perpetuare le scissioni isolane.
II
Le direttive seguite dopo l’armistizio dalla Autorità francese per prepararsi a combattere le nostre rivendicazioni sulla Comica possono osi essere definite:
— nel campo militare l’opera degli organi competenti ha cercato di affiancare ala scarsissima apparecchiatura di forze armate, rimaste di presidio nell’isola, alcuni corpi paramilitari, come l’Associazione dei Combattenti e i Compagnons de France, che, inquadrati e riscaldati da una propaganda Intensificata, permetterebbero una più seria resistenza alla nostra occupazione.
Tale resistenza, favorita dalle difficoltà naturali del paese e dal possesso di anni generali nei arsi, potrebbe prolungarsi per un periodo considerevole secondo gli esempi numerosi che cl offre la storia dell’isola, dando tempo al Governo francese di arrivare a manovrare In modo efficace nel campo internazionale.
Quanto all’azione politica ispirata da Vichy essa risulta ben chiara da alcune indiscrezioni. Nel mese scorso il Maresciallo Pétain parlando con un uomo politico corso si espresse nel modo seguente:
a) dal punto di vista storico non possiamo in verità sostenere che la Corsica sia francese;
b) non possiamo basare le nostre rivendicazioni sull’isola per la sua lingua che italiana;
c) possiamo solo batterci per l’attaccamento che manifesta alla Francia.
Da tali apprezzamenti sarebbe scaturito il programma di cd I stata iniziata l’attuazione, per i quale, secondo informatori bene a conoscenza del problema, si prevederebbero tre fasi cos caratterizzate:
1) Dimostrazioni propagandistiche in tutti i centri urbani e rurali dell’isola.
2) Protesta da pane del Governo dl Vichy che chiederà di organizzare nella Corsica un plebiscito di adesione.
3) Appelli provocati tra i Côrsi e diretti ai popoli per domandare di continuare a far parte della Francia.
Ora, considerando i vari elementi di Incertezza esistenti nelle condizioni spirituale l’attivissima propaganda antitaliana esercitata con ogni mezzo e con ogni moneta nella Corsica, devesi riconoscere che non provvedendo in tempo ad una chiarificatone dei punti oscuri tale programma. applicato nel plebiscito senza sincerità e con tutti i lenocinii di cui gli amministratori francesi sono capaci, avrebbe la quasi certezza di sboccare in una affermazione favorevole alla loro politica.
III
In conseguenza per l’Italia si tratta di arrivare alla fase risolutiva avendo, per quanto possibile, sgombrato il terreno dalle molte pregiudiziali avverse che ad arte vi sono state accumulate e spazzato i preconcetti che alterano la nostra visione di Insieme.
Con tale mira devesi preventivamente proclamare la nostra tolleranza per tutte le particolari situazioni dell’isola: quindi riconoscimento dei diritti acquisiti alla pensione dagli impiegati corsi: facoltà di scelta lasciata a tutti, senza tener conto dei precedenti politici, di conservare la vecchia cittadinanza venendo considerati come stranieri o di acquistare la nuova, e nei primo caso concessione di un prolungato periodo per liquidare gli interessi preesistenti; riconoscimento dell’uso del dialetto corso nello svolgimento dei processi, come è nella pratica attuale, limitandosi a sostituire negli atti più importanti e nella formulazione delle sentenze la lingua italiana alla francese (ora usata), che così verrebbe più facilmente eliminata dalla vita côrsa, etc.
Quanto alla forma del Governo da costituire nell’isola io ritengo che si possa e si debba senza preoccupazioni accettare l’idea di un regime speciale per un periodo di transizione anche prolungato, e perciò considerare l’affiancamento autonomo all’Italia con legami e garanzie per la fusione nazionalizzatrice progressiva.
La Corsica potrà essere retta da un Viceré o da un Alto Commissario Italiano di rango elevato, con sede in Aiaccio e con pieni poteri esecutivi. Vi sarà formata un’amministrazione particolare che pur adattandosi alla legislazione Italiana lasci largo posto alle caratteristiche ed alle tradizioni letali (assemblea consultiva eletta, autonomie comunicali e cantonali. etc.).
Nel formulare tale proposizione. io penso. come esempi di tener presenti pur con opportune varianti di misura, di tempo e di forma, a tre nostre istituzioni di quest’epoca:
1) g governo animano dello Stato di Fiume dopo il 1922, dal quale è già scaturita l’unzione all’Italia;
2) il governo speciale del Dodecaneso che sotto la dipendenza dal nostro Ministero degli Esteri ha già latte un buon cammino nell’adeguamento e nell’aderenza alle leggi italiane;
3) l’unione personale e l’affiancamento del Regno dell’Albania all’Italia, che è di più recente formazione.
…
Nel regime autonomo della Corsica dovranno essere prevedute le completa unione doganale con l’Italia, la fusione delle forze annate di difesa nelle nostre, la unificatone delle relazioni internazionali, e la comunanza degli altri corpi politici consultivi e giudicanti con accesso nei loro ranghi di personalità corse.
Inoltre alcuni servizi, quali quelli ferroviari, quelli di comunicazione esterna, l’ordinamento portuale e le poste e telegrafi dovranno essere consegnati alle amministrazioni statali della penisola (che vi impiegheranno una larga percentuale di personale corso mista all’italiano), come pegno di larghi prestiti che l’Italia farà all’Amministrazione dell’isola per eseguire un programma assai esteso di lavori di pubblico interesse e di ordinamento sociale. programma de affrontare senza ritardo e con la massima energia.
Pegni per garanzia dì prestiti fatti ai Comuni potranno essere formali dalle foreste comunali, tenendo presente la necessità di ricostituire rapidamente l’antico patrimonio forestale dell’isola.
Speciali regolamenti dovranno poi essere stabiliti pia il corpo insegnante delle scuole che dovrà essere composto esclusivamente di isolani e di regnicoli; cosi per altri ruoli con funzioni amministrative e politiche e per II clero.
L’ordinamento civile potrà essere previsto su due sottogovernatorato e provincie (e pel campo religioso su due diocesi), corrispondenti alla stono divisione regionale dell’isola.
Infine per chiudere questo rapidissimo esame è opportuno accennare ad un’alba importante questione; quella della cittadinanza.
Inizialmente potrà essere considerata ma cittadinanza corsa obbligatoria che sia equivalente ed una speciale e ridotta cittadinanza Italiana e che non comporti tutti i diritti e nati i doveri di essa; ma dovrà essere preceduto l’accesso dei Côrsi agli impieghi e ai ranghi dei corpi armati e civili della penisola, con passaggio di diano alla piena cittadinanza italiana esteso alle famiglie, ciò che dovrà avvenire anche per tutte le altre cariche alle quali i Côrsi potranno essere chiamati in Italia.
Per questa via la funzione nazionalizzante avrà il suo più esteso e celere sviluppo Tale programma, qui esposto solo per sommi capi, potrebbe essere esposto in qualche autorevole rivista,, e illustrato in conferenze e in articoli della stampa quotidiana.
Da DIARIO STORICO DEL COMANDO SUPREMO VOL V TOMO 2
Autori: Biagini e Frattolillo, dal 1.9.1941 al 30.4.1941 -ALLEGATI- Edizione Ufficio Storico, 1995 (fonte)
[2] Edoardo Monti (Como, 19 luglio 1876 – 27 ottobre 1958) è stato un generale italiano.
Sottotenente di artiglieria nel 1896, frequentò la scuola di guerra e passò nel corpo di Stato Maggiore. Partecipò alla guerra libica del 1911-12 ed a tutta la guerra contro l’Austria, divenendo colonnello nel 1917. Fu successivamente Capo di Stato Maggiore del settore di Tarvisio e della divisione di Gorizia (1921), Comandante del 15º Reggimento artiglieria da campagna (1923) e poi (1926) Capo di Stato Maggiore di Corpo d’Armata di Bari. Generale di brigata nel 1928, fu ispettore di mobilitazione della divisione di Gorizia e nel 1929 passò al comando del corpo di Stato Maggiore. Con il grado di Generale di divisione comandò la 14ª Divisione fanteria “Isonzo” a Gorizia negli anni 1931-34. Trasferito a Cagliari assunse il comando del Corpo d’Armata della Sardegna con il grado di Generale di Corpo d’Armata e lo resse dal 1935 al 1936. In Bologna nel 1937 assunse il comando di quel Corpo d’Armata fino al 17 luglio 1939. Nominato designato d’Armata si trasferì a Como, sua città natale; in Milano assunse il Comando dell’Armata “S”, unità puramente cartacea, incaricata di studiare la difesa del confine settentrionale dal Monte Dolent al Cadore.
L’11 novembre 1939 trasmise allo Stato Maggiore del Regio Esercito una “Memoria operativa nell’ipotesi di violazione della neutralità svizzera da parte della Francia”. Il 15 dicembre 1939 ricevette direttamente da Mussolini l’incarico di sovrintendente alla fortificazione del “Vallo Alpino del Littorio” alla frontiera germanica; all’interno dell’Armata “S” l’ufficio preposto prese il nome di “Comando Presidio Monti”. Nel settembre 1940 il Comando venne sciolto e Monti continuò, sotto forma di consulenza, la sua collaborazione ai nuovi uffici preposti alla costruzione del “Vallo” fino al 19 luglio 1942, quando venne collocato nella riserva. Il 10 settembre del 1942 venne ricevuto a Palazzo Venezia da Mussolini il quale volle complimentarsi con lui, in modo particolare, per la condotta durante l’incarico di sovrintendente alla costruzione del Vallo Littorio alla frontiera germanica. Terminato l’importante incarico fu Presidente della Casa militare per i veterani in Turate (CO) fino alla morte. Poco dopo la fine della guerra fece parte di un giurì per indagare sulla responsabilità in ordine alla mancata difesa della piazza di Roma durante i tragici giorni susseguenti l’8 settembre 1943.
Ruolo nella realizzazione del Vallo Alpino. Prima dell’importante incarico di sovrintendente alla costruzione del Vallo Littorio alla frontiera germanica assegnatogli da Mussolini, di cui si è riferito nella biografia, il generale Monti aveva firmato in qualità di Sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito la Circolare 300, emessa il 21 gennaio 1932, con cui approvava le aggiunte e varianti alla Circolare 200 ed alla Circolare 800 compilate dall’Ispettorato dell’Arma del Genio.(fonte)
[3] Luca Montuori. – Nacque ad Avellino il 18 febbraio 1859 da Nicola e da Tommasina Soldutti, in una famiglia che non poteva vantare precedenti militari illustri. Dopo l’infanzia trascorsa in Irpinia, entrò all’Accademia di Torino il 1° ottobre 1878 e ne uscì due anni dopo sottotenente d’artiglieria.
Quale appartenente all’arma ‘dotta’ per eccellenza le strade che gli si prospettavano erano sostanzialmente due: quella di specializzarsi nell’impiego della propria arma e di transitare nel ruolo tecnico, oppure quella di entrare nello stato maggiore per cercare di segnalarsi nell’azione di comando. La prima alternativa gli consentiva una carriera sicura ma spesso ingrata e scarsa di soddisfazioni, la seconda apriva prospettive realmente interessanti solo in caso di conflitto. Montuori ebbe pochi dubbi nell’optare per quest’ultima strada. Tratto tipico della sua personalità militare furono la durezza nel comando e la severità verso se stesso e gli altri. Difficilmente discusse gli ordini ricevuti, o si permise anche solo di interpretarli, e quasi mai accettò incertezze nei suoi subordinati. Anche se difettava di originalità concettuale, non era privo di cultura e a ogni gradino importante della sua carriera si costruì una solida preparazione tecnico-professionale.
Nel 1889 entrò alla scuola di guerra, da cui passò al corpo di stato maggiore, completando la formazione come ufficiale di fanteria. In occasione dei moti di Milano del 1898, quando era maggiore, gli fu conferita una medaglia d’argento per il suo intervento contro i dimostranti. Promosso tenente colonnello nel dicembre 1901, lavorò all’Istituto geografico militare, per diventare quindi titolare di logistica alla scuola di guerra e passare poi nel 1907 a Berlino quale addetto militare. Il 3 febbraio 1907 fu promosso colonnello, restando in servizio presso il corpo di stato maggiore; solo nel 1910 assunse il comando del 50° reggimento fanteria «Parma», con cui l’anno dopo partì per la Tripolitania.
Restò in Libia anche nei due anni successivi, promosso maggior generale nel giugno 1912, meritando la croce di cavaliere dell’Ordine militare di Savoia (16 marzo 1913) per il comando della brigata mista nella battaglia di Zanzur (8 giugno 1912) e poi quella di ufficiale del medesimo ordine (28 dicembre 1913) per la battaglia di Assaba e la successiva avanzata su Nalut.
Richiamato in Italia, comandò la brigata «Pisa» e nel 1914 la III brigata alpina, per assumere all’inizio del 1915 il comando della scuola di guerra. Gli si apriva per la prima volta l’opportunità di dare un proprio indirizzo a un ente molto prestigioso, ma con una impostazione rigida e dottrinale. Tuttavia non poté nemmeno iniziare l’impresa, perché lo scoppio del conflitto lo vide subito trasferito al fronte alla testa della brigata «Parma», che guidò fino al 3 giugno 1915. I precedenti di carriera lo destinavano infatti a un comando superiore e ai primi di giugno, con la promozione a tenente generale, gli venne assegnata la 10ª divisione, impegnata in Cadore nel settore Padola-Visdende.
Mantenne tale comando fino al 1° dicembre successivo, quando assunse quello della 4ª divisione, da mesi impegnata sul Sabotino, nel tentativo di conquistare quella fortezza naturale ritenuta prendibile in poche ore alla scuola di guerra ma che dall’inizio del conflitto aveva logorato senza alcun successo molte delle migliori unità della fanteria. Il 23 maggio 1916 lasciò la divisione per assumere il comando del XX corpo d’armata, con il quale combatté per i 15 mesi successivi sull’Altopiano dei Sette Comuni. Contribuì ad arrestare l’offensiva austriaca, condusse la controffensiva e combatté nell’estate 1917 l’attacco che avrebbe dovuto ridare all’Italia la sicurezza alle spalle dell’esercito operante sull’Isonzo e che invece naufragò nel massacro dell’Ortigara.
La sua azione di comando fu contrassegnata da un notevole livello di brutalità e da un’assoluta mancanza di scrupoli. Ordini improntati alla scarsissima considerazione per la vita dei suoi subordinati provocarono infatti la morte di parecchi comandanti di brigata e innumerevoli richieste di provvedimenti di esonero. L’azione a tratti sconsiderata di siluramento dei comandanti al fronte, se ebbe in Cadorna il maggior responsabile, trovò in Montuori uno degli esecutori più zelanti, spesso anche oltre le intenzioni del capo di stato maggiore. Montuori non subì tuttavia alcuna conseguenza dalla sua azione infruttuosa, ricavandone anzi la commenda dell’Ordine militare di Savoia (28 dicembre 1916) e una seconda medaglia d’argento.
Il 23 agosto 1917 venne richiamato sul Carso al comando del II corpo d’armata, dove rimase – ferito sulla Bainsizza – fino al 12 ottobre 1917, prendendo parte alla XI battaglia dell’Isonzo. In questa data assunse il comando interinale della 2ª armata, in sostituzione del titolare Luigi Capello, costretto al ricovero ospedaliero. Nelle fasi cruciali di questo comando la sua acquiescenza agli ordini e alle illusioni di Cadorna costò alla sua unità perdite gravissime sotto il profilo numerico ed esiziali sotto quello morale. La mancata denuncia delle responsabilità di Pietro Badoglio a Caporetto gli valse poi l’appoggio del nuovo comando supremo, che lo destinò al comando della 6ª armata sull’Altopiano dei Sette Comuni. Mantenne questo incarico fino al termine della guerra e, in una zona che conosceva molto bene, sostenuto da ottimi collaboratori, combatté più che egregiamente la battaglia del Solstizio, infrangendo fin dal primo giorno ogni velleità offensiva del generale austriaco Franz Conrad. Concorse quindi all’offensiva finale, con un’azione che ebbe il merito di tagliare la via della ritirata alla maggior parte delle forze che lo fronteggiavano.
Lasciò il comando dell’armata, alle cui dipendenze aveva avuto notevoli aliquote di forze francesi e inglesi, il 1° luglio 1919 con il titolo di cavaliere di gran croce, attribuitogli il 24 maggio 1919 per l’intera azione esercitata al comando di truppe interalleate. Il clima politico del dopoguerra e gli echi di Caporetto oscurarono i successi dell’ultimo anno di guerra, provocando anche la messa a disposizione di Montuori nel 1919. L’avvento al potere del fascismo mutò decisamente la situazione e nel febbraio 1923 tornò in auge, fu promosso generale d’armata e incluso nel Consiglio d’esercito.
All’interno di questo organismo, fedele alla sua impostazione, mantenne un profilo defilato e decisamente conservatore: fu così tra gli oppositori del nuovo ordinamento destinato ad ammodernare l’esercito proposto dal generale Antonino Di Giorgio. Nei quattro anni successivi restò al comando d’armata e nel 1927 fu collocato in soprannumero. Il 12 maggio 1928, con la presentazione di Carlo Petitti di Roreto, arrivò la nomina a senatore del Regno. Sopravvisse alla fine del fascismo e al secondo conflitto mondiale senza mai assumere posizioni di rilevanza sulla scena nazionale. Aderì però alla Repubblica sociale italiana (RSI) e di conseguenza venne fatto decadere da senatore il 31 luglio 1945. Contro quest’ultimo provvedimento avanzò poi, senza successo, istanza di ricorso. Fu sposato dapprima con Annina Fano e quindi con Carlotta Margherita Beyerle. Morì a Genova l’8 marzo 1952.(fonte)
[4] Franz Conrad von Hötzendorf. Feldmaresciallo austriaco, nato l’11 novembre 1852 a Penzing presso Vienna, morto a Mergentheim il 25 agosto 1925. Nel 1906 fu nominato capo di Stato maggiore. Tedesco di stirpe, egli era prettamente austriaco per sentimento, e considerava un furto le rivendicazioni dell’Italia nel 1859 e nel 1866; e sotto lo stesso punto di vista considerava le agitazioni interne ed esterne delle varie nazionalità della duplice monarchia. Perciò egli vide l’unico mezzo di salvezza nella guerra preventiva contro l’Italia (da lui considerata come il nemico tradizionale) e contro la Serbia, sede dell’irredentismo slavo: nel 1911 il ministro Aehrenthal, in seguito a un nuovo tentativo d’indurre alla guerra contro l’Italia impegnata a Tripoli, ottenne dall’imperatore che si ponesse fine a una politica dallo stesso ministro qualificata “di banditismo”, e il C. fu allontanato dalla carica di capo di Stato maggiore; alla quale fu però richiamato dopo la morte dell’Aehrenthal (1912).
Il C., rimase spesso un solitario, chiuso nella propria superiorità intellettuale, lontano dalla realtà: fino a vedere, ad esempio, continui disegni di aggressione da parte dell’Italia, la quale invece sino a pochi anni prima della guerra mondiale non aveva avuto, verso oriente, che timidi progetti di mobilitazione a carattere difensivo.
Allo scoppiare della guerra europea egli scrisse a Cadorna che il precedente capo di Stato maggiore, Pollio, gli aveva promesso di mandare truppe in Austria: il C. stesso nelle sue memorie, minute talvolta fino al superfluo, si guarda bene dal precisare dove il Pollio avrebbe fatto simile promessa, in realtà inesistente.
Anche in guerra il C. si tenne, per abitudine, fuori del contatto con i comandi dipendenti: il generale Krauss, capo di Stato maggiore del comando della fronte verso l’Italia, durante i 27 mesi trascorsi in tale carica non vide mai il C.: così si spiega come questi non conoscesse a sufficienza né i comandi né le truppe. Tali caratteristiche negative, e i preconcetti teorici spiegano gl’insuccessi che il C. ebbe nel campo della realtà. Fu quasi sempre in disaccordo con lo Stato maggiore germanico: tipico il dissenso col Falkenhayn nel maggio 1916, contro il parere del quale attuò l’offensiva del Trentino, con grave danno per le operazioni alla fronte russa.
Dopo la morte di Francesco Giuseppe, il nuovo imperatore volle assumere personalmente la direzione delle operazioni, ma non trovò un collaboratore gradito nel C., il quale d’altra parte aveva perduto molto del suo prestigio presso l’esercito in seguito all’insuccesso dell’offensiva del giugno 1916 contro l’Italia. L’imperatore Carlo lo mandò a comandare il gruppo di armate del Tirolo. La battaglia del Piave (v.) nel giugno del 1918, nella quale il C. sperava di attuare la sua antica concezione di scendere dagli Altipiani per prendere alle spalle il grosso dell’esercito italiano, fu un disastroso insuccesso per il maresciallo. L’imperatore lo esonerò dal comando, colmandolo tuttavia di onori. Il C. si ritrasse a vita privata e negli ultimi tempi attese a scrivere le sue memorie (Aus meiner Dienstzeit), dal 1906 fino a tutto il 1914, troncate dalla sua morte. Traspare in esse il malanimo contro l’Italia, diventato nel C. una seconda natura, ma le memorie sono un documento prezioso per la nostra storia mettendo in luce i progressi del nostro esercito negli anni precedenti la guerra.
L’odio tolse al C. la serenità necessaria per apprezzare al giusto valore gli avversarî e questa fu non ultima ragione per la quale il successo raramente gli arrise. Si debbono però riconoscergli grandi doti d’intelletto, di operosità e di carattere.(fonte)
[5] Pietro Badoglio. Nacque a Grazzano Monferrato (prov. di Asti; oggi Grazzano Badoglio) il 28 sett. 1871 da Mario e
Antonietta Pittarelli, modesti proprietari di campagna. Entrato all’Accademia di artiglieria e genio di Torino, il 16 nov. 1890 fu nominato sottotenente di artiglieria. Frequentò, la Scuola di applicazione, e il 7 ag. 1892 fu promosso tenente e assegnato al 19° reggimento di artiglieria da campagna, ove restò per quasi quattro anni, prima a Livorno e successivamente a Firenze.
Nel dicembre 1895, alla notizia dell’eroico sacrificio del battaglione Toselli sull’Amba Alagi, il B. chiese di andare volontario in Africa.
Assegnato alla 6ª batteria da montagna, s’imbarcò a Napoli. A Porto Said apprese la notizia della grave rotta di Adua; ormai al gen. Baldisserra non sarebbe spettato che di coprire l’Eritrea e liberare il presidio del forte di Adigrat, che eroicamente ancora vi si sosteneva. Il 4 maggio 1896, infatti, il forte era raggiunto dal corpo di spedizione, che poi ripiegava sulla colonia e in gran parte rimpatriava. Rimasero in Africa due battaglioni e due batterie, una delle quali era la 6ª; il B. restò in Eritrea per oltre due anni nel presidio di Adi Caieh, a 2500 metri di altitudine in una zona arida e desolata, dirigendo le esercitazioni delle truppe e i lavori di fortificazione.
Tornato in Italia, nel settembre 1899 entrò nella Scuola di guerra, dove conseguì brillantemente il diploma il 23 ag. 1902. Il 13 luglio 1903 fu promosso capitano e assegnato al 12° reggimento di artiglieria da fortezza, a Capua. Frequentò però a Roma il corso di addestramento per lo Stato Maggiore, ottenendovi, il 16 nov. 1905, il diploma di idoneità. Dopo un anno di permanenza al corpo a Bari, tornò stabilmente a Roma, al ministero della Guerra, nella divisione dello Stato Maggiore, ove si rivelò ufficiale intelligente e attivo, benché alquanto duro e riservato. Collaborava intanto con articoli di organica militare alla rivista La Preparazione, diretta dal colonnello E. Barone.
Nell’ottobre 1911 il B. ricevette l’ordine di partire per la Libia, e s’imbarcò con le truppe dell’intendenza. Ai primi di novembre, dopo la rivolta araba e l’episodio di Sciara Sciàd, nuove poderose forze furono mandate a Tripoli e, ad affiancare l’opera del gen. C. Caneva, che aveva oltre al comando del corpo di spedizione anche le mansioni di governatore, giunse dall’Italia il gen. P. Frugoni, il quale chiamò il B. a far parte del suo Stato Maggiore. Essendo rientrato in Italia il capo di Stato Maggiore del corpo d’armata, il B. ne assunse le funzioni.
In questa carica contribuì notevolmente alla preparazione dell’operazione contro l’oasi di Zanzùr, a occidente di Tripoli, rimasta un pericoloso centro di forze nemiche lungo la costa, notevolmente rafforzatosi con opere semipermanenti. L’azione, ben coordinata, si risolse in un brillante successo: il B. fu promosso maggiore per merito di guerra e in seguito venne decorato di medaglia di bronzo al valor militare.
Tornato in patria, fu assegnato al 3° reggimento di artiglieria di assedio, a Roma, con il comando di un gruppo di artiglieria e una compagnia di allievi ufficiali. Il 25 febbr. 1915 venne promosso tenente colonnello di Stato Maggiore. In vista dello scoppio delle ostilità contro l’Austria, il gen. Frugoni, comandante della 2ª armata, destinata a operare sul medio e alto Isonzo, lo volle nuovamente presso di sé; ma dopo alcuni mesi il B. passava come capo di Stato Maggiore alla 4ª divisione, dislocata, agli ordini del gen. L. Montuori, nella zona di Gorizia.
Il campo trincerato austriaco constava di due parti fondamentali: la linea avanzata sulla destra dell’Isonzo, costituente la testa di ponte coi due caposaldi del Sabotino e del San Michele, e quella arretrata, appoggiata da un lato al Monte Santo e al San Gabriele, dall’altro all’Hermada. Dopo i sanguinosi e vani tentativi del ’15 sul medio e basso Isonzo, il Cadorna aveva deciso di concentrare lo sforzo contro i due pilastri del Sabotino e del San Michele, cominciando dal primo. A questo fine bisognava innanzitutto rinnovare completamente i procedimenti di attacco e sistemare le linee difensive sul Sabotino, che erano, ancora alla fine del novembre 1915, in condizioni assolutamente insufficienti per un minimo di sicurezza. Il monte era infatti preso d’infilata dalle artiglierie nemiche e già era costato molte perdite.
Nel febbraio 1916 il B. accettò l’incarico di presiedere ai lavori sul Sabotino. Questi lavori procedettero così speditamente da arrivare, con due trincee, da oltre mille metri di distanza dalle posizioni austriache, a ottanta metri, con molti camminamenti scavati nella roccia e numerose caverne. Il 10 maggio 1916 il B. era promosso colonnello e, su richiesta del gen. L. Capello, comandante del VI corpo d’armata davanti alla testa di ponte di Gorizia, nominato suo capo di Stato Maggiore. Il B. tuttavia tornava spesso a ispezionare i lavori del Sabotino. Alla fine di luglio il monte poteva essere considerato come esempio classico di fortificazione campale e di preparazione offensiva del terreno. Il 6 agosto il B. diresse l’azione di una delle due colonne di attacco che conquistarono rapidamente la cima del monte, procedendo nella loro offensiva fin quasi alla riva dell’Isonzo. Il B. tornò poi al suo posto di capo di Stato Maggiore del VI corpo e il 27 agosto fu promosso maggior generale per merito di guerra. Passò quindi al comando di artiglieria del corpo d’armata, e poi, a metà settembre, trasferito il Capello sugli Altopiani, assunse, dietro sua richiesta, il comando della brigata Cuneo, nel tormentato settore di Sober, a sud-est di Gorizia, sulla sinistra della Vertoibizza.
In vista dell’offensiva della primavera 1917 il Cadorna il 4 aprile creava il comando della “zona di Gorizia”, affidandolo al Capello, il quale tornava a volere il B. come suo capo di Stato Maggiore.
La direttrice strategica era la valle del Vippacco, ma accompagnata dal possesso delle alture di destra e di sinistra, ossia degli altopiani della Bainsizza e Ternova da un lato e dell’orlo settentrionale del Carso e dell’Hermada dall’altro. Poiché le riserve nemiche gravitavano sul Carso, compito della “zona di Gorizia” era di iniziare l’azione e cedere poi molte sue artiglierie pesanti alla 3ª armata. Per aggirare il baluardo naturale della Bainsizza prospiciente l’Isonzo, il Capello aveva pensato di forzare il fiume a nord con manovra a largo raggio, ma ritenendo poi di non disporre di forze sufficienti, limitò l’azione a un diversivo, facendo pertanto agire frontalmente le divisioni della “zona di Gorizia”. Cominciato il bombardamento il 12 maggio, parve al Capello che il comandante del II corpo non fosse abbastanza efficiente, e il 13 lo sostituì interinalmente con il B., che, maggior generale, si trovò ad avere alle sue dipendenze tre tenenti generali e un brigadiere. Il 15 maggio, dopo aspra lotta, era preso il Kuk, e si procedeva contro il Vodice. Dopo una sospensione voluta dal Cadorna per operare sul Carso, il Capello otteneva di continuare l’azione, sia pure con artiglierie diminuite, e così il 18 anche la cima del Vodice era conquistata. La “zona di Gorizia” aveva richiamato su di sé tre divisioni austriache. Cominciava allora la serie dei furibondi contrattacchi austriaci, e la battaglia assumeva un aspetto di tipo carsico, sino a che il 28 maggio il Cadorna ordinava la cessazione delle operazioni. Il 14 giugno il B. era proposto per l’avanzamento straordinario per merito di guerra e gli era confermato l’incarico del grado superiore: continuava così a restare al comando del II corpo, che, soppressa il 1° giugno la “zona di Gorizia”, tornava ad appartenere alla 2ª armata. Quale sviluppo della decima battaglia dell’Isonzo si aveva nell’agosto 1917 l’undicesima, detta della Bainsizza.
Il Capello, di sua iniziativa, fece dell’azione complementare sul rovescio di Tolmino l’operazione principale: ma proprio l’azione contro le alture di Tolmino, compiuta dalla destra del XXVII corpo, naufragava per prima, e falliva. poteva considerarsi il 21 agosto anche l’azione sul Carso. Tuttavia, al centro il XXIV corpo comandato da E. Caviglia avanzava, mentre alla sua destra il B. con le tre divisioni del II corpo vincolava più di due divisioni austriache. Ma invece di concentrare gli sforzi al centro, il Capello s’intestava contro le alture di Tolmino: esonerava il comandante del XXVII corpo e, il 22 agosto, in piena battaglia, poneva al suo posto il B., che, essendosi gli Austriaci rinforzati da quel lato, poté ottenere però solo qualche successo locale. Comunque il 23 agosto gli era confermata la promozione straordinaria per merito di guerra a tenente generale e il 14 ottobre aveva il comando effettivo del XXVII corpo d’armata che aveva finito per trovarsi a cavaliere dell’Isonzo, con tre divisioni sulla sinistra dei fiume e una, più grossa, sulla destra.
Si avvicinava intanto il turbine della grande offensiva tedesco-austriaca sull’Isonzo, in un momento di particolare stanchezza per l’esercito italiano.
Il 18 sett. 1917 il Cadorna ordinava alla 2ª e 3ª armata di concentrare ogni attività nei preparativi per la difesa ad oltranza, ma, credendo poco a una grande offensiva nemica in un settore montano con la stagione avanzata, non prendeva le misure di sua spettanza, quali la costituzione di una riserva strategica sul medio Tagliamento e l’emanazione di precise norme sulla condotta della battaglia difensiva. Lasciava perciò praticamente mano libera al Capello, che intendeva, appena arginato l’impeto nemico, sferrare una controffensiva dalla Bainsizza a continuazione dell’offensiva fallita nell’agosto. Solo il 19 ottobre, avuta piena coscienza dell’imminente offensiva nemica, il Cadorna prescriveva tassativamente la difesa ad oltranza: il provvedimento era però tardivo e l’offensiva nemica coglieva l’esercito italiano in piena crisi di schieramento, con l’artiglieria priva di una sicura dottrina difensiva. La pressione nemica si ebbe il 24 ottobre principalmente proprio all’ala sinistra del XXVII corpo d’armata, comandato dal B., e qui si verificarono le due penetrazioni decisive, quella della 12ª divisione slesiana da Tolmino fin oltre Caporetto, grazie alla quale il contiguo IV corpo fu preso alle spalle, e la penetrazione dell’Alpenkorps tedesco sulle alture fronteggianti Tolmino, per cui fu scardinato il VII corpo posto come difesa arretrata e aggirato il caposaldo italiano dello Jeza. Davanti a Tolmino mancò quasi il tiro di contropreparazione e poi quello di sbarramento. Il B. in quella triste giornata restò tagliato fuori dalle sue truppe, cercando invano di raggiungere la sede del comando della sua artiglieria, e solo alle 16 fu in grado di rendersi parzialmente conto della situazione. I suoi difensori hanno voluto vedere in lui, in seguito, soprattutto la vittima della disobbedienza del suo superiore e maestro, il Capello, che avrebbe voluto sferrare la controffensiva proprio all’estrema ala destra del corpo di B., e che era assertore del semplicistico principio del tiro di sbarramento all’ultimo momento. Sta di fatto che, a differenza degli altri generali, il B., che pure in seguito scrisse a lungo sull’opera propria in altre circostanze, sul 24 ott. 1917 nulla scrisse, né ha lasciato alcun documento, sebbene l’argomento riguardasse anche l’onore e il prestigio di vari altri generali, fra cui il suo protettore Capello, e il buon nome del soldato italiano.
A sera il B. per vie traverse si portava nella zona del Globokak, importante altura alla testata della valle dello Judrio, per la difesa della quale il Capello gli aveva già assegnato la 47ª divisione bersaglieri; intanto le divisioni del XXVII corpo rimaste oltre l’Isonzo passavano agli ordini del gen. Caviglia. Venuto l’ordine di portare la difesa su una linea che andava dal Monte Maggiore al Kuk-Vodice, anche il B. retrocedeva e con il suo corpo d’armata, ricostituito con la 47ª divisione più la brigata Taranto e alcuni battaglioni d’assalto, ebbe il compito di difendere il tratto Judrio-monte Corada. Ma il 27 ottobre sopraggiungeva l’ordine di ritirata al Tagliamento e il nemico entrava in Cividale. La divisione bersaglieri, separata dal resto, si aggregò alle truppe di Caviglia; il XXVII corpo veniva quindi ricostituito per la seconda volta, dietro il Torre, con la 13 divisione al posto della 47ª. Il 28, superata anche la debole linea dietro il Torre, gli Austriaci giungevano a Udine. Il B. con due battaglioni di arditi e poche altre truppe ripiegò a nord-ovest verso San Daniele, mentre il resto del XXVII corpo si dirigeva a ovest verso Codroipo. Con le poche forze rimastegli il B. contribuì alla difesa sul canale di Ledra e poi a quella della testa di ponte di San Daniele, assieme alla cavalleria e ai bersaglieri ciclisti, e il 30 ottobre passava dietro il Tagliamento.
L’8 novembre il Cadorna era sostituito nella carica di capo di Stato Maggiore dal gen. A. Diaz, con il gen. G. Giardino quale sottocapo, ma due giorni dopo veniva nominato un secondo sottocapo nella persona del Badoglio.
Quest’ultima nomina non destò sulle prime meraviglia: l’infelice bollettino di Cadorna dei 28 ottobre rovesciava tutta la colpa dell’improvvisa rotta sulle truppe, e il disastro nella sua stessa fulmineità e gravità non lasciò dapprima discernere le singole responsabilità. Per di più proprio il XXVII corpo, rimesso in sesto per la terza volta, non fu sciolto come tanti altri; il B. inoltre ebbe una medaglia d’argento per la difesa di San Daniele. La sua nomina si dovette a L. Bissolati, che già al tempo della conquista del Kuk e del Vodice, parlando con il direttore della Tribuna O. Malagodi, aveva definito il B. “soldato splendido, mio vecchio amico”.
Entro il triumvirato, nelle cui mani erano poste le sorti d’Italia oltreché dell’esercito, il B. si occupò con lena instancabile e in modo veramente egregio soprattutto della parte organizzativa: lavoro immane quando si pensi che l’esercito era letteralmente dimezzato e che in quattro mesi vennero ricostituite 50 brigate di fanteria e 409 batterie. A metà febbraio 1918 il Giardino lasciava il Comando supremo e unico sottocapo di Stato Maggiore restava il B., che fu veramente il braccio destro di Diaz, tanto che, quando la Commissione d’inchiesta su Caporetto chiese di averlo a disposizione, il Diaz si oppose, non volendo privarsi di un così valido collaboratore in vista della grande offensiva austriaca. Il B. seppe far tesoro dell’esperienza dolorosa dell’ottobre: ebbe parte notevole nel definire i criteri per la nuova sistemazione difensiva del terreno e per l’impiego dell’artiglieria e delle mitragliatrici nell’azione difensiva. Dopo la battaglia del Piave, veniva elevato (27 giugno 1918) al rango di comandante d’armata per merito di guerra. Anche nella preparazione della battaglia di Vittorio Veneto ebbe una parte importante. Presiedette infine la commissione d’armistizio e, di fronte ai tentativi dilatori degli Austriaci, mostrò dignitosa energia. Per la sua opera dal novembre 1917 al novembre 1918 fu creato cavaliere di gran croce dell’Ordine Militare di Savoia e il 24 febbr. 1919 venne nominato senatore.
Nel marasma del dopoguerra il B. si trovò a partecipare in primo piano alle vicende della questione adriatica. Per ordine del presidente del consiglio Nitti aveva assunto nell’estate il comando dell’8ª armata e si era trasferito a Udine; dopo l’occupazione di Fiume da parte di D’Annunzio, veniva nominato commissario straordinario nella Venezia Giulia (14 novembre). Era suo compito impedire altri pronunciamenti militari e un ulteriore inasprimento della già difficile situazione. E realmente seppe agire con tatto, valendosi dell’influenza che aveva sul poeta; ma, desiderando levarsi presto da quel ginepraio, il 24 novembre accettava la carica di capo di Stato Maggiore dell’esercito, in sostituzione di A. Diaz, ritiratosi per motivi di salute. Tre giorni prima era stato promosso generale d’esercito per merito di guerra.
Nella nuova veste dovette affrontare la grave questione del riordinamento dell’esercito secondo l’esperienza del grande conflitto e nell’ambito della nuova situazione politica: questione che suscitava dissensi profondi fra conservatori e democratici e che portò il B. ad urtarsi col ministro della Guerra I. Bonomi. Il 3 febbr. 1921 si dimetteva dall’alta carica, rimanendo soltanto membro del Consiglio dell’esercito, organo consultivo allora creato. Era inviato quindi in Romania per decorare le città di Bucarest, Jaşi e Galati, e i sovrani dello Stato amico; a fine giugno partiva per una missione negli Stati Uniti, per esprimere la riconoscenza dell’Italia verso i suoi figli in America, che tanto patriottismo avevano mostrato durante la guerra, e per far conoscere oltre Oceano il grandioso sforzo compiuto allora dal nostro paese.
Intanto il movimento fascista prendeva vigore. Dapprima il B. l’aveva guardato con una certa indulgenza, ma poi il dilagare delle violenze e la rumorosa adesione ad esso da parte di Capello l’avevano reso diffidente e quasi ostile. Alla vigilia della marcia su Roma, nell’ottobre del ’22 interpellato dal Facta, il B. dichiarò che con dieci o dodici arresti al massimo il governo avrebbe potuto stroncare tutto il movimento. Rimase quindi per oltre un anno in disparte, sino a che, alla fine del 1923, compì il primo accostamento al fascismo, accettando la carica di ambasciatore straordinario in Brasile. Restò in quella sede per un anno e mezzo, ma già nel giugno ’24, quando l’Italia fu scossa dal delitto Matteotti, egli inviava un telegramma di netta solidarietà a Mussolini. Questi, dopo essersi posto decisamente sulla via della dittatura con il discorso del 3 genn. 1925, non tardò a chiamare a sé il B. nominandolo capo di Stato Maggiore generale (4 maggio). Continuavano più che mai le polemiche sul riordinamento dell’esercito, e il compromesso tra conservatori e democratici tentato dal ministro della Guerra, gen. A. Di Giorgio, aveva suscitato un vespaio fra gli stessi militari. Mussolini, riuniti nelle sue mani i tre ministeri militari, con tre docili sottosegretari, intendeva creare le forze armate dell’Italia fascista e valersi dello stesso B. come semplice strumento. Tanto più che il 7 nov. 1925, fallito l’attentato Zaniboni con la rovina del gen. Capello, passato ormai all’antifascismo militante, il B. aveva nuovamente espresso a Mussolini la propria solidarietà.
Cominciava così il grande equivoco, destinato a protrarsi per quindici anni e in forma sempre più grave dopo il 1936, fra il B., che in fondo non era fascista, ma si considerava la più alta personalità militare italiana e, non rassegnandosi a restare in disparte, si adattava ad accomodamenti sempre meno sinceri, e Mussolini, sempre più intollerante di ogni obbiezione. Dal canto suo il re, sempre più esautorato da Mussolini, cercava di tenere il B. legato a sé.
Tra il 1926 e il 1929 si verificava un progressivo esautoramento di B. a vantaggio delle velleità militari di Mussolini, ma accompagnato da un contemporaneo crescendo di onorificenze. L’11 maggio 1926 si aveva l’”ordinamento Mussolini” dell’esercito; in compenso quindici giorni dopo il B. era creato maresciallo d’Italia. Il 6 febbraio del 1927 il capo di Stato Maggiore generale veniva ridotto come dice il decreto di nomina a consulente tecnico del Capo del Governo per quanto concerne la coordinazione e la sistemazione difensiva dello Stato e i progetti di operazione in guerra; e colle attribuzioni, in tempo di guerra, che saranno stabilite per la sua carica dal Governo”. Il 12 giugno 1928 però il re nominava il B. marchese del Sabotino. Si era intanto acuito l’attrito con il sottosegretario gen. Cavallero; alla fine di quell’anno Mussolini nominava il B. governatore della Tripolitania e Cirenaica, pur lasciandogli la carica di capo di Stato Maggiore generale, e il 6 genn. 1929, poco prima che partisse per Tripoli, il re lo creava cavaliere dell’Ordine della SS. Annunziata.
Si trattava di completare la riconquista e la sottomissione della Libia. Dopo il successo dell’azione condotta nel Fezzan dal gen. R. Graziani, fra il dicembre 1929 e il febbraio 1930, grazie soprattutto all’aviazione, il B. poteva volgere l’attenzione alla Cirenaica, ove nominava vicegovernatore lo stesso Graziani. Alla fine del 1930, con metodi durissimi, anche la Cirenaica era sottomessa e nel gennaio 1931 riconquistata l’oasi di Cufra. Il B. si dedicava quindi all’opera di riordinamento e di colonizzazione. Il 4 febbr. 1934 lasciava definitivamente la Libia.
Lasciati nel 1929 i ministeri militari, Mussolini ne riprendeva i portafogli in vista della conquista dell’Etiopia. Nel periodo 1929-33 era stata allestita una nuova aviazione e iniziato il rinnovamento del naviglio di guerra, ma l’esercito era rimasto nelle vecchie condizioni di preparazione. Gravissimo si presentava in particolare per una azione in Etiopia il problema logistico, mentre di fronte all’ostilità della Società delle Nazioni sarebbe stato necessario invece agire con grande celerità, sia per presentare il fatto compiuto, sia per non essere sorpresi dalla stagione delle piogge. Per questi motivi il B. era contrario all’impresa; seguì però tutti i preparativi e compì anche un viaggio in Eritrea. Mussolini avrebbe desiderato che l’impresa fosse attuata da un generale fascista, il quadrumviro De Bono, che in effetti il 3 ott. 1935 iniziava le ostilità con l’occupazione di Adigrat, Adua e Axum, e, dopo una necessaria sosta, Macallè (8 novembre). Ma, per il suo procedere, troppo lento agli occhi di Mussolini, fu sostituito dal Badoglio.
Questi il 30 novembre sbarcava a Massaua, trovandovi una situazione non favorevole, ad onta dello sforzo grandioso dei mesi precedenti. Mentre gli Italiani si erano spinti avanti per centinaia di chilometri, gli Abissini avevano compiuto la mobilitazione e la radunata prima del previsto e, contro le loro precedenti abitudini, prendevano l’iniziativa dell’offensiva, tendendo a tagliare la lunga linea di operazione italiana con una duplice azione sul fianco destro, l’una a raggio ristretto, l’altra ad amplissimo raggio; contemporaneamente una grossa massa avanzava frontalmente. Molto saggiamente il B., lungi dal proseguire nell’avanzata, decise di prolungare la sosta per migliorare tutta la sistemazione logistica e tattica, e chiese altre due divisioni in rinforzo alle sette già sul posto. Gliene furono mandate tre, mentre altre due divisioni rafforzavano il fronte somalo. La situazione delle forze contrapposte era pertanto ben diversa da quella del 1895-1896, allorché 20.000 Italiani fronteggiavano 100.000 Abissini: adesso di fronte ai 215-000 Abissini, con pochi cannoni e senza aviazione, l’Italia allineava 200.000 uomini con 750 cannoni, 7000 mitragliatrici e 350 aerei. L’azione abissina a largo raggio, stante l’opportuno ripiegamento del II corpo italiano fino ad Axum, si risolveva alla fine di dicembre in una puntata nel vuoto; quella a raggio più ristretto era fermata con la prima battaglia del Tembièn. Dopo tre mesi di sosta, gli Italiani, sicuri sul fianco destro, riprendevano l’offensiva: con la battaglia dell’Amba Aradam (11-15 febbr. 1936) il B., con duplice azione convergente, sostenuta validamente dall’aviazione e da opportuni concentramenti d’artiglieria, annientava la massa principale nemica, composta di 80.000 uomini, di fronte a Macallè; quindi con abili mosse combinate annientava successivamente le due masse ancora impegnate nell’azione avvolgente, mentre il 28 febbraio sulla principale direttrice di marcia occupava l’Amba Alagi. Dopo un altro periodo di sosta il B. riprendeva ad avanzare e il 31 marzo sbaragliava presso il lago Ascianghi la guardia del corpo del negus. Intanto dalla Somalia avanzava vittorioso il gen. Graziani e il negus fuggiva imbarcandosi a Gibuti. Il 5 maggio il B. entrava in Addis Abeba alla testa di una spedizione autocarrata, partita da Dessiè dodici giorni prima.
Proclamato l’impero il 9 maggio, il B. fu nominato viceré d’Etiopia e l’11 duca di Addis Abeba; ma lasciò subito il posto al gen. Graziani per rientrare in Italia e riprendere le sue funzioni di capo di Stato Maggiore generale. Roma gli conferì la cittadinanza onoraria e il partito fascista gli dette la tessera ad honorem. Nell’ottobre dello stesso 1936 il B. narrava gli avvenimenti d’Etiopia nel volume La guerra d’Etiopia, edito a Milano, che recava una prefazione di Mussolini.
Nel settembre 1937 il B. succedette a G. Marconi nella presidenza del Consiglio delle ricerche, venendo così a trovarsi a capo del Comitato nazionale per l’indipendenza economica e della Commissione per gli studi sulle materie fondamentali per la difesa. Ma le sue fortune cominciavano a declinare. Il 30 marzo 1938 Mussolini annunziava al senato che la guerra futura sarebbe stata guidata da lui solo, e poco dopo si faceva proclamare dalla Camera e dal Senato, insieme con il re, primo maresciallo dell’Impero, suscitando lo sdegno, senza conseguenze, del sovrano e del Badoglio. In realtà, Mussolini intendeva così dividere con il B. la direzione delle cose militari, lasciandogli l’alta direzione degli apprestamenti bellici e riservando per sé il supremo comando in guerra. Il compito di B. si faceva sempre più arduo: la guerra e la sistemazione d’Etiopia, la guerra di Spagna, l’occupazione dell’Albania avevano assorbito e disperso le scarse risorse; ormai la sua voce era ben poco ascoltata da Mussolini, al quale egli disse a volte la cruda verità, indulgendo altre volte a un ottimismo di maniera estremamente pericoloso.
Allo scoppio della seconda guerra mondiale il B. fu per la neutralità: il 26 maggio 1940 giunse a dichiarare a Mussolini che l’entrata in guerra sarebbe stata un suicidio, ma, tre giorni dopo, nel consiglio di guerra tenuto da Mussolini, non sollevò alcuna opposizione o riserva. Scesa in campo anche l’Italia, il B., pur nella sua alta carica, non prese parte attiva alle decisioni sulla condotta della guerra, che Mussolini, spesso senza neppure preavvisarlo, riservava a sé. Pure continuò a pazientare: anche quando Mussolini decise di invadere la Grecia, non seppe tenere un contegno deciso. Solo quando, cominciati i rovesci sul fronte greco e attaccato con virulenza da R. Farinacci su Regime Fascista, non ottenne soddisfazione, si dimise (4 dic. 1940).
Visse allora a Roma il 1941 e 1942 tenendosi appartato, ma nella primavera del 1943, in coincidenza con l’aggravarsi della situazione dell’Italia nel conflitto, cominciò a prendere contatti con elementi antifascisti e con il re, con il quale aveva avuto buoni rapporti negli anni precedenti. Non prese parte alla preparazione degli avvenimenti che portarono, il 25 luglio 1943, alla caduta di Mussolini e al suo arresto, ma i contatti con la corte, anche tramite il conte Acquarone, fecero sì che, quando si dovette cercare un militare da porre a capo del nuovo governo, la scelta cadesse su di lui, anziché sul gen. Caviglia, come era stato proposto da D. Grandi.
Il B. per il suo passato non rappresentava certo un elemento di rottura decisiva con il fascismo, ed era quindi l’uomo adatto agli scopi del sovrano, che lo poneva alla presidenza di un ministero di tecnici e di funzionari con pieni poteri e con il compito di avviare il distacco dalla Germania nazista e di cercare una via d’uscita dalla guerra. Ma il governo di B. iniziava con un tentativo di prendere tempo: nel proclama, scritto da V. E. Orlando e da B. solo sottoscritto trasmesso la sera del 26 luglio 1943, si diceva che la guerra continuava mantenendo fede alla parola data. In realtà continuare la lotta, dopo l’occupazione della Sicilia e con la disastrosa situazione dei rifornimenti, era impossibile, ma assai difficile era l’apertura di trattative con gli Anglo-Americani, molto diffidenti anche nei confronti del governo dei B., mentre assai arduo era lo sganciamento dai Tedeschi.
Il ministero di B. visse nel timore di una ripresa da parte dei fascisti, di movimenti di sinistra e di un colpo di mano tedesco: in urto con gli esponenti democratici e antifascisti, non aveva neppure il cordiale appoggio del sovrano, che, troppo compromesso con il fascismo, non aveva voluto un ministero di carattere politico ed escludeva qualsiasi concessione agli elementi di sinistra. Così, respinta da Hitler la proposta di un incontro con il re, avanzata da B., a guadagnar tempo fu volto anche il convegno di Tarvisio (7 agosto) fra i ministri degli Esteri e i capi di Stato Maggiore generale italiani e tedeschi. Persa una settimana preziosa, furono avviate le trattative con gli Anglo-Americani, prima con sondaggi per via diplomatica, poi con l’invio di un militare, il gen. G. Castellano, in Portogallo, a prendere contatto con i rappresentanti degli Stati Maggiori alleati. Non si poté ottenere nulla più che la resa incondizionata: il 1° settembre il B., insieme con il capo di Stato Maggiore Ambrosio, e il ministro degli Esteri Guariglia, accettò il gravissimo armistizio, cui dette il proprio assenso il re, e che fu firmato il 3 settembre a Cassibile, presso Siracusa.
In esso fra l’altro gli alleati si arrogavano pieno diritto di disarmo, smobilitazione e demilitarizzazione di tutte le forze militari italiane. L’articolo 12 del trattato preannunziava poi l’imposizione di altre condizioni di carattere politico, economico e finanziario. Alle rovinose clausole del “corto armistizio” si sarebbero aggiunte così quelle del “lungo armistizio”. Al Castellano era però stato letto un “promemoria aggiuntivo”, concordato fra Churchill e Roosevelt, in cui era detto: “La misura nella quale le condizioni saranno modificate in favore dell’Italia dipenderà dall’entità dell’apporto dato dal governo e dal popolo italiano alle Nazioni Unite contro la Germania durante il resto della guerra”. Gli alleati prescrivevano inoltre che il governo italiano avrebbe proclamato l’armistizio subito dopo l’annuncio datone dal gen. Eisenhower, ordinando alle forze armate e al popolo di collaborare da quel momento con gli alleati e di resistere ai Tedeschi. Il Castellano ottenne che unitamente allo sbarco principale a sud di Roma un altro ne venisse effettuato nelle vicinanze della capitale, con una divisione aviotrasportata, paracadutisti e artiglieria, ma non poté saper altro se non che sbarco e proclamazione di armistizio sarebbero avvenuti un giorno “X”. La notte sull’8 settembre due ufficiali alleati venuti a Roma per accordarsi sull’operazione di sbarco presso Roma, resisi conto del rischio che avrebbero corso le truppe alleate per l’immediata vicinanza ai campi di aviazione di potenti forze tedesche, e dell’estrema difficoltà di ricevere un valido appoggio italiano, fecero sospendere l’aviosbarco. Il B. telegrafò chiedendo inutilmente agli Anglo-Americani di rinviare di alcuni giorni la dichiarazione dell’armistizio e implicitamente l’aviosbarco e le operazioni ad esso connesse; fallito questo tentativo, la sera dell’8 settembre trasmetteva per radio la notizia dell’armistizio. All’alba del 9 settembre il B., con i ministri militari e gli Stati Maggiori, circa un centinaio di persone, seguì il re e il principe ereditario a Brindisi nel precipitoso abbandono della capitale: si trattò di ben altro che di un regolare spostamento del governo, come allora si disse, e soprattutto ciò avvenne senza che venissero lasciati ordini precisi a chi restava nella più disperata situazione a Roma stessa e in tutte le località più lontane, ove i soldati italiani erano stati mandati a combattere. Tristemente ironica potrà suonare la tarda accusa lanciata da “radio Bari” ai primi di ottobre: “A Roma sono state lasciate sei divisioni contro due germaniche. A suo tempo saranno appurate le cause della resa della capitale”. Proprio a Roma reparti dell’esercito, già messi in stato di allarme dal gen. G. Carboni la sera dell’8, ed elementi popolari, avevano tentato, nel disfacimento degli organi di governo, una generosa resistenza ai Tedeschi, primo episodio di una più grande lotta contro il nazismo. Resistenza per nulla infeconda, perché valse a trattenere 60.000 Tedeschi con 600 carri armati medi e pesanti, quando gli Anglo-Americani compivano (9-16 settembre) con circa cinque divisioni soltanto lo sbarco nel golfo di Salerno ed era provvidenziale per il gen. Clark di poter disporre dell’82ª divisione aviotrasportata.
Il 9 settembre a Roma il Comitato nazionale delle correnti antifasciste si mutava in Comitato di Liberazione Nazionale (C.L.N.) “per – chiamare si dichiarava – gli Italiani alla lotta e alla resistenza e per riconquistare all’Italia il posto che le compete nel consesso delle libere nazioni”; e tre giorni dopo si proclamava governo di fatto, espressione della volontà popolare. Il B. si trovava a Brindisi senza autorità; e più che mai diveniva pesante la sua posizione fra i sospetti degli alleati, l’ostilità degli antifascisti, e la diffidenza e scontentezza nei suoi riguardi dello stesso sovrano. Sotto un certo rispetto Churchill, con il suo discorso ai Comuni il 21 ottobre, prese le sue difese, dichiarando necessario che tutte le forze vive della nazione italiana si stringessero attorno al loro legittimo governo. Ma in realtà egli intendeva valersi, date le condizioni di confusione e di anarchia prevalenti in Italia, del re e di B. per ottenere la piena esecuzione delle clausole dell’armistizio; solo per salvare le apparenze parlava poi della necessità che venisse costituito un governo di coalizione antifascista, da mantenere sino al termine della guerra, quando il popolo italiano avrebbe deciso non già del proprio regime, ma semplicemente di un altro governo.
Intanto, nell’immane tragedia del dissolvimento dell’esercito, non poche truppe italiane in Iugoslavia, in Grecia, a Lero, a Samo, a Cefalonia, isolate e senza ordini, ancora si battevano contro i Tedeschi, fino allo sterminio, o si univano ai partigiani greci e iugoslavi; e altre combattevano in Corsica, mentre nell’Italia occupata dai Tedeschi Napoli si ribellava il 27 settembre e si andava allargando ovunque la lotta partigiana. Nel “regno del sud” mentre alcuni animosi attorno a Benedetto Croce si adoperavano per crear formazioni di volontari, il B. pensava di organizzare un piccolo corpo regolare italiano. Il 28 settembre era infatti costituito a Brindisi un raggruppamento motorizzato agli ordini del gen. Dapino, composto da due battaglioni di fanteria, uno di bersaglieri, nove batterie di artiglieria, un battaglione controcarri. Negli stessi giorni il B. era avvertito di doversi trovare a Malta, con altri suoi capi militari, il 29; ma non fu per trattare della collaborazione militare, bensì per firmare il documento previsto dall’art. 12 delle condizioni di armistizio di Cassibile.
Esso era intitolato “strumento di resa dell’Italia” e aggravava notevolmente le già durissime condizioni, ponendo a disposizione degli alleati tutti i mezzi di trasporto terrestri, acquei, aerei, tutti i mezzi di diffusione di notizie e di propaganda; sottomettendo al loro controllo la vita economica italiana e togliendo all’Italia ogni diritto a rappresentanze diplomatiche e consolari all’estero. Anche ora però una lettera di Eisenhower al B. riconosceva come molte clausole fossero ineseguibili e che tutto poteva essere modificato con l’intensificarsi della cooperazione italiana. Il B. firmò; quanto all’entrata in guerra dell’Italia, affermò di poter apprestare, appena ritirate le truppe dalla Sardegna, da otto a dieci dìvisioni, ma non si impegnò circa la dichiarazione di guerra alla Germania, poiché tali erano gli ordini del re, che si illudeva di poterla negoziare.
Tornato a Brindisi, il B. cercò di ottenere armi, trasporto in terraferma delle truppe della Sardegna, passaggio di questo territorio all’amministrazione italiana; ma il gen. Mac Farlane, capo della delegazione militare alleata, dichiarò che la guerra alla Germania era la premessa di ogni concessione alleata. Il re dovette cedere, e alla dichiarazione di guerra, comunicata l’11 ottobre via Madrid, fece seguito il riconoscimento dell’Italia quale co-belligerante. In realtà però il governo del re e di B. doveva servire quasi esclusivamente, non già a rafforzare l’azione militare italiana contro i Tedeschi, bensì a spremere dall’Italia quanto ancora fosse possibile. Dal canto suo il re, dopo aver invano preteso d’includere il gerarca fascista Dino Grandi nel ministero, si appoggiava a elementi fascisti e anche comunisti. Il B. tornava più che mai a trovarsi fra l’incudine e il martello: a Napoli nessuno voleva partecipare al suo governo, e a Roma il 16 ottobre il C.L.N. precisava il suo atteggiamento con un ordine del giorno che, fu detto, segnava “lo statuto fondamentale del C.L.N. in Italia”, ma sanciva pure il distacco dalla monarchia e dal suo governo da parte delle forze democratiche. In questa difficile situazione il B. il 24 ottobre manifestò al re con una lettera leale ed esplicita l’opportunità d’abdicare, lui e il figlio, per salvare la monarchia, creando una reggenza per il giovanissimo Vittorio Emanuele. Di eguale parere erano il conte Sforza, rimpatriato da poco dall’America, e Benedetto Croce: il re però non volle saperne, poiché riteneva che l’abdicazione avrebbe affrettato la caduta della monarchia. Intanto però la guerra assumeva, dal Volturno al Sangro, un carattere di logorio, e la liberazione di Roma appariva sempre meno prossima.
Il 16 novembre il B. annunciava il completamento del governo, formato soprattutto con sottosegretari aventi funzione di ministri: la presenza alle Finanze dell’ex ministre fascista Guido Jung sollevò specialmente contro il re, ma anche contro il B., l’indignazione generale. Il B. cercò poi di impedire che venisse autorizzato un convegno dei C.L.N. delle province dell’Italia occupata, ma il 7 genn. 1944 gli alleati, dopo varie oscillazioni, dettero il consenso ed esso venne fissato per il 28-29 gennaio a Bari. Anche la preparazione militare andava a rilento; falliva la costituzione di corpi volontari autonomi, patrocinata dal Croce, ma osteggiata dal re e dagli alleati; costoro non volevano saperne neppure di forze regolari notevoli: non più di 14.000 uomini avrebbero dovuto combattere in prima linea. Non fu concessa la costituzione di otto o dieci divisioni, e si rifiutò il concorso di tre gruppi alpini per la guerra fra le aspre montagne del Sannio: dei 300.000 uomini disponibili gli alleati si servirono solo in parte, e per lavori nelle retrovie, mentre vuotavano i magazzini superstiti per mandare armi e indumenti ai partigiani greci e jugoslavi. L’aviazione italiana, che contava ancora trecento aeroplani, si prodigò fra continui rischi, ma non ricevette il materiale necessario per il ricambio e per le riparazioni; anche l’uso della flotta fu sempre limitato e contrastato. Alla fine i 5000 uomini del gruppo motorizzato furono portati in zona di guerra; essi parteciparono a Monte Lungo, dall’8 al 16 dicembre, alla grande lotta per il forzamento della stretta di Mignano, sulla via verso Cassino, distinguendosi per valore e subendo gravissime perdite.
Il 22 genn. ’44 ebbe luogo lo sbarco alleato ad Anzio, potente diversivo che colse di sorpresa il gen. Kesselring; ma non si seppe sfruttarlo, e la liberazione di Roma restò sempre lontana. Intanto il gen. Eisenhower aveva lasciato la direzione della guerra nel Mediterraneo, e il gen. inglese Alexander, capo delle forze alleate in Italia, si mostrava ostilissimo al congresso di Bari. Una nuova soluzione del problema istituzionale, escogitata da Enrico De Nicola, e che comportava l’abbandono del potere da parte del re e la luogotenenza al figlio Umberto, fu ancora respinta da Vittorio Emanuele III. Ma al congresso di Bari si chiese all’unanimità l’abdicazione del re, si dichiarò che il governo doveva avere i pieni poteri fino all’elezione della Costituente e si elesse una giunta che prese a funzionare regolarmente. La situazione del governo di B. era quanto mai difficile: il maresciallo, premuto dal sovrano, si valeva di elementi fascisti, come l’ex generale della milizia O. Giannantoni, provocando le rimostranze degli stessi suoi sostenitori, ma nel contempo assumeva un atteggiamento contrario al re nella questione istituzionale. Il 20 febbr. 1944 Vittorio Emanuele finì con l’accettare la soluzione della luogotenenza, purché ciò avvenisse dopo la liberazione di Roma.
Intanto il B., minacciando le dimissioni, doveva sventare la minaccia della cessione di un terzo della flotta italiana all’URSS, quale compenso per l’appoggio sovietico al re e al suo governo; il 18 marzo infatti Mosca, al fine di far sentire l’influenza russa nel Mediterraneo, annunziava che avrebbe stabilito rapporti diretti con il regio governo di Badoglio. Il 27 giungeva dall’URSS Palmiro Togliatti, il quale si dichiarava pronto a entrare nel governo Badoglio, con viva soddisfazione del maresciallo. In realtà l’intervento sovietico, che sulle prime irritò quasi tutti gli antifascisti, valeva a modificare la politica degli Anglo-Americani che il 10 aprile, per bocca del generale Mac Farlane, presenti i membri nuovi e vecchi del Consiglio consultivo d’Italia, dichiaravano essere ormai indispensabile la rinuncia immediata del re alle sue prerogative e ai suoi poteri e suggerivano una luogotenenza del principe di Piemonte. Era un vero ultimatum: il re dovette cedere, salvo rinviare la trasmissione del potere al momento della liberazione di Roma.
Il B. iniziava allora le consultazioni per il nuovo ministero, che il 21 aprile era formato, con rappresentanti dei partiti – conservando solo in carica i ministri militari – e con sede a Salerno: esso s’impegnava a far eleggere a guerra finita un’assemblea costituente. In questo modo però il nuovo governo risultava più che mai legato all’Inghilterra e all’America, e faceva cadere i timori di Churchill che un governo democratico potesse richiedere una revisione o un’attenuazione delle durissime clausole del duplice armistizio. Contro la permanenza di B. al governo e contro il nuovo ministero, considerato legato a circostanze transitorie e di carattere provvisorio, si schierava il C.L.N. dell’Italia settentrionale con una mozione del 26 aprile. Invece il C.L.N. romano, nel cui seno si erano pure manifestati forti contrasti, riflesso anche dell’eccidio delle Fosse Ardeatine del 24-25 marzo, il 5 maggio stabiliva che tutti i partiti cooperassero con il governo “ai fini della guerra di liberazione nazionale”.
Ma una vera partecipazione alla guerra con forze adeguate secondo i piani di B. e del nuovo capo dello Stato Maggiore generale, maresciallo G. Messe, incontrava ancora ostacoli. Solo il 10 febbraio si ottenne che il raggruppamento motorizzato, riorganizzato dal gen. U. Utili, fosse di nuovo impiegato come unità combattente nella zona alle sorgenti del Volturno, settore relativamente secondario, dove il 18 febbraio ebbe il primo, onorevole contatto con il nemico. Spostato poi a nord di Cassino, il 31 marzo il raggruppamento conquistava monte Morrone, dopo aver preso l’antistante cima di Castelnuovo, respingendo poi con gravi perdite per l’assalitore un tentativo tedesco di riprendere monte Morrone nella notte sul 10 aprile. Il 18 aprile il raggruppamento assumeva il nome di Corpo italiano di liberazione, ed era subito ingrossato da un battaglione di fanteria di marina e dalla divisione paracadutisti Nembo, finalmente trasportata dalla Sardegna. Anche la marina e l’aviazione si prodigavano. Nella grande battaglia per la liberazione di Roma, iniziata il 12 maggio 1944, le truppe italiane, aggregate all’8ª armata, che si mosse dopo il successo della 5ª, non vennero impegnate che molto tardivamente, dietro insistenze e non poterono entrare in Roma, il 5 giugno, fra le truppe liberatrici.
Liberata Roma, Vittorio Emanuele intendeva firmare nella capitale il decreto di nomina di Umberto a luogotenente, ma la maggioranza del ministero era per la firma immediata, che fu imposta dal gen. Mac Farlane a Ravello, presso Salerno, nella villa Rufolo, nel pomeriggio del 5 giugno, presente anche il Badoglio.
Avuto dal principe Umberto l’incarico di costituire il nuovo ministero, il B. giunse a Roma con il luogotenente la mattina dell’8. Ma qui tutti i membri del C.L.N. romano, presente il gen. Mac Farlane, dichiararono necessario un governo schiettamente democratico, formato da elementi di sicura fede antifascista, e tale da poter condurre energicamente la guerra e preparare la libera consultazione popolare per la scelta della forma istituzionale, designando unanime il Bonomi quale presidente. Così il B. lasciava silenziosamente Roma la mattina del 9 giugno, invano sperando che P. Togliatti non approvasse l’operato del C.L.N. Il 10 giugno il Bonomi presentava al luogotenente la lista del nuovo ministero: gli alleati tardarono a riconoscere il fatto compiuto, e si dové attendere a Salerno il loro placet; solo il 15 luglio il nuovo ministero poteva insediarsi a Roma. Pare che il B. si adoperasse per avallare il nuovo governo presso gli alleati. Ma prima di sparire definitivamente dalla scena politica, nella speranza di cancellare la macchia della fuga di Pescara, il B. si adoperò perché venisse iniziata una severa inchiesta circa la mancata difesa di Roma, e specialmente contro il gen. Carboni che, invece, di sua iniziativa, aveva cercato di difenderla contro i Tedeschi.
Ritiratosi a vita privata, fu dichiarato decaduto da senatore il 30 marzo 1945 per l’adesione data al fascismo; due anni dopo il provvedimento era cassato dalla Corte di Cassazione. Pubblicava poi due libri di memorie: Rivelazioni su Fiume, Roma 1946, con ampia appendice di documenti, e L’Italia nella seconda guerra mondiale (Memorie e documenti), Milano 1946.
Il B. morì a Grazzano il 1° nov. 1956.(fonte)
[6] Vittorio Emanuele Orlando. – Nacque a Palermo il 19 maggio 1860, da Camillo, avvocato appartenente a una famiglia di antiche tradizioni forensi, e da Carmela Barabbino. Compiuti gli studi classici, si iscrisse alla facoltà giuridica palermitana nel 1877, nello stesso anno di Gaetano Mosca.
I giovani che arrivarono allora alle università furono i protagonisti del rinnovamento della cultura scientifica italiana, che si realizzò dopo la guerra franco-prussiana, anche con la recezione massiccia dell’influenza culturale germanica, nello sforzo di ammodernamento della vita intellettuale del paese. Oltre a Orlando, in Sicilia furono Mosca, Francesco Scaduto, Angelo Majorana e Antonio Longo i giovani giuristi che operarono per inserire completamente la cultura giuridica regionale in quella nazionale e rinnovare la stessa cultura nazionale.
Se anche la cultura regionale continuava a esprimere eminenti personalità come il filosofo Simone Corleo e grandissimi studiosi delle tradizioni popolari come Giuseppe Pitrè e Salvatore Salomone Marino, fu soprattutto la nuova apertura nazionale e internazionale della cultura isolana, specie universitaria, a segnare della propria impronta quegli anni. Arrivarono dal continente personaggi come Adolfo Holm, studioso tedesco di storia antica siciliana, chiamato da Michele Amari a coprire la cattedra di storia antica e moderna (e che guidò negli studi storici Mosca); alla cattedra di diritto costituzionale fu nominato Alessandro Paternostro, studioso anche di diritto internazionale, dal 1888 al 1892 consigliere giuridico in Giappone del ministero della Giustizia di Tokyo, avvocato, deputato, membro del ‘Comitato dei sette’ incaricato dell’inchiesta parlamentare sullo scandalo della Banca Romana; nel 1884 Giuseppe Salvioli, reduce da esperienze di studio in Germania e in Inghilterra, coprì la cattedra di storia del diritto, partecipò alla vita politica e lesse a Palermo il 9 novembre 1890 quella prolusione intitolata ai Difetti sociali del codice civile in relazione alle classi non abbienti ed operaie che si può considerare il manifesto del socialismo giuridico italiano; nel 1881 arrivò nella facoltà giuridica anche il filosofo positivista Raffaele Schiattarella, che suscitò «un vero fermento di spiriti», destinato a esercitare «un forte influsso sulla cultura dell’isola» nell’ultimo ventennio del secolo (G. Gentile, Il tramonto della cultura siciliana, Firenze 1963, pp.147 ss.).
Dunque, l’Università assunse un ruolo di punta nella modernizzazione intellettuale dell’isola, un rinnovamento che accompagnò anche lo sviluppo economico, industriale e armatoriale palermitano, in una fase di forte dinamicità dell’intera vita sociale e intellettuale siciliana, destinata poi ad arrestarsi negli anni Novanta con la repressione dei Fasci siciliani e la grande emigrazione di fine del secolo e d’inizio Novecento.
Orlando fu sin da studente fervido lettore degli scritti di Herbert Spencer e di Joseph-Ernest Renan sulla Revue philosophique e la Revue des deux Mondes e a Renan inviò il suo primo lavoro, Il Prometeo di Eschilo e il Prometeo della mitologia greca, apparso nel 1879 nella Rivista europea (pp. 475 ss.); nello stesso anno curò la rubrica economica della Rassegna palermitana, battagliando in difesa del liberismo (uno dei motivi culturali dell’intellettualità siciliana, culminato nel magistero di Francesco Ferrara), e scrisse per essa (I, pp. 161 ss.) un lungo articolo su Le condizioni finanziarie de’ nostri comuni, ove si mostrò ben addentro a problemi di finanze locali, bilanci e decentramento e buon conoscitore dei lavori di Antonio Salandra, Costantino Baer e Rudolf von Gneist; nel 1881 si cimentò, contemporaneamente, su un tema spenceriano, pubblicando l’articolo Delle forme e delle forze politiche secondo H. Spencer sulla Rivista europea (pp. 3 ss.), e su un tema già affrontato anni prima da Luigi Palma, quello de La riforma elettorale, dato quell’anno come argomento al concorso indetto dal Reale Istituto Lombardo, poi rielaborato e pubblicato in forma di monografia (Milano 1883).
Laureatosi nel 1881, nel 1882 si recò a Monaco di Baviera dove seguì i corsi tenuti da Aloys Brinz, celebre romanista civilista, uno dei più eminenti pandettisti tedeschi. Il medesimo anno ottenne la libera docenza in Diritto costituzionale all’Università di Palermo e nel 1885 vinse la cattedra di Diritto costituzionale presso l’Università di Modena.
L’incontro con Palma segnò una tappa fondamentale della sua formazione, assieme allo studio dell’opera di Johann Kaspar Bluntschli e all’insegnamento di Brinz. Nei lavori di Palma i tradizionali richiami ai rappresentanti del pensiero politico-costituzionale inglese e francese, John Stuart Mill, Benjamin Constant, Alexis de Tocqueville, spartivano il campo con quelli rivolti alla costituzionalistica liberale tedesca, Robert von Mohl, Bluntschli, Lorenz von Stein e Gneist. Ma l’apertura di Palma alla dottrina tedesca non arrivò fino a un confronto con i risultati raggiunti dalla scuola storica, dalla pandettistica e dall’introduzione del metodo giuridico nello studio del diritto pubblico a opera di Karl von Gerber e di Paul Laband. Orlando, invece, accostatosi direttamente alla pandettistica seguendo i corsi di Brinz, conosciuta l’opera della Scuola storica di Friedrich Carl von Savigny e gli scritti dell’ultima giuspubblicistica tedesca, compì il passo non compiuto da Palma e poté avviare il rinnovamento dello studio del diritto pubblico in Italia.
L’ormai avvenuto distacco da Spencer e l’adesione alla Scuola storica del diritto si manifestarono in quegli anni in due ricerche di carattere espressamente storico, Delle fratellanze artigiane in Italia (Firenze 1884) e La legislazione statutaria e i giureconsulti italiani del secolo XIV (Palermo 1884). Sempre nel 1884 si inserì nel dibattito ormai vivo intorno a La decadenza del sistema parlamentare con un articolo pubblicato sulla Rassegna di scienze sociali e politiche (II,1, pp. 589-600) scritto secondo i canoni della dottrina politico-costituzionale del tempo, aperto, al di là delle forme giuridiche, a considerare lo stato delle forze sociali e politiche. A partire proprio dalla netta separazione tra ordine giuridico e ordine politico, di lì a poco la svolta orlandiana avrebbe proposto lo studio delle forme dell’organizzazione costituzionale e amministrativa come l’oggetto esclusivo della giuspubblicistica italiana.
La vicenda iniziò con il saggio Della resistenza individuale e collettiva (Torino 1885), ripubblicato con modifiche di poco conto nel quinto volume della «Biblioteca di scienze politiche» di Attilio Brunialti come seconda parte della Teoria giuridica delle guarentigie della libertà (Torino 1890), sotto il titolo di Guarentigie costituzionali, per completare la prima dedicata alle Guarentigie giurisdizionali. Si sviluppò così quel progetto di sistemazione rigorosamente giuridica delle libertà, avviato nel saggio sulla resistenza.
Furono le nozioni del diritto e dello Stato assunti − sulle orme della Scuola storica di Savigny e nel rifiuto della concezione volontaristica e contrattualistica rousseauiana − come prodotti della storia, fatti storico-naturali, e anche la concezione gneistiana del Rechtsstaat e quella überöffentliche Rechte, svolta dai maestri dello Staatsrecht germanico a partire da Gerber, a fornire a Orlando, dal 1885 in poi, il modello statualistico teoricamente più maturo per un esame del problema della libertà «dal lato della guarentigia giuridica» dei «cittadini in rispetto all’autorità dello Stato» (p. 919 n. 2), dal lato insomma delle guarentigie giurisdizionali. Ma accanto a esse Orlando riaffermò l’esistenza anche delle guarentigie costituzionali, il loro nesso con le libertà politiche e i diritti politici in cui queste si attuano, così come il legame delle guarentigie giurisdizionali con le libertà e i diritti civili e l’indicazione della «storia costituzionale inglese» come solo «esempio mirabile del modo armonico con cui quelle due forme di libertà si sono sviluppate» (pp. 919-937).
Un altro aspetto specifico che distinse il lavoro di Orlando dalla pubblicistica antiparlamentaristica della Destra e dai giuristi tedeschi, da Gerber a Laband, a Gneist, fu la difesa scientifica del governo parlamentare, del suo carattere giuridico, lo sforzo teso a mostrare come il governo parlamentare fosse scientificamente conciliabile con il Rechtsstaat, anzi fosse il Rechtsstaat.
Non a caso, la prima applicazione concreta del metodo giuridico fu dedicata nel 1886 agli Studi giuridici sul governo parlamentare (in Diritto pubblico generale, Milano 1940, pp. 345-415), alla fondazione scientifica della natura giuridica del governo parlamentare, che postulava sia la critica al principio della divisione dei poteri (perché la specialità dello Stato costituzionale moderno riguardava piuttosto la distinzione, garantita da norme di diritto pubblico, della forma, natura ed efficacia degli atti legislativi, esecutivi e giudiziari in cui si manifestavano le singole funzioni fondamentali della sovranità); sia quella della rappresentanza politica per via di delegazione di poteri (perché il popolo non era un ‘organismo giuridico’ che potesse conferire mandati, non era persona, si personificava nello Stato), per affermare invece che la forma rappresentativa mirava solo ad assicurare l’elezione e l’esercizio del governo ai migliori, ai più capaci, e che il Gabinetto derivava il suo carattere giuridico dalla Corona: insomma, per sostenere una concezione dualistica della costituzione e della forma di governo, palesemente tributaria nei confronti della storia e del modello costituzionale inglesi, che contemperava in una forma di governo bilanciato, nel governo di gabinetto, prerogativa regia e maggioranza parlamentare.
Provata l’identità di Rechtsstaat e governo parlamentare, iniziò in quegli anni gli studi sull’altro istituto fondativo del Rechtsstaat italico, la giustizia amministrativa. Fu l’avvio di un lungo travaglio ermeneutico che approdò, in una Nota pubblicata nel 1896 nell’Archivio di diritto pubblico (VI, pp. 24-30) alla negazione del carattere giurisdizionale della IV Sezione del Consiglio di Stato all’affermazione della sua natura di semplice contenzioso amministrativo esercitato con le garanzie del contraddittorio (a integrazione della funzione garantista svolta dal giudice ordinario) e dunque al principio della non impugnabilità delle decisioni della IV Sezione dinanzi alla Cassazione di Roma. Nonostante la giurisprudenza contraria e pur prendendo poi atto dell’esplicito dettato della legge del 1907, Orlando sostenne quelle opinioni nella voce Contenzioso amministrativo (in Digesto italiano, VIII, 2, Torino 1895-98, pp. 849-947), nel saggio su La giustizia amministrativa (in Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano, III, Torino 1901, pp. 633-1165) e anche nelle edizioni dei Principii di diritto amministrativo successive alle riforme del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa del 1907.
Nel 1885 vinse il concorso per la cattedra di diritto costituzionale dell’Università di Modena e l’anno successivo di quella di Messina. I principi indicati nelle prolusioni inaugurali di Modena e di Messina furono rielaborati nella prolusione su I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico (in Diritto pubblico generale, cit., pp. 3-22), letta l’8 gennaio 1889 nell’Università di Palermo, dove il 16 dicembre dell’anno precedente era stato chiamato alla cattedra di diritto amministrativo.
La prolusione costituì il manifesto del moderno specialismo scientifico disciplinare nella giuspubblicistica italiana e «fece in questo senso epoca» per il diritto pubblico (S. Romano, Il diritto pubblico italiano, Milano 1988, p. 6 n.13). Orlando − distinti «l’ordine politico ed il giuridico», «la discussione filosofica e politica circa la natura e la convenienza» di un istituto dallo «studio giuridico di esso», e rifiutata l’aridità del «commento esegetico» − non formulò invero una compiuta trama teorica ma semplici indicazioni tecniche, propose di ricorrere alla tecnica perfezionata nella secolare elaborazione del diritto romano e di costruire il diritto pubblico come «un complesso di principi giuridici sistematicamente coordinati», a cominciare dalle idee «di personalità giuridica dello Stato», di «diritti pubblici subiettivi» e di rapporto giuridico, regolato dalla signoria della volontà dello Stato e dei soggetti individuali, a cominciare dunque dagli elementi costitutivi del soggettivismo pandettistico.
Se la prolusione di Orlando fece epoca per il diritto pubblico in Italia, più risalente e corale era stato l’inizio del rinnovamento nelle scienze del diritto romano e privato, a opera di Filippo Serafini, Vittorio Scialoja, Carlo Fadda e Paolo Emilio Bensa. Medesimi ne furono, però, gli obiettivi: la costruzione dello Stato giuridico italiano e l’affermazione in esso del ruolo di guida teorica da assegnare alla scienza giuridica universitaria nei confronti della pratica forense, amministrativa e politico-legislativa. Ed era nell’accoglimento della lezione savigniana riguardo al dualismo tra diritto e legge, tra legge e sistema che si aprivano al giurista universitario gli spazi necessari per interporsi tra il momento della statuizione e quelli dell’interpretazione e applicazione giudiziale e amministrativa; per farsi garante del controllo scientifico di legittimità dell’operato della giurisprudenza, subordinando l’applicazione della legge al suo inserimento nel sistema del diritto positivo e affidando la costruzione scientifica del sistema al concettualismo giuridico.
A sua volta, il dualismo tra diritto e legge generava nella dottrina l’ipostatizzazione dei principi e degli istituti del sistema, con il richiamo al Rudolf von Jhering del Geist des römischen Rechts, ancora rappresentante della Begriffsjurisprudenz,«l’abitudine a considerare le varie nozioni e i vari istituti giuridici, come delle entità reali, esistenti, viventi»; e pareva assicurare solidità e generalità ai concetti, sino a ricordare a Orlando il «calcolo colle idee» dei giuristi romani di leibniziana e savigniana memoria. Tra Ottocento e Novecento il paradigma pandettistico divenne così, a partire dalla scienza romanistica e da quella giuspubblicistica, lo statuto scientifico del moderno specialismo in tutte le discipline giuridiche e permise a tutti i nuovi rami della scienza giuridica la costruzione della specifica identità di propri ambiti teorici rigorosamente disciplinari. Nel diritto pubblico il giurista diventava il tecnico, lo specialista, l’elaboratore esclusivo delle forme di organizzazione e di esercizio del potere statuale. Il formalismo del sapere giuridico era in funzione del formalismo del potere statuale e Orlando, adottando il primo, legava indissolubilmente le discipline giuspubblicistiche allo Stato italiano e faceva di quest’ultimo, del polo statuale, del modello statocentrico, il loro unico oggetto teorico.
Le Università, luoghi di produzione del paradigma pandettistico, ne erano naturalmente anche luoghi privilegiati di trasmissione: «il centro motore di questo nuovo indirizzo», come aveva auspicato nella prolusione palermitana. E come Gneist aveva concluso il suo Rechtsstaat invitando i giuristi tedeschi alla ‘missione’ del Rechtsstaat germanico, Orlando concluse la prolusione palermitana indicando ai giuristi italiani nella ricostruzione scientifica del diritto pubblico italiano l’apporto che potevano dare all’edificazione dello Stato giuridico nazionale e al compimento della «meravigliosa storia del Risorgimento».
Con i Principii di diritto costituzionale (Firenze 1889), Orlando cercò di introdurre nella stessa manualistica il metodo giuridico e i concetti con esso costruiti. Era un’opera anticipatrice, ma con tutti i limiti di un tentativo di sistemazione precoce in un campo teorico ancora quasi tutto da dissodare e da trasformare con analisi particolari informate al nuovo metodo giuridico. Ne seguì quel carattere eclettico tipico «di un periodo di preparazione e transizione», come lo stesso Orlando avrebbe avvertito quindici anni dopo pubblicando la quarta edizione (Firenze 1905, p. 6).
Uno dei risultati costruttivi importanti comunque raggiunti nei Principii fu, per esempio, l’affinamento formale delle nozioni di personalità e sovranità dello Stato, già attinte dall’insegnamento di Bluntschli fin dal saggio del 1885 sulla resistenza e poi perfezionate confrontandole con l’elaborazione che avevano avuto nell’opera di Gerber. Orlando ritenne di poter precisare la nozione gerberiana per definire la sovranità «come l’affermarsi dello Stato come giuridica persona, e quindi la fonte della sua generale capacità di diritto» (p. 45), una definizione che saldava sovranità e diritto, ovvero sovranità e limite giuridico al suo esercizio, che fondava insomma lo Stato liberale di diritto come Stato a un tempo sovrano e limitato appunto dal diritto.
Ben più innovatori apparvero i Principii di diritto amministrativo (Firenze 1891), che segnarono un decisivo avanzamento del metodo, della dogmatica e della sistematica giuridica. Definivano la scienza del diritto amministrativo come «il sistema di quei principi giuridici che regolano l’attività dello Stato pel raggiungimento dei suoi fini» (p. 17) e «dalla definizione della scienza» ricavavano, «per via di deduzione, le [tre] parti costitutive di essa»: l’«organizzazione dell’amministrazione», l’«attività dell’amministrazione» e la «difesa del diritto individuale verso l’amministrazione» (p. 45). La definizione pose il ‘centro di gravitazione’ del sistema nella «nozione di attività amministrativa» (G. Miele, Contributi al diritto amministrativo, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, III [1953], p. 54), svolta dall’organizzazione amministrativa, e dunque riproduceva l’architettura concettuale pandettistica, accoglieva lo schema soggettivistico das Rechtssubject – die Rechtsgeschäfte, doppiava il dualismo privatistico tra soggetto e negozio.
Lo Stato soggetto, persona giuridica, era titolare di una peculiare capacità di agire, la sovranità, che esercitava necessariamente tramite i suoi strumenti, gli organi (Principii di diritto amministrativo, p. 46), i quali nel loro insieme formavano, accanto all’organizzazione costituzionale, l’organizzazione dell’amministrazione (cui erano dedicati i libri secondo, terzo e quarto). Oltre a compiere attività di diritto privato comune, gli organi esercitavano la sovranità nella forma di ‘atti imperativi’, che nel loro complesso costituivano l’attività dell’amministrazione (libri quinto e sesto), sicché i privati, titolari dei diritti o degli interessi che assumessero lesi dall’attività amministrativa, potevano adire gli organi della giustizia ordinaria o amministrativa, preposti alla difesa giurisdizionale contro l’azione amministrativa (libro settimo). Il principio dello Stato persona giuridica appariva, infine, un presupposto necessario delle obbligazioni dello Stato (libro ottavo) e della responsabilità dello Stato per gli atti dei suoi funzionari. Al tema della responsabilità dello Stato era dedicata negli ultimi due capitoli del libro ottavo una riflessione insieme innovativa e tradizionale, volta a soddisfare le esigenze di specialità del diritto pubblico amministrativo, ma anche a «non alterare l’unità del diritto espressa dai principi del diritto comune civilistico» (G. Cazzetta, Responsabilità aquiliana, Milano 1991, p. 502).
Nel 1891, nell’anno in cui uscirono i Principii di diritto amministrativo, Orlando fondò a Palermo l’Archivio di diritto pubblico. Nel Programma della rivista riassunse i nuovi principi metodici e teorici di diritto pubblico generale, di diritto costituzionale e amministrativo e nell’Archivio svolse in quegli anni una gran parte del lavoro di elaborazione teorica e di direzione culturale volto alla rifondazione della scienza del diritto pubblico secondo i canoni del nuovo metodo giuridico.
Nella storia della giuspubblicistica italiana, l’Archivio risultò la prima rivista programmaticamente impegnata a elaborare un’identità disciplinare specialistica per il diritto costituzionale e per quello amministrativo e a dare inizio alla formazione di una ‘scuola nazionale’ di una nuova scienza del diritto pubblico italiano intesa come scienza giuridica autonoma, articolata in una pluralità di discipline specialistiche, capace di immettere i giuristi nelle forme dello specialismo giuridico e, attraverso esse, nelle istituzioni dello Stato nazionale.
Il progetto dell’Archivio, interrotto nel 1896 (risorse per un breve periodo a Roma sotto la direzione di Orlando e Luigi Luzzatti tra il 1902 e il 1903, per riprendere le pubblicazioni nel 1909 col titolo di Rivista di diritto pubblico e della pubblica amministrazione in Italia e diventare l’organo ufficiale della giuspubblicistica italiana), venne continuato l’anno dopo con la pubblicazione, presso la Società Editrice Libraria di Milano, dei fascicoli iniziali del Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano, che, nell’arco di quasi un trentennio e con il concorso di gran parte degli amministrativisti italiani, illustrò tutte le branche del diritto amministrativo.
Nella partizione del Trattato, anticipata assieme alle teorie fondamentali nella Introduzione dell’opera e rappresentata anche in un grande prospetto grafico, Orlando riprendeva lo schema dei Principii, articolato nel dualismo soggettivistico organizzazione/attività − fedele, come abbiamo visto, al modello pandettistico soggetto/negozio − e nella distinzione dell’attività in giuridica e sociale; distribuiva la materia amministrativa in una serie di monografie, che seguivano in prevalenza un ordine espositivo, di tipo contenutistico, senza curarsi di raggruppare i diversi «istituti retti da comuni principi» in un quadro sistematico di teorie generali. Ma così operando si «contribuì in maggior copia al progresso scientifico della nostra scienza, perché, applicandosi direttamente al diritto positivo», finalmente si «ridusse nei freni della costruzione giuridica, certi gineprai di norme complessi e intricati» (M.S. Giannini, Profili storici della scienza del diritto amministrativo [1940], ora in Id., Scritti, II, Milano 2002, p. 151). Né, d’altra parte, il tentativo di inquadrare gli istituti giuridici in teorie generali fu sempre assente. Non mancarono nel Trattato monografie che miravano proprio alle «generalizzazioni e alle costruzioni sistematiche» e intendevano comporre i risultati delle indagini analitiche «in una sintesi sistematica, la teoria generale» (S. Romano, Le giurisdizioni speciali amministrative, in Primo Trattato, cit., III, pp. 507 s.).
Il grande lavoro di ‘caposcuola’, promotore e organizzatore degli studi delle nuove scienze costituzionalistica e amministrativistica italiane svolto da Orlando poté dirsi esaurito intorno al 1900, con l’inizio della sua attività politica.
Chiamato nel 1903 alla Sapienza di Roma − dove continuò l’insegnamento di Diritto pubblico interno sino al 1931, quando chiese il collocamento a riposo per evitare di prestare giuramento di fedeltà al regime fascista, per riprenderlo poi nel 1947 con la prolusione su La rivoluzione mondiale e il diritto (in Scritti giuridici varii (1941-1952), Milano 1955, pp. 373-435), letta a sessantadue anni dalla prima − i suoi interventi scientifici assunsero, prevalentemente, la forma dei lavori d’occasione e della discussione di teorie altrui, a principiare dai gran temi della natura del diritto e del rapporto tra diritto e Stato, svolti in un confronto ininterrotto con le teorie, formulate dal suo allievo Santi Romano, del diritto come istituzione e della pluralità degli ordinamenti giuridici, tra i quali, a suo avviso, lo Stato rimaneva comunque «l’organizzazione giuridica per eccellenza» (Stato e diritto [1926], in Diritto pubblico generale, cit., p. 235) e, dinanzi a «i dissidi e gli urti sociali» di partiti, sindacati e classi, il «principale presidio di […] libertà politica» (Sul concetto di Stato [1910], ibid., p. 220) e l’«organo di un interesse generale, come rappresentante di una collettività di popolo» (Lo Stato sindacale nella letteratura giuridica contemporanea [1924], ibid., p. 331).
In quel periodo il suo contributo scientifico più rilevante fu l’introduzione dell’opera di Georg Jellinek nella cultura giuridica italiana, con la traduzione e la prefazione del System der subjektiven öffentlichen Rechte nel 1912 (un libro cui si era rifatto già negli anni Novanta Romano nel saggio su La teoria dei diritti pubblici subbiettivi, in Primo trattato, cit., I, pp. 111-220) e l’accoglimento del principio dell’autolimitazione dello Stato come loro presupposto (le cui aporie gli furono però ben presenti), cui fecero seguito la traduzione e l’annotazione della Allgemeine Staatslehre tra il 1921 (G. Jellinek-V.E. Orlando, La dottrina generale dello Stato, Milano 1921) e il 1949 (La dottrina generale del diritto dello Stato, Milano 1949).
Orlando − che nel 1890 aveva sposato Ida Castellano (da cui ebbe sei figli), figlia di Ambrogio, fondatore del Lloyd Siciliano e socio dei Florio, la grande famiglia di imprenditori e armatori palermitani − iniziò l’attività politica nel 1895, quando si presentò nel collegio di Partinico contro l’uscente deputato Paolo Figlia, un vecchio parlamentare della Sinistra storica, fedelissimo sostenitore di Francesco Crispi: ottenne una buona affermazione personale ma non fu eletto. Con l’appoggio del ‘partito di Antonio di Rudinì’, fu eletto invece nel 1897, rimanendo rappresentante del collegio di Partinico sino alle dimissioni dal Parlamento, nel 1925.
Seguì la maggioranza di centro-destra nel sostegno ai governi Pelloux e Saracco, ma il 20 giugno 1901 nel discorso di approvazione del bilancio dell’Interno prese le distanze dalla Destra e, aderendo ai motivi dell’intervento di Giovanni Giolitti, auspicò la neutralità dello Stato dinanzi alle agitazioni operaie e il riconoscimento del diritto di sciopero. Chiamato da Giolitti al ministero dell’Istruzione nel 1903, vi rimase sino al 1905 e realizzò la riforma della scuola primaria: una riforma non organica, ma importante, perché estendeva l’obbligo scolastico dal nono al dodicesimo anno di età, migliorava le condizioni economiche degli insegnanti e sosteneva l’assistenza scolastica.
Con Giolitti fu di nuovo ministro, di Grazia e Giustizia dal 1907 al 1909, quando portò a compimento la riforma dell’ordinamento giudiziario che unì alle garanzie di status giuridico dei magistrati e all’istituzione del Consiglio superiore della magistratura l’avvio di un processo di burocratizzazione e il rafforzamento del ruolo interno di direzione svolto dagli alti gradi, destinato a divenire il principale canale di trasmissione dell’influenza politica sulla magistratura. Nel 1908 fu autore dello statuto giuridico degli impiegati dello Stato, basato su un sistema di tutele inderogabili dei pubblici dipendenti, che confermò nel 1919 con la legge sull’impiego privato.
Ancora ministro di Grazia e Giustizia con Salandra, dal 1914 al 1916, preparò il disegno di legge per la «difesa economica e militare dello Stato» con l’attribuzione al governo dei pieni poteri in un ampio numero di materie, e predispose l’ordinamento della legislazione di guerra. Come già nella sua precedente attività ministeriale, operò anche per il miglioramento dei rapporti tra Stato e Chiesa e, intervenuta la guerra, seppe garantire la salvaguardia delle prerogative sovrane e delle immunità diplomatiche assicurate alla S. Sede dalla legge delle guarentigie.
Questi buoni rapporti furono la premessa dei colloqui riservati a Parigi con l’inviato pontificio, monsignor Bonaventura Cerretti, tra il maggio e il giugno 1919, nei mesi della conferenza della pace, volti a predisporre una soluzione normativa del rapporto tra lo Stato italiano e la Chiesa, contatti che Orlando volle più tardi ricordare come una preparazione del Concordato del 1929 (Miei rapporti di governo con la S. Sede, Napoli 1930, 2a ed. Milano 1944, rist. Bologna 1980).
Ministro dell’Interno con Paolo Boselli dal 1916, avendo ispirata la sua azione di governo del ‘fronte interno’ al rispetto delle libertà costituzionali, venne coinvolto in un durissimo scontro con il comando supremo di Luigi Cadorna, che lo accusò di mancata repressione del disfattismo dei partiti estremi.
Fu presidente del Consiglio dal 29 ottobre 1917 al 23 giugno 1919; dai giorni della rovinosa sconfitta di Caporetto a Vittorio Veneto seppe dirigere l’enorme sforzo di resistenza militare e civile del paese, che accompagnò e sostenne con la sua efficacissima oratoria parlamentare ed eloquenza politica, una retorica patriottica culminata in memorabili discorsi parlamentari come quello del «Resistere! resistere! resistere!» del 22 dicembre 1917 o quello del «Monte Grappa, tu sei la mia patria!» del 23 febbraio 1918, che concorse a fondare ‘la leggenda del Piave’.
Alla vittoria seguirono le delusioni della Conferenza della pace a Parigi, dove sulla questione adriatica finì con esaurirsi in sei mesi di negoziati inconcludenti, tra il gennaio e il giugno 1919, l’intera attività della delegazione italiana guidata da Orlando e dal ministro degli Esteri Sidney Sonnino. Le incertezze e le divergenze della delegazione, tra il rispetto integrale del patto di Londra e la volontà di servirsene come mezzo di scambio per ottenere Fiume, le oggettive difficoltà delle rivendicazioni italiane che si scontravano con il nazionalismo slavo, la politica filoslava del presidente americano Thomas Woodrow Wilson e le chiusure francesi e inglesi, portarono all’isolamento dell’Italia, al messaggio di Wilson diretto al popolo italiano il 23 aprile e all’abbandono della conferenza da parte della delegazione italiana il giorno successivo.
Il rientro a Roma, il bagno di folla del 26 e il voto di fiducia della Camera del 29 aprile non influirono affatto sulla conferenza, che continuò senza i delegati italiani. Orlando e Sonnino rientrarono a Parigi il 7 maggio a seguito delle pressioni di Francia e Inghilterra e senza giustificazioni ufficiali. L’insuccesso diplomatico, attribuito all’indecisione e alla debolezza della linea politica di Orlando, compromise il prestigio del governo e del paese, diffuse il sentimento di un’umiliazione subita, creò il mito della ‘vittoria mutilata’ e provocò la caduta del governo il 19 giugno 1919.
Lasciato il governo, dal 1919 al 1920 Orlando fu presidente della Camera dei deputati. Di fronte alla lotta politica e sindacale del dopoguerra e alla nascita e all’affermarsi del movimento fascista, assunse, come buona parte della classe dirigente liberale, un atteggiamento favorevole a quest’ultimo, perché, come scrisse nel novembre 1922, all’indomani della marcia su Roma, in una delle sue corrispondenze inviate al giornale La Nación di Buenos Aires, riteneva il fascismo un movimento di necessaria reazione a una «profonda crisi istituzionale»: allo «stato patologico» del governo parlamentare tramutato in un «direttorio», nella «più anarchica e perniciosa forma di governo che la storia delle costituzioni conosca», in un’«assemblea di delegati dei gruppi» parlamentari e degli interessi partitici e particolaristici, in cui la legge elettorale proporzionale, invano da lui osteggiata, aveva dissolto il parlamento, infrangendo «la spirituale unità del popolo» e provocando la «permanente impotenza di costituire un forte e saldo governo» (Cianferotti, 1980, pp. 220 s.)
Sembra che la notte tra il 27 e il 28 ottobre 1922 Orlando intervenisse presso il re Vittorio Emanuele III perché non firmasse il decreto di stato d’assedio predisposto dal governo Facta per reprimere l’insurrezione fascista e opporsi alla marcia su Roma. Lo raccontano le memorie di Dino Grandi (Il mio paese, Bologna 1985, pp. 181 s.) e lo attesta una lettera autografa indirizzata a Orlando il 28 luglio 1943 dallo stesso Grandi, che ricordava «l’episodio che tutti ignorano: quando il 27 ottobre [1]922 Ella intervenne presso il Sovrano per evitare la guerra civile a seguito di una visita che allora Le feci» (Archivio centrale dello Stato, Archivio V.E. Orlando, b. 12, f. 588).
Nel 1924, dopo aver appoggiato il governo fascista e svolto un ruolo di primo piano nella stesura della nuova legge elettorale maggioritaria, la legge Acerbo (cfr. anche una lettera di Giacomo Acerbo a Orlando del 21 giugno 1923, ibid., b.1, f. 7), ed essere stato eletto nel listone nazionale, fu sorpreso dall’assassinio di Giacomo Matteotti mentre si trovava impegnato in un viaggio in Sud America. Non aderì all’Aventino ma il 22 novembre 1924, in occasione della votazione del bilancio del ministero dell’Interno, passò all’opposizione, seguendo di pochi giorni la scelta compiuta da Giolitti.
Il discorso che in quell’occasione pronunciò alla Camera risultò la confessione pubblica delle ragioni dell’abdicazione della classe dirigente liberale in favore del governo fascista. Fu il discorso «di una crisi di coscienza, che segnava la fine della «fiducia» riposta sino ad allora nel fascismo, la «fiducia» che aveva giustificato l’intera sequenza degli eventi di quegli anni in nome della legge storica della «necessità, per la salvezza del paese»: dall’«atto extra-parlamentare e […] di violenza» della marcia su Roma al voto di fiducia parlamentare per «una sanatoria […] della violenza [e] la legalizzazione della illegalità», alla «dittatura» del governo fascista (perché «non v’è incompatibilità tra dittatura e governo parlamentare», purché «la dittatura sia temporanea»), alla «cooperazione» con esso. Ma ora la «fiducia» nel governo fascista come «controrivoluzione» capace di restaurare il regime parlamentare era venuta meno, soprattutto perché «oltre» e «accanto» al governo si era imposto «un altro potere costituzionalmente indefinito e indefinibile, cioè il potere del partito politico» fascista: «questo quid, imprecisato e imprecisabile, che si chiama partito, colla sua organizzazione non statale e che può essere antistatale, il quale interviene, il quale svia l’azione dell’autorità, […] sovverte le basi del regime» parlamentare e ferisce «nella sua essenza il principio dello Stato». Nello statualismo liberale orlandiano mancava uno spazio teorico per il partito politico (che contrastava con l’«unità organica» del popolo e con l’unità e la sovranità della persona giuridica statale) e dinanzi a un partito fascista che addirittura si poneva «come un’entità accanto al governo, concorrente all’esercizio dei poteri sovrani» e annunciava così il sorgere dello Stato totalitario del Novecento, la sua «ripugnanza» era «insuperabile»» (Discorsi parlamentari di Vittorio Emanuele Orlando, IV, Roma 1965, pp. 1566-1575).
Dopo il famoso discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925, nella tornata del 16 gennaio un intervento di Orlando nella discussione sulle modifiche della legge elettorale fatto per illustrare un energico ordine del giorno recante, tra le altre, le firme di Giolitti e di Salandra, che denunciava la violazione di tutte le libertà costituzionali a causa degli «attuali metodi di governo», venne ripetutamente e aspramente interrotto da Giuseppe Bottai, Italo Balbo e dallo stesso Mussolini (Discorsi, cit., IV, pp. 1576-1584). Il 10 agosto dette le dimissioni da deputato e si ritirò dalla vita politica per le sopraffazioni e le violenze subite nelle elezioni amministrative palermitane, dove si era presentato a capo di una lista antifascista. Dopo l’abbandono dell’Università, nel 1931, si dedicò solo alla professione di avvocato e non prese più parte alla vita politica, eccetto la lettera indirizzata a Mussolini il 3 ottobre 1935 in occasione della guerra d’Etiopia, in cui offriva la sua opera «nella pura forma del servizio» alla patria.
Convocato dal re alla vigilia della caduta di Mussolini, fu autore della famosa frase «la guerra continua» (ibid., cit., IV, p. 1692; cfr. anche una minuta di lettera di Orlando a Palmiro Togliatti datata 23 giugno 1945, con annotazione autografa, «lettera progettata ma non inviata», in Archivio centrale dello Stato, Archivio V.E. Orlando, b. 24, f. 1163), ma anche radicalmente contrario alle esitazioni del re e di Pietro Badoglio che portarono al disastro dell’8 settembre. All’indomani dell’armistizio e sino alla liberazione di Roma trovò rifugio in una casa di religiosi sotto la protezione del Vaticano.
Tornato all’attività politica dopo la liberazione di Roma, nominato nel settembre 1945 alla Consulta su designazione del Partito liberale, presiedette la commissione per le modifiche al decreto luogotenenziale 25 giugno 1944 n. 151 relativo all’Assemblea costituente, stabilite dal decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946 n. 98, che sottrasse alla Costituente e affidò a un referendum popolare la decisione sulla forma istituzionale dello Stato (Repubblica o Monarchia).
Il 9 marzo 1946, come relatore sulla proposta di modifica, Orlando riprese dopo ventun anni la parola a Montecitorio in un discorso che volle intitolare «Da un’epoca ad un’altra», come testimone ed «estremo superstite» («di un’altra età, di un altro mondo, di un’altra storia») di un’epoca storica e costituzionale che si chiudeva e di un’altra che si apriva, un discorso di cui l’Assemblea deliberò l’affissione negli albi pretori dei Comuni italiani.
Eletto alla Costituente tra i candidati indipendenti proposti dalla Unione democratica nazionale, presiedette quale decano le prime due sedute dell’assemblea del 25 e 26 giugno 1946. Non fu designato a far parte della Commissione dei 75 delegata a redigere la bozza della nuova Costituzione. Su di essa intervenne in maniera radicalmente critica nel discorso del 10 marzo 1947, a cominciare dalla forma di governo, negando che quella prevista fosse una forma di governo parlamentare e che anzi, per i limiti imposti ai poteri del capo dello Stato e «per la debolezza del potere esecutivo», rischiava di mutarsi in una confusa forma di governo assembleare di giacobina memoria.
La fedeltà alle antiche convinzioni liberali, il modello storicistico di fondazione delle libertà costituzionali, l’avversione al giacobinismo politico-costituzionale risultavano perfettamente contrari ai principi e agli istituti che fondavano la legittimità stessa dell’attività costituente e della nuova Costituzione repubblicana: dalla dottrina del potere costituente al concetto di una legalità costituzionale sovraordinata alla legge ordinaria, dalla nozione di rigidità della Costituzione all’istituzione di una Corte costituzionale e alla formulazione di norme programmatiche, come quelle contenute nel titolo secondo della parte prima della Costituzione sui rapporti etico-sociali, da lui ritenute lesive della certezza del diritto e che invano tentò di far eliminare (Fioravanti, 1988, pp. 288-290; Quaglioni, 2007, pp. 421-459). I suoi pensieri e le sue idee non ebbero, insomma, «alcun peso sulle decisioni dei costituenti italiani» (C. Esposito, La dottrina del diritto e dello Stato di V. E. Orlando, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, III [1953], p. 93).
Quanto ai suoi interventi alla Costituente in materia di politica estera, furono fatalmente dominati dalla sua storia personale di ‘presidente della Vittoria’ che aveva portato al compimento dell’Unità d’Italia; ciò spiega la strenua opposizione alla ratifica del Trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, avversione giunta sino ad accusare il 30 luglio 1947 i negoziatori di abiezioni fatte per cupidigia di servilismo.
Nominato senatore di diritto in base alla terza disposizione transitoria della Costituzione, partecipò ai lavori del Senato sui maggiori temi di politica estera e interna. Si astenne nel voto di adesione al Patto Atlantico, criticò la proposta della Comunità europea di difesa (CED) e prese posizione contro la legge maggioritaria. Il suo tempo di ‘estremo superstite’ della vecchia Italia liberale era passato.
Morì a Roma il 1° dicembre 1952 dopo una breve malattia. Il 19 novembre aveva discusso la sua ultima causa di fronte alla seconda Sezione civile della Cassazione e Piero Calamandrei ebbe la ventura di essergli associato nello stesso patrocinio.(fonte)
Il Capello, di sua iniziativa, fece dell’azione complementare sul rovescio di Tolmino l’operazione principale: ma proprio l’azione contro le alture di Tolmino, compiuta dalla destra del XXVII corpo, naufragava per prima, e falliva. poteva considerarsi il 21 agosto anche l’azione sul Carso. Tuttavia, al centro il XXIV corpo comandato da E. Caviglia avanzava, mentre alla sua destra il B. con le tre divisioni del II corpo vincolava più di due divisioni austriache. Ma invece di concentrare gli sforzi al centro, il Capello s’intestava contro le alture di Tolmino: esonerava il comandante del XXVII corpo e, il 22 agosto, in piena battaglia, poneva al suo posto il B., che, essendosi gli Austriaci rinforzati da quel lato, poté ottenere però solo qualche successo locale. Comunque il 23 agosto gli era confermata la promozione straordinaria per merito di guerra a tenente generale e il 14 ottobre aveva il comando effettivo del XXVII corpo d’armata che aveva finito per trovarsi a cavaliere dell’Isonzo, con tre divisioni sulla sinistra dei fiume e una, più grossa, sulla destra.
Si avvicinava intanto il turbine della grande offensiva tedesco-austriaca sull’Isonzo, in un momento di particolare stanchezza per l’esercito italiano.
Il 18 sett. 1917 il Cadorna ordinava alla 2ª e 3ª armata di concentrare ogni attività nei preparativi per la difesa ad oltranza, ma, credendo poco a una grande offensiva nemica in un settore montano con la stagione avanzata, non prendeva le misure di sua spettanza, quali la costituzione di una riserva strategica sul medio Tagliamento e l’emanazione di precise norme sulla condotta della battaglia difensiva. Lasciava perciò praticamente mano libera al Capello, che intendeva, appena arginato l’impeto nemico, sferrare una controffensiva dalla Bainsizza a continuazione dell’offensiva fallita nell’agosto. Solo il 19 ottobre, avuta piena coscienza dell’imminente offensiva nemica, il Cadorna prescriveva tassativamente la difesa ad oltranza: il provvedimento era però tardivo e l’offensiva nemica coglieva l’esercito italiano in piena crisi di schieramento, con l’artiglieria priva di una sicura dottrina difensiva. La pressione nemica si ebbe il 24 ottobre principalmente proprio all’ala sinistra del XXVII corpo d’armata, comandato dal B., e qui si verificarono le due penetrazioni decisive, quella della 12ª divisione slesiana da Tolmino fin oltre Caporetto, grazie alla quale il contiguo IV corpo fu preso alle spalle, e la penetrazione dell’Alpenkorps tedesco sulle alture fronteggianti Tolmino, per cui fu scardinato il VII corpo posto come difesa arretrata e aggirato il caposaldo italiano dello Jeza. Davanti a Tolmino mancò quasi il tiro di contropreparazione e poi quello di sbarramento. Il B. in quella triste giornata restò tagliato fuori dalle sue truppe, cercando invano di raggiungere la sede del comando della sua artiglieria, e solo alle 16 fu in grado di rendersi parzialmente conto della situazione. I suoi difensori hanno voluto vedere in lui, in seguito, soprattutto la vittima della disobbedienza del suo superiore e maestro, il Capello, che avrebbe voluto sferrare la controffensiva proprio all’estrema ala destra del corpo di B., e che era assertore del semplicistico principio del tiro di sbarramento all’ultimo momento. Sta di fatto che, a differenza degli altri generali, il B., che pure in seguito scrisse a lungo sull’opera propria in altre circostanze, sul 24 ott. 1917 nulla scrisse, né ha lasciato alcun documento, sebbene l’argomento riguardasse anche l’onore e il prestigio di vari altri generali, fra cui il suo protettore Capello, e il buon nome del soldato italiano.
A sera il B. per vie traverse si portava nella zona del Globokak, importante altura alla testata della valle dello Judrio, per la difesa della quale il Capello gli aveva già assegnato la 47ª divisione bersaglieri; intanto le divisioni del XXVII corpo rimaste oltre l’Isonzo passavano agli ordini del gen. Caviglia. Venuto l’ordine di portare la difesa su una linea che andava dal Monte Maggiore al Kuk-Vodice, anche il B. retrocedeva e con il suo corpo d’armata, ricostituito con la 47ª divisione più la brigata Taranto e alcuni battaglioni d’assalto, ebbe il compito di difendere il tratto Judrio-monte Corada. Ma il 27 ottobre sopraggiungeva l’ordine di ritirata al Tagliamento e il nemico entrava in Cividale. La divisione bersaglieri, separata dal resto, si aggregò alle truppe di Caviglia; il XXVII corpo veniva quindi ricostituito per la seconda volta, dietro il Torre, con la 13 divisione al posto della 47ª. Il 28, superata anche la debole linea dietro il Torre, gli Austriaci giungevano a Udine. Il B. con due battaglioni di arditi e poche altre truppe ripiegò a nord-ovest verso San Daniele, mentre il resto del XXVII corpo si dirigeva a ovest verso Codroipo. Con le poche forze rimastegli il B. contribuì alla difesa sul canale di Ledra e poi a quella della testa di ponte di San Daniele, assieme alla cavalleria e ai bersaglieri ciclisti, e il 30 ottobre passava dietro il Tagliamento.
L’8 novembre il Cadorna era sostituito nella carica di capo di Stato Maggiore dal gen. A. Diaz, con il gen. G. Giardino quale sottocapo, ma due giorni dopo veniva nominato un secondo sottocapo nella persona del Badoglio.
Quest’ultima nomina non destò sulle prime meraviglia: l’infelice bollettino di Cadorna dei 28 ottobre rovesciava tutta la colpa dell’improvvisa rotta sulle truppe, e il disastro nella sua stessa fulmineità e gravità non lasciò dapprima discernere le singole responsabilità. Per di più proprio il XXVII corpo, rimesso in sesto per la terza volta, non fu sciolto come tanti altri; il B. inoltre ebbe una medaglia d’argento per la difesa di San Daniele. La sua nomina si dovette a L. Bissolati, che già al tempo della conquista del Kuk e del Vodice, parlando con il direttore della Tribuna O. Malagodi, aveva definito il B. “soldato splendido, mio vecchio amico”.
Entro il triumvirato, nelle cui mani erano poste le sorti d’Italia oltreché dell’esercito, il B. si occupò con lena instancabile e in modo veramente egregio soprattutto della parte organizzativa: lavoro immane quando si pensi che l’esercito era letteralmente dimezzato e che in quattro mesi vennero ricostituite 50 brigate di fanteria e 409 batterie. A metà febbraio 1918 il Giardino lasciava il Comando supremo e unico sottocapo di Stato Maggiore restava il B., che fu veramente il braccio destro di Diaz, tanto che, quando la Commissione d’inchiesta su Caporetto chiese di averlo a disposizione, il Diaz si oppose, non volendo privarsi di un così valido collaboratore in vista della grande offensiva austriaca. Il B. seppe far tesoro dell’esperienza dolorosa dell’ottobre: ebbe parte notevole nel definire i criteri per la nuova sistemazione difensiva del terreno e per l’impiego dell’artiglieria e delle mitragliatrici nell’azione difensiva. Dopo la battaglia del Piave, veniva elevato (27 giugno 1918) al rango di comandante d’armata per merito di guerra. Anche nella preparazione della battaglia di Vittorio Veneto ebbe una parte importante. Presiedette infine la commissione d’armistizio e, di fronte ai tentativi dilatori degli Austriaci, mostrò dignitosa energia. Per la sua opera dal novembre 1917 al novembre 1918 fu creato cavaliere di gran croce dell’Ordine Militare di Savoia e il 24 febbr. 1919 venne nominato senatore.
Nel marasma del dopoguerra il B. si trovò a partecipare in primo piano alle vicende della questione adriatica. Per ordine del presidente del consiglio Nitti aveva assunto nell’estate il comando dell’8ª armata e si era trasferito a Udine; dopo l’occupazione di Fiume da parte di D’Annunzio, veniva nominato commissario straordinario nella Venezia Giulia (14 novembre). Era suo compito impedire altri pronunciamenti militari e un ulteriore inasprimento della già difficile situazione. E realmente seppe agire con tatto, valendosi dell’influenza che aveva sul poeta; ma, desiderando levarsi presto da quel ginepraio, il 24 novembre accettava la carica di capo di Stato Maggiore dell’esercito, in sostituzione di A. Diaz, ritiratosi per motivi di salute. Tre giorni prima era stato promosso generale d’esercito per merito di guerra.
Nella nuova veste dovette affrontare la grave questione del riordinamento dell’esercito secondo l’esperienza del grande conflitto e nell’ambito della nuova situazione politica: questione che suscitava dissensi profondi fra conservatori e democratici e che portò il B. ad urtarsi col ministro della Guerra I. Bonomi. Il 3 febbr. 1921 si dimetteva dall’alta carica, rimanendo soltanto membro del Consiglio dell’esercito, organo consultivo allora creato. Era inviato quindi in Romania per decorare le città di Bucarest, Jaşi e Galati, e i sovrani dello Stato amico; a fine giugno partiva per una missione negli Stati Uniti, per esprimere la riconoscenza dell’Italia verso i suoi figli in America, che tanto patriottismo avevano mostrato durante la guerra, e per far conoscere oltre Oceano il grandioso sforzo compiuto allora dal nostro paese.
Intanto il movimento fascista prendeva vigore. Dapprima il B. l’aveva guardato con una certa indulgenza, ma poi il dilagare delle violenze e la rumorosa adesione ad esso da parte di Capello l’avevano reso diffidente e quasi ostile. Alla vigilia della marcia su Roma, nell’ottobre del ’22 interpellato dal Facta, il B. dichiarò che con dieci o dodici arresti al massimo il governo avrebbe potuto stroncare tutto il movimento. Rimase quindi per oltre un anno in disparte, sino a che, alla fine del 1923, compì il primo accostamento al fascismo, accettando la carica di ambasciatore straordinario in Brasile. Restò in quella sede per un anno e mezzo, ma già nel giugno ’24, quando l’Italia fu scossa dal delitto Matteotti, egli inviava un telegramma di netta solidarietà a Mussolini. Questi, dopo essersi posto decisamente sulla via della dittatura con il discorso del 3 genn. 1925, non tardò a chiamare a sé il B. nominandolo capo di Stato Maggiore generale (4 maggio). Continuavano più che mai le polemiche sul riordinamento dell’esercito, e il compromesso tra conservatori e democratici tentato dal ministro della Guerra, gen. A. Di Giorgio, aveva suscitato un vespaio fra gli stessi militari. Mussolini, riuniti nelle sue mani i tre ministeri militari, con tre docili sottosegretari, intendeva creare le forze armate dell’Italia fascista e valersi dello stesso B. come semplice strumento. Tanto più che il 7 nov. 1925, fallito l’attentato Zaniboni con la rovina del gen. Capello, passato ormai all’antifascismo militante, il B. aveva nuovamente espresso a Mussolini la propria solidarietà.
Cominciava così il grande equivoco, destinato a protrarsi per quindici anni e in forma sempre più grave dopo il 1936, fra il B., che in fondo non era fascista, ma si considerava la più alta personalità militare italiana e, non rassegnandosi a restare in disparte, si adattava ad accomodamenti sempre meno sinceri, e Mussolini, sempre più intollerante di ogni obbiezione. Dal canto suo il re, sempre più esautorato da Mussolini, cercava di tenere il B. legato a sé.
Tra il 1926 e il 1929 si verificava un progressivo esautoramento di B. a vantaggio delle velleità militari di Mussolini, ma accompagnato da un contemporaneo crescendo di onorificenze. L’11 maggio 1926 si aveva l’”ordinamento Mussolini” dell’esercito; in compenso quindici giorni dopo il B. era creato maresciallo d’Italia. Il 6 febbraio del 1927 il capo di Stato Maggiore generale veniva ridotto come dice il decreto di nomina a consulente tecnico del Capo del Governo per quanto concerne la coordinazione e la sistemazione difensiva dello Stato e i progetti di operazione in guerra; e colle attribuzioni, in tempo di guerra, che saranno stabilite per la sua carica dal Governo”. Il 12 giugno 1928 però il re nominava il B. marchese del Sabotino. Si era intanto acuito l’attrito con il sottosegretario gen. Cavallero; alla fine di quell’anno Mussolini nominava il B. governatore della Tripolitania e Cirenaica, pur lasciandogli la carica di capo di Stato Maggiore generale, e il 6 genn. 1929, poco prima che partisse per Tripoli, il re lo creava cavaliere dell’Ordine della SS. Annunziata.
Si trattava di completare la riconquista e la sottomissione della Libia. Dopo il successo dell’azione condotta nel Fezzan dal gen. R. Graziani, fra il dicembre 1929 e il febbraio 1930, grazie soprattutto all’aviazione, il B. poteva volgere l’attenzione alla Cirenaica, ove nominava vicegovernatore lo stesso Graziani. Alla fine del 1930, con metodi durissimi, anche la Cirenaica era sottomessa e nel gennaio 1931 riconquistata l’oasi di Cufra. Il B. si dedicava quindi all’opera di riordinamento e di colonizzazione. Il 4 febbr. 1934 lasciava definitivamente la Libia.
Lasciati nel 1929 i ministeri militari, Mussolini ne riprendeva i portafogli in vista della conquista dell’Etiopia. Nel periodo 1929-33 era stata allestita una nuova aviazione e iniziato il rinnovamento del naviglio di guerra, ma l’esercito era rimasto nelle vecchie condizioni di preparazione. Gravissimo si presentava in particolare per una azione in Etiopia il problema logistico, mentre di fronte all’ostilità della Società delle Nazioni sarebbe stato necessario invece agire con grande celerità, sia per presentare il fatto compiuto, sia per non essere sorpresi dalla stagione delle piogge. Per questi motivi il B. era contrario all’impresa; seguì però tutti i preparativi e compì anche un viaggio in Eritrea. Mussolini avrebbe desiderato che l’impresa fosse attuata da un generale fascista, il quadrumviro De Bono, che in effetti il 3 ott. 1935 iniziava le ostilità con l’occupazione di Adigrat, Adua e Axum, e, dopo una necessaria sosta, Macallè (8 novembre). Ma, per il suo procedere, troppo lento agli occhi di Mussolini, fu sostituito dal Badoglio.
Questi il 30 novembre sbarcava a Massaua, trovandovi una situazione non favorevole, ad onta dello sforzo grandioso dei mesi precedenti. Mentre gli Italiani si erano spinti avanti per centinaia di chilometri, gli Abissini avevano compiuto la mobilitazione e la radunata prima del previsto e, contro le loro precedenti abitudini, prendevano l’iniziativa dell’offensiva, tendendo a tagliare la lunga linea di operazione italiana con una duplice azione sul fianco destro, l’una a raggio ristretto, l’altra ad amplissimo raggio; contemporaneamente una grossa massa avanzava frontalmente. Molto saggiamente il B., lungi dal proseguire nell’avanzata, decise di prolungare la sosta per migliorare tutta la sistemazione logistica e tattica, e chiese altre due divisioni in rinforzo alle sette già sul posto. Gliene furono mandate tre, mentre altre due divisioni rafforzavano il fronte somalo. La situazione delle forze contrapposte era pertanto ben diversa da quella del 1895-1896, allorché 20.000 Italiani fronteggiavano 100.000 Abissini: adesso di fronte ai 215-000 Abissini, con pochi cannoni e senza aviazione, l’Italia allineava 200.000 uomini con 750 cannoni, 7000 mitragliatrici e 350 aerei. L’azione abissina a largo raggio, stante l’opportuno ripiegamento del II corpo italiano fino ad Axum, si risolveva alla fine di dicembre in una puntata nel vuoto; quella a raggio più ristretto era fermata con la prima battaglia del Tembièn. Dopo tre mesi di sosta, gli Italiani, sicuri sul fianco destro, riprendevano l’offensiva: con la battaglia dell’Amba Aradam (11-15 febbr. 1936) il B., con duplice azione convergente, sostenuta validamente dall’aviazione e da opportuni concentramenti d’artiglieria, annientava la massa principale nemica, composta di 80.000 uomini, di fronte a Macallè; quindi con abili mosse combinate annientava successivamente le due masse ancora impegnate nell’azione avvolgente, mentre il 28 febbraio sulla principale direttrice di marcia occupava l’Amba Alagi. Dopo un altro periodo di sosta il B. riprendeva ad avanzare e il 31 marzo sbaragliava presso il lago Ascianghi la guardia del corpo del negus. Intanto dalla Somalia avanzava vittorioso il gen. Graziani e il negus fuggiva imbarcandosi a Gibuti. Il 5 maggio il B. entrava in Addis Abeba alla testa di una spedizione autocarrata, partita da Dessiè dodici giorni prima.
Proclamato l’impero il 9 maggio, il B. fu nominato viceré d’Etiopia e l’11 duca di Addis Abeba; ma lasciò subito il posto al gen. Graziani per rientrare in Italia e riprendere le sue funzioni di capo di Stato Maggiore generale. Roma gli conferì la cittadinanza onoraria e il partito fascista gli dette la tessera ad honorem. Nell’ottobre dello stesso 1936 il B. narrava gli avvenimenti d’Etiopia nel volume La guerra d’Etiopia, edito a Milano, che recava una prefazione di Mussolini.
Nel settembre 1937 il B. succedette a G. Marconi nella presidenza del Consiglio delle ricerche, venendo così a trovarsi a capo del Comitato nazionale per l’indipendenza economica e della Commissione per gli studi sulle materie fondamentali per la difesa. Ma le sue fortune cominciavano a declinare. Il 30 marzo 1938 Mussolini annunziava al senato che la guerra futura sarebbe stata guidata da lui solo, e poco dopo si faceva proclamare dalla Camera e dal Senato, insieme con il re, primo maresciallo dell’Impero, suscitando lo sdegno, senza conseguenze, del sovrano e del Badoglio. In realtà, Mussolini intendeva così dividere con il B. la direzione delle cose militari, lasciandogli l’alta direzione degli apprestamenti bellici e riservando per sé il supremo comando in guerra. Il compito di B. si faceva sempre più arduo: la guerra e la sistemazione d’Etiopia, la guerra di Spagna, l’occupazione dell’Albania avevano assorbito e disperso le scarse risorse; ormai la sua voce era ben poco ascoltata da Mussolini, al quale egli disse a volte la cruda verità, indulgendo altre volte a un ottimismo di maniera estremamente pericoloso.
Allo scoppio della seconda guerra mondiale il B. fu per la neutralità: il 26 maggio 1940 giunse a dichiarare a Mussolini che l’entrata in guerra sarebbe stata un suicidio, ma, tre giorni dopo, nel consiglio di guerra tenuto da Mussolini, non sollevò alcuna opposizione o riserva. Scesa in campo anche l’Italia, il B., pur nella sua alta carica, non prese parte attiva alle decisioni sulla condotta della guerra, che Mussolini, spesso senza neppure preavvisarlo, riservava a sé. Pure continuò a pazientare: anche quando Mussolini decise di invadere la Grecia, non seppe tenere un contegno deciso. Solo quando, cominciati i rovesci sul fronte greco e attaccato con virulenza da R. Farinacci su Regime Fascista, non ottenne soddisfazione, si dimise (4 dic. 1940).
Visse allora a Roma il 1941 e 1942 tenendosi appartato, ma nella primavera del 1943, in coincidenza con l’aggravarsi della situazione dell’Italia nel conflitto, cominciò a prendere contatti con elementi antifascisti e con il re, con il quale aveva avuto buoni rapporti negli anni precedenti. Non prese parte alla preparazione degli avvenimenti che portarono, il 25 luglio 1943, alla caduta di Mussolini e al suo arresto, ma i contatti con la corte, anche tramite il conte Acquarone, fecero sì che, quando si dovette cercare un militare da porre a capo del nuovo governo, la scelta cadesse su di lui, anziché sul gen. Caviglia, come era stato proposto da D. Grandi.
Il B. per il suo passato non rappresentava certo un elemento di rottura decisiva con il fascismo, ed era quindi l’uomo adatto agli scopi del sovrano, che lo poneva alla presidenza di un ministero di tecnici e di funzionari con pieni poteri e con il compito di avviare il distacco dalla Germania nazista e di cercare una via d’uscita dalla guerra. Ma il governo di B. iniziava con un tentativo di prendere tempo: nel proclama, scritto da V. E. Orlando e da B. solo sottoscritto trasmesso la sera del 26 luglio 1943, si diceva che la guerra continuava mantenendo fede alla parola data. In realtà continuare la lotta, dopo l’occupazione della Sicilia e con la disastrosa situazione dei rifornimenti, era impossibile, ma assai difficile era l’apertura di trattative con gli Anglo-Americani, molto diffidenti anche nei confronti del governo dei B., mentre assai arduo era lo sganciamento dai Tedeschi.
Il ministero di B. visse nel timore di una ripresa da parte dei fascisti, di movimenti di sinistra e di un colpo di mano tedesco: in urto con gli esponenti democratici e antifascisti, non aveva neppure il cordiale appoggio del sovrano, che, troppo compromesso con il fascismo, non aveva voluto un ministero di carattere politico ed escludeva qualsiasi concessione agli elementi di sinistra. Così, respinta da Hitler la proposta di un incontro con il re, avanzata da B., a guadagnar tempo fu volto anche il convegno di Tarvisio (7 agosto) fra i ministri degli Esteri e i capi di Stato Maggiore generale italiani e tedeschi. Persa una settimana preziosa, furono avviate le trattative con gli Anglo-Americani, prima con sondaggi per via diplomatica, poi con l’invio di un militare, il gen. G. Castellano, in Portogallo, a prendere contatto con i rappresentanti degli Stati Maggiori alleati. Non si poté ottenere nulla più che la resa incondizionata: il 1° settembre il B., insieme con il capo di Stato Maggiore Ambrosio, e il ministro degli Esteri Guariglia, accettò il gravissimo armistizio, cui dette il proprio assenso il re, e che fu firmato il 3 settembre a Cassibile, presso Siracusa.
In esso fra l’altro gli alleati si arrogavano pieno diritto di disarmo, smobilitazione e demilitarizzazione di tutte le forze militari italiane. L’articolo 12 del trattato preannunziava poi l’imposizione di altre condizioni di carattere politico, economico e finanziario. Alle rovinose clausole del “corto armistizio” si sarebbero aggiunte così quelle del “lungo armistizio”. Al Castellano era però stato letto un “promemoria aggiuntivo”, concordato fra Churchill e Roosevelt, in cui era detto: “La misura nella quale le condizioni saranno modificate in favore dell’Italia dipenderà dall’entità dell’apporto dato dal governo e dal popolo italiano alle Nazioni Unite contro la Germania durante il resto della guerra”. Gli alleati prescrivevano inoltre che il governo italiano avrebbe proclamato l’armistizio subito dopo l’annuncio datone dal gen. Eisenhower, ordinando alle forze armate e al popolo di collaborare da quel momento con gli alleati e di resistere ai Tedeschi. Il Castellano ottenne che unitamente allo sbarco principale a sud di Roma un altro ne venisse effettuato nelle vicinanze della capitale, con una divisione aviotrasportata, paracadutisti e artiglieria, ma non poté saper altro se non che sbarco e proclamazione di armistizio sarebbero avvenuti un giorno “X”. La notte sull’8 settembre due ufficiali alleati venuti a Roma per accordarsi sull’operazione di sbarco presso Roma, resisi conto del rischio che avrebbero corso le truppe alleate per l’immediata vicinanza ai campi di aviazione di potenti forze tedesche, e dell’estrema difficoltà di ricevere un valido appoggio italiano, fecero sospendere l’aviosbarco. Il B. telegrafò chiedendo inutilmente agli Anglo-Americani di rinviare di alcuni giorni la dichiarazione dell’armistizio e implicitamente l’aviosbarco e le operazioni ad esso connesse; fallito questo tentativo, la sera dell’8 settembre trasmetteva per radio la notizia dell’armistizio. All’alba del 9 settembre il B., con i ministri militari e gli Stati Maggiori, circa un centinaio di persone, seguì il re e il principe ereditario a Brindisi nel precipitoso abbandono della capitale: si trattò di ben altro che di un regolare spostamento del governo, come allora si disse, e soprattutto ciò avvenne senza che venissero lasciati ordini precisi a chi restava nella più disperata situazione a Roma stessa e in tutte le località più lontane, ove i soldati italiani erano stati mandati a combattere. Tristemente ironica potrà suonare la tarda accusa lanciata da “radio Bari” ai primi di ottobre: “A Roma sono state lasciate sei divisioni contro due germaniche. A suo tempo saranno appurate le cause della resa della capitale”. Proprio a Roma reparti dell’esercito, già messi in stato di allarme dal gen. G. Carboni la sera dell’8, ed elementi popolari, avevano tentato, nel disfacimento degli organi di governo, una generosa resistenza ai Tedeschi, primo episodio di una più grande lotta contro il nazismo. Resistenza per nulla infeconda, perché valse a trattenere 60.000 Tedeschi con 600 carri armati medi e pesanti, quando gli Anglo-Americani compivano (9-16 settembre) con circa cinque divisioni soltanto lo sbarco nel golfo di Salerno ed era provvidenziale per il gen. Clark di poter disporre dell’82ª divisione aviotrasportata.
Il 9 settembre a Roma il Comitato nazionale delle correnti antifasciste si mutava in Comitato di Liberazione Nazionale (C.L.N.) “per – chiamare si dichiarava – gli Italiani alla lotta e alla resistenza e per riconquistare all’Italia il posto che le compete nel consesso delle libere nazioni”; e tre giorni dopo si proclamava governo di fatto, espressione della volontà popolare. Il B. si trovava a Brindisi senza autorità; e più che mai diveniva pesante la sua posizione fra i sospetti degli alleati, l’ostilità degli antifascisti, e la diffidenza e scontentezza nei suoi riguardi dello stesso sovrano. Sotto un certo rispetto Churchill, con il suo discorso ai Comuni il 21 ottobre, prese le sue difese, dichiarando necessario che tutte le forze vive della nazione italiana si stringessero attorno al loro legittimo governo. Ma in realtà egli intendeva valersi, date le condizioni di confusione e di anarchia prevalenti in Italia, del re e di B. per ottenere la piena esecuzione delle clausole dell’armistizio; solo per salvare le apparenze parlava poi della necessità che venisse costituito un governo di coalizione antifascista, da mantenere sino al termine della guerra, quando il popolo italiano avrebbe deciso non già del proprio regime, ma semplicemente di un altro governo.
Intanto, nell’immane tragedia del dissolvimento dell’esercito, non poche truppe italiane in Iugoslavia, in Grecia, a Lero, a Samo, a Cefalonia, isolate e senza ordini, ancora si battevano contro i Tedeschi, fino allo sterminio, o si univano ai partigiani greci e iugoslavi; e altre combattevano in Corsica, mentre nell’Italia occupata dai Tedeschi Napoli si ribellava il 27 settembre e si andava allargando ovunque la lotta partigiana. Nel “regno del sud” mentre alcuni animosi attorno a Benedetto Croce si adoperavano per crear formazioni di volontari, il B. pensava di organizzare un piccolo corpo regolare italiano. Il 28 settembre era infatti costituito a Brindisi un raggruppamento motorizzato agli ordini del gen. Dapino, composto da due battaglioni di fanteria, uno di bersaglieri, nove batterie di artiglieria, un battaglione controcarri. Negli stessi giorni il B. era avvertito di doversi trovare a Malta, con altri suoi capi militari, il 29; ma non fu per trattare della collaborazione militare, bensì per firmare il documento previsto dall’art. 12 delle condizioni di armistizio di Cassibile.
Esso era intitolato “strumento di resa dell’Italia” e aggravava notevolmente le già durissime condizioni, ponendo a disposizione degli alleati tutti i mezzi di trasporto terrestri, acquei, aerei, tutti i mezzi di diffusione di notizie e di propaganda; sottomettendo al loro controllo la vita economica italiana e togliendo all’Italia ogni diritto a rappresentanze diplomatiche e consolari all’estero. Anche ora però una lettera di Eisenhower al B. riconosceva come molte clausole fossero ineseguibili e che tutto poteva essere modificato con l’intensificarsi della cooperazione italiana. Il B. firmò; quanto all’entrata in guerra dell’Italia, affermò di poter apprestare, appena ritirate le truppe dalla Sardegna, da otto a dieci dìvisioni, ma non si impegnò circa la dichiarazione di guerra alla Germania, poiché tali erano gli ordini del re, che si illudeva di poterla negoziare.
Tornato a Brindisi, il B. cercò di ottenere armi, trasporto in terraferma delle truppe della Sardegna, passaggio di questo territorio all’amministrazione italiana; ma il gen. Mac Farlane, capo della delegazione militare alleata, dichiarò che la guerra alla Germania era la premessa di ogni concessione alleata. Il re dovette cedere, e alla dichiarazione di guerra, comunicata l’11 ottobre via Madrid, fece seguito il riconoscimento dell’Italia quale co-belligerante. In realtà però il governo del re e di B. doveva servire quasi esclusivamente, non già a rafforzare l’azione militare italiana contro i Tedeschi, bensì a spremere dall’Italia quanto ancora fosse possibile. Dal canto suo il re, dopo aver invano preteso d’includere il gerarca fascista Dino Grandi nel ministero, si appoggiava a elementi fascisti e anche comunisti. Il B. tornava più che mai a trovarsi fra l’incudine e il martello: a Napoli nessuno voleva partecipare al suo governo, e a Roma il 16 ottobre il C.L.N. precisava il suo atteggiamento con un ordine del giorno che, fu detto, segnava “lo statuto fondamentale del C.L.N. in Italia”, ma sanciva pure il distacco dalla monarchia e dal suo governo da parte delle forze democratiche. In questa difficile situazione il B. il 24 ottobre manifestò al re con una lettera leale ed esplicita l’opportunità d’abdicare, lui e il figlio, per salvare la monarchia, creando una reggenza per il giovanissimo Vittorio Emanuele. Di eguale parere erano il conte Sforza, rimpatriato da poco dall’America, e Benedetto Croce: il re però non volle saperne, poiché riteneva che l’abdicazione avrebbe affrettato la caduta della monarchia. Intanto però la guerra assumeva, dal Volturno al Sangro, un carattere di logorio, e la liberazione di Roma appariva sempre meno prossima.
Il 16 novembre il B. annunciava il completamento del governo, formato soprattutto con sottosegretari aventi funzione di ministri: la presenza alle Finanze dell’ex ministre fascista Guido Jung sollevò specialmente contro il re, ma anche contro il B., l’indignazione generale. Il B. cercò poi di impedire che venisse autorizzato un convegno dei C.L.N. delle province dell’Italia occupata, ma il 7 genn. 1944 gli alleati, dopo varie oscillazioni, dettero il consenso ed esso venne fissato per il 28-29 gennaio a Bari. Anche la preparazione militare andava a rilento; falliva la costituzione di corpi volontari autonomi, patrocinata dal Croce, ma osteggiata dal re e dagli alleati; costoro non volevano saperne neppure di forze regolari notevoli: non più di 14.000 uomini avrebbero dovuto combattere in prima linea. Non fu concessa la costituzione di otto o dieci divisioni, e si rifiutò il concorso di tre gruppi alpini per la guerra fra le aspre montagne del Sannio: dei 300.000 uomini disponibili gli alleati si servirono solo in parte, e per lavori nelle retrovie, mentre vuotavano i magazzini superstiti per mandare armi e indumenti ai partigiani greci e jugoslavi. L’aviazione italiana, che contava ancora trecento aeroplani, si prodigò fra continui rischi, ma non ricevette il materiale necessario per il ricambio e per le riparazioni; anche l’uso della flotta fu sempre limitato e contrastato. Alla fine i 5000 uomini del gruppo motorizzato furono portati in zona di guerra; essi parteciparono a Monte Lungo, dall’8 al 16 dicembre, alla grande lotta per il forzamento della stretta di Mignano, sulla via verso Cassino, distinguendosi per valore e subendo gravissime perdite.
Il 22 genn. ’44 ebbe luogo lo sbarco alleato ad Anzio, potente diversivo che colse di sorpresa il gen. Kesselring; ma non si seppe sfruttarlo, e la liberazione di Roma restò sempre lontana. Intanto il gen. Eisenhower aveva lasciato la direzione della guerra nel Mediterraneo, e il gen. inglese Alexander, capo delle forze alleate in Italia, si mostrava ostilissimo al congresso di Bari. Una nuova soluzione del problema istituzionale, escogitata da Enrico De Nicola, e che comportava l’abbandono del potere da parte del re e la luogotenenza al figlio Umberto, fu ancora respinta da Vittorio Emanuele III. Ma al congresso di Bari si chiese all’unanimità l’abdicazione del re, si dichiarò che il governo doveva avere i pieni poteri fino all’elezione della Costituente e si elesse una giunta che prese a funzionare regolarmente. La situazione del governo di B. era quanto mai difficile: il maresciallo, premuto dal sovrano, si valeva di elementi fascisti, come l’ex generale della milizia O. Giannantoni, provocando le rimostranze degli stessi suoi sostenitori, ma nel contempo assumeva un atteggiamento contrario al re nella questione istituzionale. Il 20 febbr. 1944 Vittorio Emanuele finì con l’accettare la soluzione della luogotenenza, purché ciò avvenisse dopo la liberazione di Roma.
Intanto il B., minacciando le dimissioni, doveva sventare la minaccia della cessione di un terzo della flotta italiana all’URSS, quale compenso per l’appoggio sovietico al re e al suo governo; il 18 marzo infatti Mosca, al fine di far sentire l’influenza russa nel Mediterraneo, annunziava che avrebbe stabilito rapporti diretti con il regio governo di Badoglio. Il 27 giungeva dall’URSS Palmiro Togliatti, il quale si dichiarava pronto a entrare nel governo Badoglio, con viva soddisfazione del maresciallo. In realtà l’intervento sovietico, che sulle prime irritò quasi tutti gli antifascisti, valeva a modificare la politica degli Anglo-Americani che il 10 aprile, per bocca del generale Mac Farlane, presenti i membri nuovi e vecchi del Consiglio consultivo d’Italia, dichiaravano essere ormai indispensabile la rinuncia immediata del re alle sue prerogative e ai suoi poteri e suggerivano una luogotenenza del principe di Piemonte. Era un vero ultimatum: il re dovette cedere, salvo rinviare la trasmissione del potere al momento della liberazione di Roma.
Il B. iniziava allora le consultazioni per il nuovo ministero, che il 21 aprile era formato, con rappresentanti dei partiti – conservando solo in carica i ministri militari – e con sede a Salerno: esso s’impegnava a far eleggere a guerra finita un’assemblea costituente. In questo modo però il nuovo governo risultava più che mai legato all’Inghilterra e all’America, e faceva cadere i timori di Churchill che un governo democratico potesse richiedere una revisione o un’attenuazione delle durissime clausole del duplice armistizio. Contro la permanenza di B. al governo e contro il nuovo ministero, considerato legato a circostanze transitorie e di carattere provvisorio, si schierava il C.L.N. dell’Italia settentrionale con una mozione del 26 aprile. Invece il C.L.N. romano, nel cui seno si erano pure manifestati forti contrasti, riflesso anche dell’eccidio delle Fosse Ardeatine del 24-25 marzo, il 5 maggio stabiliva che tutti i partiti cooperassero con il governo “ai fini della guerra di liberazione nazionale”.
Ma una vera partecipazione alla guerra con forze adeguate secondo i piani di B. e del nuovo capo dello Stato Maggiore generale, maresciallo G. Messe, incontrava ancora ostacoli. Solo il 10 febbraio si ottenne che il raggruppamento motorizzato, riorganizzato dal gen. U. Utili, fosse di nuovo impiegato come unità combattente nella zona alle sorgenti del Volturno, settore relativamente secondario, dove il 18 febbraio ebbe il primo, onorevole contatto con il nemico. Spostato poi a nord di Cassino, il 31 marzo il raggruppamento conquistava monte Morrone, dopo aver preso l’antistante cima di Castelnuovo, respingendo poi con gravi perdite per l’assalitore un tentativo tedesco di riprendere monte Morrone nella notte sul 10 aprile. Il 18 aprile il raggruppamento assumeva il nome di Corpo italiano di liberazione, ed era subito ingrossato da un battaglione di fanteria di marina e dalla divisione paracadutisti Nembo, finalmente trasportata dalla Sardegna. Anche la marina e l’aviazione si prodigavano. Nella grande battaglia per la liberazione di Roma, iniziata il 12 maggio 1944, le truppe italiane, aggregate all’8ª armata, che si mosse dopo il successo della 5ª, non vennero impegnate che molto tardivamente, dietro insistenze e non poterono entrare in Roma, il 5 giugno, fra le truppe liberatrici.
Liberata Roma, Vittorio Emanuele intendeva firmare nella capitale il decreto di nomina di Umberto a luogotenente, ma la maggioranza del ministero era per la firma immediata, che fu imposta dal gen. Mac Farlane a Ravello, presso Salerno, nella villa Rufolo, nel pomeriggio del 5 giugno, presente anche il Badoglio.
Avuto dal principe Umberto l’incarico di costituire il nuovo ministero, il B. giunse a Roma con il luogotenente la mattina dell’8. Ma qui tutti i membri del C.L.N. romano, presente il gen. Mac Farlane, dichiararono necessario un governo schiettamente democratico, formato da elementi di sicura fede antifascista, e tale da poter condurre energicamente la guerra e preparare la libera consultazione popolare per la scelta della forma istituzionale, designando unanime il Bonomi quale presidente. Così il B. lasciava silenziosamente Roma la mattina del 9 giugno, invano sperando che P. Togliatti non approvasse l’operato del C.L.N. Il 10 giugno il Bonomi presentava al luogotenente la lista del nuovo ministero: gli alleati tardarono a riconoscere il fatto compiuto, e si dové attendere a Salerno il loro placet; solo il 15 luglio il nuovo ministero poteva insediarsi a Roma. Pare che il B. si adoperasse per avallare il nuovo governo presso gli alleati. Ma prima di sparire definitivamente dalla scena politica, nella speranza di cancellare la macchia della fuga di Pescara, il B. si adoperò perché venisse iniziata una severa inchiesta circa la mancata difesa di Roma, e specialmente contro il gen. Carboni che, invece, di sua iniziativa, aveva cercato di difenderla contro i Tedeschi.
Ritiratosi a vita privata, fu dichiarato decaduto da senatore il 30 marzo 1945 per l’adesione data al fascismo; due anni dopo il provvedimento era cassato dalla Corte di Cassazione. Pubblicava poi due libri di memorie: Rivelazioni su Fiume, Roma 1946, con ampia appendice di documenti, e L’Italia nella seconda guerra mondiale (Memorie e documenti), Milano 1946.
Il B. morì a Grazzano il 1° nov. 1956.(fonte)
[7] Alberto Emanuele Lumbroso Nacque a Torino il 1o ott. 1872, in una famiglia israelita, unico figlio di Giacomo e di Maria Esmeralda Todros, di nazionalità francese.
Il nonno paterno, Abramo, protomedico del bey di Tunisi, aveva ottenuto nel 1866 da Vittorio Emanuele II il titolo di barone per meriti scientifici e per speciali benemerenze. Il padre del L., Giacomo, era nato a Bardo, in Tunisia, nel 1844. Ellenista e papirologo di fama internazionale, dal 1874 socio della Deutsche Akademie der Wissenschaften, influenzò fortemente l’educazione e la formazione intellettuale del Lumbroso. Trasferitosi a Roma intorno al 1877, divenne accademico dei Lincei (1878) e pubblicò la sua opera principale, L’Egitto al tempo dei Greci e dei Romani (Roma 1882), ottenendo nello stesso 1882 la cattedra di storia antica all’Università di Palermo. Con il medesimo insegnamento, nel 1884, si trasferì a Pisa, quindi, nel 1887, nuovamente a Roma dove insegnò storia moderna alla “Sapienza” (vedi le Lezioni universitarie su Cola di Rienzo, ibid. 1891). Giacomo morì a Rapallo nel 1925.
I trasferimenti del padre lasciarono notevoli tracce nella formazione del giovane L.; tra le sue prime esperienze romane si ricordano la frequentazione delle case di T. Mamiani e di Q. Sella, dove divenne amico di S. Giacomelli, nipote di questo; in Sicilia rimase affascinato da G. Pitrè e, nell’Archivio per lo studio delle tradizioni popolari da lui diretto, pubblicò nel 1896 il suo primo articolo.
Nel periodo pisano il L. continuò con successo gli studi e sviluppò una notevole passione per la cultura erudita, collezionando autografi, raccogliendo motti, proverbi e notizie folkloristiche, sempre in perfetta sintonia con il padre. Tornato a Roma si diplomò al liceo classico E.Q. Visconti, si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza e si appassionò al periodo napoleonico, laureandosi, intorno al 1894, con una tesi su Napoleone I e l’Inghilterra (poi rielaborata e pubblicata in volume: Napoleone I e l’Inghilterra. Saggio sulle origini del blocco continentale e sulle sue conseguenze economiche, Roma 1897). Gli studi napoleonici occuparono interamente il L. fra l’ultimo decennio dell’Ottocento e il primo del Novecento. La frequentazione di ambienti intellettuali ed eruditi italiani (soprattutto romani, torinesi e, più tardi, napoletani) e francesi, l’assoluta familiarità con la lingua della madre e lo sviluppo di un talento compilativo dimostrato fin dalla prima giovinezza portarono il L. alla realizzazione di un gran numero di pubblicazioni.
Tra il 1894 e il 1895 uscirono i cinque volumi del Saggio di una bibliografia ragionata per servire alla storia dell’epoca napoleonica (Modena), circa mille pagine dedicate alle lettere “da A a Bernays” (l’opera resterà incompiuta) e tra il 1895 e il 1898 le sei serie della Miscellanea napoleonica (Roma-Modena), altra cospicua opera erudita di oltre millecinquecento pagine che raccoglieva memoriali, lettere, canzoni, accadimenti notevoli e minuti forniti da studiosi europei e introdotti dal L.; nella Bibliografia dell’età del Risorgimento V.E. Giuntella li definì “saggi bibliografici che, sebbene arretrati, possono ancora essere utilmente consultati” (I, Firenze 1971, p. 405).
L’interesse per il periodo napoleonico portò il L. a Napoli, in cerca di notizie e documenti su Gioacchino Murat. Suo interlocutore privilegiato in quella città fu B. Croce: il L. frequentò la casa del filosofo negli ultimi anni del secolo e i rapporti epistolari tra i due si protrassero a lungo.
I maggiori lavori napoletani del L. furono la Correspondance de Joachim Murat, chasseur à cheval, général, maréchal d’Empire, grand-duc de Clèves et de Berg (julliet 1791 – julliet 1808 [sic]), (prefaz. di H. Houssaves, Turin 1899 e L’agonia di un Regno: Gioacchino Murat al Pizzo (1815), I, L’addio a Napoli, prefaz. di G. Mazzatinti, Roma-Bologna 1904.
Alla fine del secolo il L. fu organizzatore e presidente operativo del Comitato internazionale per il centenario della battaglia di Marengo (14 giugno 1800-1900): chiamò alla presidenza onoraria G. Larroumet, professore della Sorbona e accademico di Francia, ottenendo la partecipazione onoraria di noti intellettuali tra cui G. Carducci, B. Croce, G. Mazzatinti, C. Segre, A. Sorel, le cui lettere di adesione furono via via pubblicate nel Bulletin mensuel du Comité international; nel 1903, accompagnato da una lettera-prefazione di Larroumet, fu edito il primo tomo, poi rimasto senza seguito, dei Mélanges Marengo (s.l. [ma Frascati] né d.).
Ancora una volta il L. usa uno stile cronachistico, cerca e pubblica ogni genere di fonte, prediligendo quelle dirette. A tale scopo rintraccia figli e nipoti dei personaggi che descrive; caso emblematico quello dei “Napoleonidi”: e infatti, grazie ai suoi lavori e alle sue frequentazioni parigine, divenne “Bibliothécaire honoraire de S.A.I. le prince Napoléon” [Vittorio Napoleone]; pubblicò poi Napoleone II, studi e ricerche. Ritratti, fac-simili di autografi e vari scritti editi ed inediti sul duca di Reichstadt (Roma 1902), Bibliografia ragionata per servire alla storia di Napoleone II, re di Roma, duca di Reichstadt (ibid. 1905) e – più tardi – redasse le voci su Napoleone I e i Napoleonidi per il Grande Dizionario enciclopedico UTET (1937, VII, pp. 1100-1150). A coronamento dei suoi interessi per i Bonaparte, nel 1901 il L. fondò e diresse la Revue napoléonienne, bimestrale (ma, dal 1908, mensile) che uscì fino al 1913, coinvolgendo nell’iniziativa un gran numero di studiosi italiani e francesi.
L’interesse per la cultura d’Oltralpe lo portò a pubblicare anche lavori su Voltaire (Voltairiana inedita, Roma 1901), Stendhal (Stendhaliana: da Enrico Beyle a Gioacchino Rossini, Pinerolo 1902) e soprattutto Maupassant (Souvenirs sur Guy de Maupassant: sa dernière maladie, sa mort. Avec des lettres inédites communiquées par madame Laure de Maupassant et des notes recueillies parmi les amis et les médecins de l’écrivain, Genève-Rome 1905), scritto durante un lungo soggiorno parigino.
Nel 1898 il L. era intanto diventato consigliere della Società bibliografica italiana e probabilmente nel contesto culturale della Società conobbe Carducci, cui dedicò, postuma, una Miscellanea carducciana (con prefaz. di B. Croce, Bologna 1911), raccolta di notizie critiche, biografiche e bibliografiche sul poeta.
Nel 1897 aveva sposato Natalia Besso, dall’unione con la quale nacquero Maria Letizia (1898) e Ortensia (1901). Nel 1901 l’intera famiglia abbracciò la religione cattolica. Nel 1904 il L. donò la sua ricca biblioteca napoleonica (circa trentamila volumi e opuscoli) alla Biblioteca nazionale di Torino, da poco distrutta in un incendio. Nel 1907 assunse, con A.J. Rusconi, la direzione della Rivista di Roma e, a partire dal 1909, ne divenne direttore unico.
La direzione della Rivista rappresentò una svolta nei suoi interessi e nei suoi studi, che da internazionali ed eruditi divennero più “patriottici”, legati a eventi del Risorgimento e della storia italiana (in particolare il L. sì appassionò alla riabilitazione dell’ammiraglio C. Pellion di Persano e, oltre agli articoli apparsi nella Rivista, sull’argomento pubblicò La battaglia di Lissa nella storia e nella leggenda: la verità sulla campagna navale del 1866 desunta da nuovi documenti e testimonianze, Roma 1910, seguita da ulteriori approfondimenti, tra cui Il carteggio di un vinto, ibid. 1917). Tra coloro chiamati dal L. a collaborare alla Rivista – che dal primo momento egli volle “crispina, salandrina e antigiolittiana” e, dopo la guerra, “antibonomiana e antinittiana” (Premessa, s. 3, XXXII [1928], 1) – D. Oliva, E. Corradini, L. Ferderzoni, A. Dudan.
Dal 1909 G. D’Annunzio collaborò alla Rivista di Roma. Il contatto diretto portò in breve tempo il L., inizialmente piuttosto critico nei confronti del poeta (si veda del L. Plagi, imitazioni e traduzioni, in Id., Scaramucce e avvisaglie. Saggi storici e letterari di un bibliofilo(, Frascati 1902, pubblicazione che Croce aveva particolarmente apprezzato), a divenirne ammiratore e paladino, fino a entrare in forte polemica sia con lo stesso Croce sia con G.A. Borgese; nel 1913, nel cinquantesimo anniversario di D’Annunzio, volle dedicargli l’intero n. 6 della Rivista; nello stesso anno il L. fu attivo nel Comitato pro Dalmazia italiana e, nel 1914, diede vita a un Comitato pro Polonia del quale offrì la presidenza onoraria al poeta.
Approssimandosi la guerra, la Rivista di Roma svolse campagne in favore dell’intervento e, nel 1915, lo stesso L. partì volontario col grado di sottotenente. Promosso tenente, dal 1916 al 1918 fu addetto militare aggiunto presso l’ambasciata italiana ad Atene e, al termine del conflitto, fu insignito del cavalierato nell’Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro per benemerenze acquisite in guerra.
Nel 1924, ormai di fatto separato dalla moglie, il L. si trasferì a Genova dove riprese la pubblicazione della Rivista di Roma, sospesa nel biennio 1922-23, che diresse fino al 1932. A Genova ebbe due figli, Emanuele e Maria Tornaghi, nati nel 1918 e nel 1919 da Adriana Tornaghi, con la quale aveva a lungo convissuto.
Dopo la morte del padre, il L. ne pubblicò la bibliografia (in Raccolta di scritti in onore di Giacomo Lumbroso, Milano 1925); fin dal 1923 aveva collaborato con Critica fascista, e nel 1929 inviò suoi libri a B. Mussolini e chiese l’iscrizione al Partito nazionale fascista. I lavori più consistenti del L. negli anni Venti e Trenta furono dedicati principalmente alla Grande Guerra e a personaggi della casa reale.
Bibliografia ragionata della guerra delle nazioni: numeri 1-1000 (scritti anteriori al 1 marzo 1916), Roma 1920; Le origini economiche e diplomatiche della guerra mondiale, dal trattato di Francoforte a quello di Versailles, I-II, Milano 1926-28; Carteggi imperiali e reali: 1870-1918. Come sovrani e uomini di Stato stranieri passarono da un sincero pacifismo al convincimento della guerra inevitabile, ibid. 1931; Cinque capi nella tormenta e dopo: Cadorna, Diaz, Emanuele Filiberto, Giardino, Thaon di Revel visti da vicino, ibid. 1932; Da Adua alla Bainsizza a Vittorio Veneto: documenti inediti, polemiche, spunti critici, Genova 1932; Fame usurpate: il dramma del comando unico interalleato, Milano 1934.
Fra gli ultimi volumi pubblicati dal L. si ricordano ancora: Carlo Alberto re di Sardegna. Memorie inedite del 1848, con uno studio sulla campagna del 1848 e con un’appendice di documenti inediti o sconosciuti tradotti sugli autografi francesi del re da Carlo Promis (s.l. 1935) nonché, per i “Quaderni di cultura sabauda”, I duchi di Genova dal 1822 ad oggi (Ferdinando, Tommaso, Ferdinando-Umberto), ed Elena di Montenegro regina d’Italia (entrambi Firenze 1934).
Grazie al suo prestigio personale e all’adesione al cattolicesimo risalente al 1901, i Lumbroso furono discriminati dall’applicazione delle leggi razziali del 1938, ma il L. non pubblicò più. Il L. morì a Santa Margherita Ligure l’8 maggio 1942.(fonte)