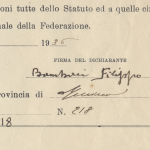CASA DI SUA MAESTÀ IL RE
IL MINISTRO
10 agosto 1962
Gentile Signora,
S.M. il Re ha appreso con profondo
rammarico la notizia della dipartica del
Gr. Uff. Federigo Cappelli, Editore, e mi ha
dato l’incarico di partecipare a lei, ai suoi
figlioli ed ai congiunti tutti sentite condo-
glianze.
Il Sovrano Si inchina reverente alla
memoria dell’Instancabile lavoratore, dell’uo-
mo di cuore generoso e di mente eletta, che
ha contribuito alla diffusione della cultura
nel Paese.
Nel loro grande dolore Sua Maestà Si
considera vicino con cuore amico e con animo
memore.
Voglia anche accogliere, gentile Si-
gnora, per lei ed i suoi, l’espressione del
mio cordoglio e deferenti sentimenti.
Dev.mo
F. Lucifero[1]
Gentile Signora
Irene Pazzi ved. Cappelli[2]
Via Farini
BOLOGNA
retro
LE L. 1000
5342
Note
[1] Falcone Lucifero
Una famiglia di antiche origini nobiliari
Nacque il 3 gennaio 1898 a Crotone, allora in provincia di Catanzaro, da Armando e da Antonietta dei marchesi di Francia. Di famiglia nobile – il titolo di marchese di Apriglianello, frazione di Crotone dove si trova il palazzo avito costruito alla fine del XVII secolo, era stato attribuito a Fabrizio Lucifero (1662-1731) da Filippo V nel 1703 – era il penultimo di sette figli: Teresa (1888-1974), Alfonsina (1889-1982), Ketty (1891-1926), Antonio Arduino (1892- 1970), Francesco (1895-1948), Luciano Antonio (1900-1941). I Luchiferus erano presenti nel territorio di Crotone fin dalla dominazione sveva e, come ha scritto Salvatore Mongiardo, con «i capelli rossi e statura di due metri per i maschi, nonché padroni di quasi tutte le terre dal mare ai monti» (2013, p. 34), erano una famiglia di rilievo. Il padre si dedicò alla gestione delle vaste proprietà terriere, manifestando propositi innovativi sia nelle tecniche di produzione sia nei rapporti sociali. Si impegnò in molteplici attività culturali con spirito enciclopedico, coltivando interessi in diversi campi. La madre era imparentata con i baroni Scoppa di Sant’Andrea Apostolo dello Jonio. Alla morte, nel febbraio del 1910, di Enrichetta Scoppa, i Lucifero ne ereditarono le proprietà che confluirono nella loro azienda agricola.
Il nonno paterno, Antonio (1830-1899), era stato tra il 1874 e il 1875 sindaco della città, lo zio paterno Alfonso (1853-1925) deputato dal 1886 al 1919 e sottosegretario alla Pubblica istruzione nel II governo Sonnino, il cugino Roberto (1903-1993) fu componente della Consulta nazionale, poi deputato del Blocco nazionale della libertà alla Costituente, segretario del Partito liberale italiano nel 1947-48, senatore nella prima legislatura repubblicana, quindi deputato del Partito nazionale monarchico fino al 1963. Nella formazione di Lucifero si avvertivano pertanto diversi influssi: da un lato, il modello paterno in cui l’aspirazione a modernizzare feroci e antichi rapporti sociali propri di una società oligarchica ed escludente si coniugava con diversi interessi culturali; dall’altra la presenza pubblica della famiglia di origine. Fin da giovanissimo contribuì a rendere più vivace la vita cittadina, fondando una biblioteca popolare per ragazzi e la sezione cittadina della Lega navale italiana.
La formazione e gli studi
Compiuti gli studi superiori al Collegio militare di Roma, prese la licenza liceale il 16 settembre 1919. Si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza dell’Università di Roma nel 1916 e vi sostenne gli esami del primo triennio. Nel dicembre del 1919 si iscrisse a Torino e si laureò il 9 luglio 1920. Il profitto come studente non fu eccelso: il voto finale fu di 93/110 in diritto processuale, vale a dire procedura civile, disciplina sulla quale svolse la dissertazione con Antonio Castellari. Il periodo torinese fu, nella ricostruzione di sé che egli propose, di decisiva rilevanza, data la funzione del capoluogo sabaudo nel prospettare le forme della nascente società industriale e della riconfigurazione del conflitto. Frequentò il gruppo raccolto attorno all’allora settimanale L’Ordine Nuovo e in particolare il suo animatore, Antonio Gramsci, del quale avrebbe d’un canto rifiutato il radicalismo rivoluzionario, ma accolto dall’altro «l’umanesimo socialista» (Liguori, 2020). Sul piano dell’impegno pubblico la prima esperienza decisiva era stata l’adesione all’interventismo, cui era seguita la diretta partecipazione come ufficiale alla Grande Guerra. Gli anni torinesi furono segnati dalla militanza socialista, orientamento che per «sentimento» aveva abbracciato all’età di dodici anni alla vista del lazzaretto della sua città (Deaglio, 1991). Giunse in città nel 1918 per proseguire il servizio militare e fu attivo militante, votando anche in favore dell’occupazione delle fabbriche. Assistette al momento culminante e poi all’inizio della ritirata del movimento consiliare ma più in generale del movimento operaio. Come per altri della sua generazione, quell’impatto traumatico con lo strutturarsi della politica di massa rimase fissato nella memoria tanto da temere una seconda ondata nell’immediato secondo dopoguerra. Erano però radicalmente mutate cornice globale e realtà nazionale: la lezione degli anni Venti era stata appresa dai sorgenti partiti antifascisti, sebbene agli occhi della classe dirigente di orientamento monarchico apparissero – per il loro repubblicanesimo – antisistema. Rimanevano – secondo il termine ricorrente nei diari di Lucifero della Luogotenenza per definire gli antifascisti repubblicani – sovversivi (cfr. L’ultimo re, 2002, passim)
Nel primo dopoguerra e durante la dittatura fascista
Nelle elezioni comunali di Crotone del 17 ottobre 1920 Lucifero si candidò nel Partito socialista, che vinse ed elesse sindaco Enrico Mastracchi. Anche Lucifero fu eletto, ma «fu consigliere poco diligente al suo ufficio, considerate le numerosissime assenze alle tornate consiliari» (Palmieri, 2006, p. 124, nota 44). Scissosi il Partito socialista tra massimalisti e riformisti in concomitanza con la marcia su Roma (28 ottobre 1922), Lucifero aderì nel 1924 al Partito socialista unitario, assunse posizioni antifasciste e fu attivo politicamente fino allo scioglimento dei partiti. Fece parte di Italia libera, il movimento antifascista generato dall’interventismo democratico e glielo ricordò il leader repubblicano Randolfo Pacciardi durante la crisi del governo Parri (cfr. L’ultimo re, 2002, p. 451). Avvocato civilista, Lucifero si immerse nella professione, che avviò a Roma nello studio Sacerdoti-Pelosini. Durante la dittatura politicamente appartato, promosse la costituzione del Centro romano di studi sulla delinquenza minorile, diretto da Simone De Santis (1862-1935), alle origini in Italia degli studi e delle pratiche relative alla psicologia e alla neuropsichiatria infantile. Lucifero ne fu a lungo segretario e viaggiò molto per approfondire e studiare le soluzioni adottate all’estero. A Roma abitava sul Lungotevere Arnaldo da Brescia, dove ospitò negli anni Trenta il pittore Angelo Savelli (1911-1995), allora studente all’Accademia di Belle Arti e del cui padre Lucifero era amico.
Gli anni della dittatura furono di immersione nel lavoro e, come per molti, di sostanziale ritiro, di coabitazione con quella che ai contemporanei appariva la stabilizzazione permanente dell’Italia che aveva individuato una soluzione originale per la nazionalizzazione delle masse. Era imperniata sulla diarchia tra sovrano e dittatura (Colombo, 2010). In una prospettiva di più lungo periodo potrebbe apparire come il tentativo impossibile di conciliazione tra consuetudine oligarchica e pulsioni della società di massa reggimentata entro la prospettiva nazionalistica della democrazia totalitaria. Ne derivò un intreccio inestricabile tra monarchia e regime fascista, al cui irrisolvibile scioglimento Lucifero si sarebbe cimentato con tutte le sue forze negli anni del suo più intenso impegno pubblico. La diarchia, infatti, aveva inteso conciliare il vecchio regime liberale monarchico, che aveva scientemente escluso l’approdo democratico pluralista dal suo orizzonte, con il regime totalitario, accettato proprio perché aveva evitato gli effetti ritenuti dirompenti del pluralismo di massa. Al fondo era il sentimento di intrinseca fragilità che aveva accompagnato la monarchia sabauda nel corso del XIX e della prima metà del XX secolo. Con esso Lucifero dovette fare i conti a partire dal giugno 1944.
Da prefetto a ministro
Dopo il passaggio della provincia di Catanzaro all’amministrazione alleata, il 10 ottobre 1943 Lucifero venne nominato prefetto di Catanzaro. Secondo Fausto Cozzetto venne scelto non soltanto per la conoscenza maturata con l’ufficiale agli affari civili della provincia di Catanzaro, maggiore Holmstrom, ma soprattutto per l’appartenenza a una delle famiglie più cospicue dell’area in una fase in cui la fine della dittatura fascista liberò l’asprezza dei conflitti sociali (Cozzetto, 1994, p. 231). Il 10 febbraio 1944 il Consiglio dei ministri nominò Lucifero prefetto e lo mise «a disposizione per incarico politico» (Verbali del Consiglio dei ministri, I, 1994, p. 179). Sostituì infatti Alessandro Brizzi, già direttore generale dell’Agricoltura al ministero dell’Economia nazionale, a capo del dicastero dell’Agricoltura nel I governo Badoglio. A Lucifero riuscì l’affidamento al suo ministero del Commissariato generale dell’Alimentazione, conteso dall’Interno (p. 188). Conclusa l’esperienza governativa con la formazione del II governo Badoglio composto dai partiti del Comitato di liberazione nazionale (CNL), l’11 maggio Lucifero fu designato prefetto di Bari. In quella stessa seduta, il Consiglio dei ministri discusse l’intervista del principe di Piemonte, indicato dal padre quale futuro luogotenente del Regno dopo la liberazione di Roma, a Christopher Lumby del Times, apparsa il 20 aprile. Approvò, in seguito anche alla severa replica di Benedetto Croce, all’unanimità un documento in cui si respingevano le accuse al popolo italiano di «responsabilità della guerra fascista» (Verbali dei Consiglio dei ministri, II, 1994, p. 70). Il 4 maggio Badoglio aveva preavvertito «di essere in grado di assicurare il Consiglio che vi saranno cambiamenti nel seguito di S.A.R. il Principe Ereditario» (p. 26). E di quei cambiamenti fu parte decisiva Lucifero.
Una lunga fedeltà: a capo della Real Casa con Umberto di Savoia
Il primo Consiglio dei ministri del governo presieduto da Ivanoe Bonomi dopo la liberazione di Roma approvò lo schema di decreto legge per la nomina del «Reggente il Ministero della Real Casa» (Verbali del Consiglio dei ministri, III, 1995, p. 5). La scelta cadde su Lucifero per più ragioni. Era gradito al principe ereditario, in rapporti di amicizia col fratello Francesco. Nel contempo era ritenuto di garanzia circa il mantenimento della tregua istituzionale. L’obiettivo di Lucifero fu reinventare la monarchia, cercando non solo di cancellare le tracce del legame intrecciato con la dittatura fascista e col suo progetto totalitario, ma di rinnovarne costumi e stile, rendendoli più austeri e confinando dietro le quinte gran parte dei componenti la famiglia reale. Per la sua storia personale, Lucifero appariva particolarmente adatto a riadattare la monarchia all’inevitabile tempo democratico. Mise al servizio di questo disegno la credibilità di nobile monarchico dall’adamantino vissuto socialista e antifascista. Era però, a leggere i suoi diari del 1944-1946, un’impresa oltremodo complicata. Anche i sostenitori dell’istituto monarchico avrebbero voluto la rinuncia di Umberto e procedere alla diretta successione del figlio Vittorio Emanuele, allora bambino di sette anni, accompagnato da una reggenza. In questo senso si mossero i liberali già attivi nel prefascismo. Non sfuggiva loro che la monarchia si era servita del fascismo per alimentare energie e forze nuove che ne ravvivassero la legittimità. Luigi Einaudi, per esempio, in esilio in Svizzera, con la principessa di Piemonte sostenne che Umberto di Savoia col fascismo si era «compromesso» (Diario dell’esilio, 1997, p. 45).
Lucifero era conscio di queste difficoltà: vedeva la cautela e la prudenza di molti, pur favorevoli all’istituto monarchico, per non compromettersi con Umberto di Savoia, a cominciare da uomini di rilievo della gerarchia cattolica. I colori della luogotenenza erano quelli del crepuscolo, quasi a suggello dell’esaurirsi della funzione svolta dalla monarchia dei Savoia nel processo di unificazione nazionale. Né, del resto, essa pareva afferrare pienamente i caratteri inediti per l’Italia dell’articolazione del sistema democratico in formazione sul piano globale. Il peso dello stile regale dei Savoia, sfociato nella coabitazione inevitabile tra sistema oligarchico e democrazia totalitaria, condizionava il presente in cui si affermava un sistema plurale, articolato nei partiti che organizzavano le culture politiche degli italiani in vista di un nuovo edificio istituzionale democratico da edificare.
Referente della Casa reale era quel che restava della classe dirigente liberale prefascista – da Croce a Vittorio Emanuele Orlando, da Ivanoe Bonomi a Francesco Saverio Nitti – rinvigorita da apporti delle nuove generazioni, come il cugino di Lucifero, Roberto. Per loro il fascismo era una parentesi e negavano fosse una fase che aveva segnato il difficile farsi della coabitazione nazionale. L’universo cattolico, al quale si guardava come alla forza che avrebbe potuto sostenere la monarchia nella realtà democratica, non solo era assai variegato, ma seguiva propri autonomi disegni. Fu Alcide De Gasperi ad ammonire Lucifero: «Non è poi detto che la Repubblica in Italia non possa essere moderata!» (L’ultimo re, p. 427). Il leader democristiano evidenziava la precarietà dell’assunto su cui si reggeva la causa monarchica, così come era stata impostata da Lucifero, quale sola barriera efficace alla minaccia del bolscevismo. Era una posizione speculare a quella di Pietro Nenni. Si ribadiva uno schema che era stato efficace nel passato, ma che nella nuova realtà perdeva la gran parte del suo senso.
Se era palese la diffidenza nei riguardi della classe dirigente dei partiti del movimento operaio, a cominciare dai capi – Palmiro Togliatti e Nenni –, particolarmente viva era l’avversione nei confronti degli azionisti, da Sergio Fenoaltea sottosegretario del governo Bonomi a Ferruccio Parri presidente del Consiglio, da Ugo La Malfa a Emilio Lussu, e di radicali come il futuro presidente della Commissione dei Settantacinque Meuccio Ruini. Nei riflessi nazionali della revisione di cultura politica realizzata dalla sinistra democratica europea e americana tra le due guerre, che costituì l’originalità della proposta azionista, Lucifero intravedeva un insidioso avversario. In un certo senso rivelava la presenza di tratti trasformisti nello schema alla base del tentativo di riforma della monarchia dopo l’immersione nell’esperienza totalitaria. Dietro il rispetto delle forme, celava una sostanza – la testimonianza che ci ha lasciato Lucifero è esemplare in questo senso – di profondo sospetto nei confronti del Comitato di liberazione nazionale (CNL) e della rivendicazione del ruolo di guida della navigazione verso l’approdo democratico che, pur tra contrasti, esso conduceva. Ne è prova l’avversione di Lucifero per Parri, ritenuto «torbido», «capace di congiure e di porcherie», «settario» (pp. 451, 467), connotati sideralmente estranei alla ferma mitezza democratica del presidente del Consiglio uscente. Il suo governo era però considerato una soluzione di continuità e pertanto antagonista irriducibile della monarchia: per il suo superamento Lucifero molto si prodigò.
Tuttavia a Parri non succedettero Nitti, Bonomi od Orlando, come era nelle attese e nelle speranze, ma De Gasperi, il cui ministero fu prosecuzione dell’esperienza del CLN e della faticosa costruzione per la prima volta di una vita democraticamente plurale. L’opera di Lucifero fu in questa fase volta a ricercare modi e forme che alla dichiarata neutralità della luogotenenza accompagnavano atteggiamenti antichi, con l’obiettivo di salvare la monarchia nel passaggio dalla dittatura del partito unico alla democrazia dei partiti. Così, non pareva avere tutti i torti il generale francese conosciuto nel gennaio del 1945 in casa della principessa Elvina Pallavicini, il quale, alla vigilia della crisi provocata dai liberali del governo Parri, gli chiese sornione «se mi interesso di Croce Rossa!», tanto che Lucifero commentò: «Si potrebbe dire che il generale sia un fine umorista!» (L’ultimo re, 2002, p. 444).
Lucifero conseguì comunque risultati parziali incoraggianti. Contribuì a far prevalere l’ipotesi del referendum popolare, una richiesta dei monarchici in alternativa all’affidamento della scelta sulla questione istituzionale all’Assemblea Costituente. Il referendum – per i monarchici plebiscito – avrebbe in effetti fornito una formidabile legittimazione democratica alla forma di Stato cui si sarebbero affidati i votanti. Nonostante il frammentato e diviso universo monarchico, fu molto efficace la campagna incentrata, dopo l’abdicazione di Vittorio Emanuele III, sulla valorizzazione del giovane Umberto, della moglie Maria José e dei figli, allora bambini. Non fu però sufficiente: il referendum del 2-3 giugno 1946 decise per la Repubblica, sia pure confermando alcune forti e irrisolte fratture, a cominciare da quella tra il nord e il sud del Paese. La fase conclusiva della vicenda dinastica dei Savoia ebbe strascichi: furono enfatizzati dalla lentezza con cui giunsero i risultati – si votava per la prima volta dopo un ventennio e il referendum fu scrutinato solo dopo le schede dell’Assemblea Costituente –, dalle polemiche su come effettuare il conteggio (se sui voti validi o sull’insieme dei votanti), dai sospetti di brogli in favore della Repubblica: il ministro dell’Interno era il socialista Giuseppe Romita, eventualità che la luogotenenza aveva cercato di evitare.
Un recente studio ha mostrato, avvalendosi del modello statistico sviluppato sulla base della legge di Benford, la natura cristallina del voto. Ha concluso che «l’assenza di evidenti anomalie nei test porta a escludere il dubbio di brogli elettorali tali da capovolgere l’esito referendario» (Mengotto – Venturini, 2012, p. 510). Lungi dall’essere edulcorato, il risultato rifletteva la volontà effettiva della maggioranza. E proprio per questo era fonte di amarezza per la monarchia giudicata non più adatta a rappresentare l’unità nazionale. Dopo i giorni convulsi successivi al risultato, partito il 13 giugno Umberto II di Savoia, ormai il ‘re di maggio’, per l’esilio a Cascais, Lucifero ne fu sino alla morte, nel 1983, il fedele ministro della Real Casa. Come mostra il loro carteggio dei decenni seguenti, mantenne in nome del re i rapporti con le autorità laiche e religiose, lo rappresentò ufficialmente, intervenne a suo nome a sostegno delle persone e delle aree colpite dalle calamità naturali, come dalle stragi che da quella di piazza Fontana a Milano (12 dicembre 1969) in poi hanno condizionato il radicamento della democrazia repubblicana. Nel 1948 intanto aveva pubblicato il romanzo giovanile Tonna – era il nome della domestica di famiglia della sua infanzia –, ambientato nella Calabria del latifondo e degli aspri conflitti di classe, con la copertina disegnata da Savelli. Lucifero fu sempre molto attivo, e anche quando era ormai molto anziano mantenne intatte l’arguta intelligenza e la lucidità.
Morì a 99 anni, il 2 maggio 1997. Non si era mai sposato. Riposa nella tomba di famiglia a Crotone.(fonte)
[2] Cappelli Editore
Federigo Cappelli
L’inizio dell’attività editoriale si può collocare intorno alla metà dell’Ottocento, più esattamente nel 1844, quando il barbiere fiorentino Federigo Cappelli si trasferisce a Rocca San Casciano, sugli appennini forlivesi, vi fonda una tipografia e riceve la prima commessa di testi per le scuole, registri e moduli amministrativi. L’attività tipografica, come per ogni altra casa editrice italiana, non si distingue da quella editoriale, che si costruisce sulla prima e nel tempo finisce per prevalere.
La scelta di Rocca San Casciano era dovuta al fatto che il paese, allora compreso nella provincia di Firenze, era capoluogo di Circondario, sede di tribunale e sottoprefettura. Era quindi sede di diversi uffici amministrativi e di un’attività significativa per il tempo, che coinvolgeva numerose figure provenienti dalle zone e città limitrofe.
La tipografia pubblica inizialmente modulistica e solo occasionalmente libri.
Licinio Cappelli
Alla morte di Federigo nel 1880, il figlio Licinio, di appena sedici anni, eredita un’attività discretamente sviluppata ma anche oberata di debiti.
Il giovane subentra con determinazione, amplia l’attività produttiva estendendola a testi di diversa natura, da manuali scolastici per le scuole della zona e testi di diritto scritti da autori che gravitavano intorno al tribunale di Rocca, ai periodici. Inizia, ad esempio, la pubblicazione della strenna “Fra sorelle”, legata al periodico “Mamma” diretto da Gualberta Beccari, e un mensile di storia dell’arte chiamato “Iride”.
Soprattutto, però, Licinio comprende la necessità di estendere il più possibile la promozione e commercializzazione dei suoi libri e inizia a viaggiare nelle città più vicine, da Forlì a Firenze a Bologna, alla ricerca di clientela.
La crescita dell’attività è dimostrata dall’acquisto, nel 1895, di due nuove macchine per stampare e dalla trasformazione della vecchia tipografia in Arti Grafiche Cappelli, con un numero via via crescente di dipendenti.
Acquistata insieme al libraio Luigi Beltrami, nel 1900, a Bologna, la Libreria Treves di via Farini, poco dopo rileva anche la Libreria Zanichelli, situata al lato opposto della piazza Galvani, con l’annessa tipografia, che conserva per un breve periodo, per cederla molto presto alla Bemporad di Firenze.
Oramai trasferitosi a Bologna, vi fonda la Casa Editrice Cappelli nel 1914, data ufficiale di nascita.
La tipografia rimane invece a Rocca San Casciano, con cui Licinio e la sua famiglia conservano legami molto stretti. Dai venticinque dipendenti dell’inizio del secolo, la tipografia passa a un centinaio nell’arco di una trentina d’anni. Significativa anche l’occupazione femminile, tradizionalmente presente nel lavoro di legatoria.
La Cappelli amplia l’ambito delle sue pubblicazioni e aumenta la produzione a un ritmo straordinario, spaziando su materie nuove, dalla narrativa alla medicina, al diritto, alle scienze e ai periodici femminili. Apre librerie a Trieste, Milano, Bolzano e Napoli.
Nel 1906 aveva pubblicato, con la sigla Zanichelli-Beltrami-Cappelli, forse il primo testo di ampio respiro per il mercato nazionale, il romanzo Anima di Tommaso Nediani con prefazione di Fogazzaro, e nel 1912 aveva rilevato dai fratelli Ademollo di Firenze “Cordelia”, periodico a sfondo femminista “cauto e moderato” con annessa collana di successo ragguardevole diretto prima da Ida Baccini (1884-1911), poi da Maria Majocchi Plattis (Iolanda) (1911-1917), Rina Maria Pierazzi (1917-1935) e infine Elena Morozzo della Rocca (1935-1942).
Negli anni della Prima Guerra mondiale aveva iniziato le pubblicazioni di testi e periodici di medicina, come gesto patriottico nei confronti della massa di feriti e mutilati causata dalla guerra. Una sua famosa collana fu Classici italiani della medicina, continuata fino al secondo dopoguerra.
La Cappelli nel primo dopoguerra
A partire dagli anni Venti la crescita fu probabilmente tumultuosa, favorita anche dai buoni rapporti con il regime fascista. Mussolini – nato a Predappio – era conterraneo di Cappelli e secondo un aneddoto aveva lavorato da studente nella tipografia come correttore di bozze.
In realtà, insieme ai buoni rapporti con il regime, la Casa editrice dimostrò una sua autonomia, pubblicando testi e mantenendo rapporti con figure, se non appartenenti all’antifascismo, almeno lontane dal regime.
Tra i suoi collaboratori e autori vi fu Attilio Frescura, autore di un celebre libro di memorie sulla Prima Guerra mondiale, Memorie di un imboscato (1919, Mursia 2015), più volte censurato. La Casa editrice conservò sempre un’intensa attività di collaborazione con Rodolfo Mondolfo (1877-1976), il filosofo e professore universitario ebreo che rifiutò di aderire al partito fascista, abbandonò l’università e si trasferì in Argentina, da dove mantenne una continua corrispondenza e collaborazione.
Negli anni Venti comparve l’opera omnia di Alfredo Oriani, voluta da Benito Mussolini che ne fu prefatore; tra il 1927 e il 1930 l’edizione critica delle opere di Giacomo Leopardi di Francesco Moroncini; negli anni Trenta la collana Classici del pensiero politico, curata da Giovanni Gentile, e tra il 1932 e il 1937 l’edizione nazionale degli scritti di Giuseppe Garibaldi.
Frescura, giornalista, autore e collaboratore, suggerì la pubblicazione de La coscienza di Zeno nel 1923, intervenendo, pare, sull’originale.
La Cappelli nel secondo dopoguerra
Superate le difficoltà della Seconda Guerra mondiale, la Casa editrice cavalcò l’onda della ricostruzione e della crescita economica e scolastica nel secondo dopoguerra, saldamente guidata dal fondatore, che nel 1946 aveva partecipato alla fondazione dell’AIE, l’Associazione Italiana degli Editori.
Alla morte di Licinio, avvenuta nel 1952, il figlio Carlo Alberto subentrò alla guida della Casa editrice nella quale entrarono i numerosi figli di Licinio, che ricoprirono diversi ruoli, dalla direzione delle librerie alla gestione della tipografia, a funzioni in Casa editrice, con esiti non sempre felici.
La Cappelli continuò a mantenersi un editore generalista, con una produzione molto estesa e diversificata, aggiungendo un interesse particolare per il teatro, il cinema e lo spettacolo, frutto del forte interesse di Carlo Alberto verso questo ambito.
Carlo Alberto fu infatti un impresario teatrale di grande rilievo, direttore del Teatro Comunale di Bologna e dell’Arena di Verona, ed è probabile che la sua attenzione all’andamento della Casa editrice sia stata minore rispetto a quello per l’attività teatrale.
Significative in questo senso sono pubblicazioni come quella di Andrea Camilleri, I teatri stabili in Italia (1898-1918), (1959), la collana Documenti di teatro diretta da Giorgio Guazzotti e Paolo Grassi, la collana L’Ippocampo, diretta da Giuseppe Longo, con scritti di Valgimigli, Marchesi, Trompeo, Cardarelli, Bartolini, Giusso ecc.
Di grande rilievo l’interesse per il cinema, grazie principalmente alla collaborazione con Renzo Renzi. Incarcerato in quanto autore del soggetto del film L’armata s’agapò, amico di Federico Fellini, per cui curerà i volumi usciti presso la Cappelli, nel 1956 Renzi dà vita alla celebre collana – riprodotta e tradotta in molti Paesi – Dal soggetto al film, che raccoglie i documenti preparatori, soggetti e/o sceneggiature. Renzi sarà anche tra i fondatori, nel 1967, della Cineteca di Bologna.
Fin dagli anni Cinquanta la Cappelli pubblica una Biblioteca universale tascabile che pubblicherà centinaia di titoli.
Solida fino al 1960, la Casa editrice dà i primi segni di difficoltà negli anni successivi, e già nel 1968 si parla di difficoltà che potrebbero essere insormontabili. Sembra mancare una guida ferma e la presenza di tanti parenti non sembra giovare alla buona gestione della società. Anche il parco dei collaboratori non viene rinnovato con sufficiente abilità: i volumi che escono sembrano talvolta prodotti per assecondare collaboratori storici piuttosto che per ragioni di opportunità di mercato. Il direttore editoriale, il letterato Mario Ramous, non riesce a mediare efficacemente e a compensare i limiti di capacità decisionale.
Quando entra in vigore la riforma della scuola media, la Casa editrice non è pronta ad adeguarsi ai nuovi programmi con la produzione di nuovi testi dedicati.
Tuttavia, sostenuta dal patrimonio familiare, la Casa editrice continua l’attività fino a che diviene inevitabile la cessione. La Cappelli non fallirà mai, perché la famiglia ne consentirà la liquidazione facendo fronte ai debiti.
La proprietà Milano
Nel 1977 subentra nella proprietà Nicola Milano, una figura che per molti aspetti ricorda quella di Licinio. Maestro elementare nel cuneese, padre di una numerosa famiglia, Nicola inizia prima l’attività di agente per la propaganda di testi per le scuole elementari, poi decide di produrli, fondando la casa editrice Nicola Milano. Il passo successivo è la commissione dei testi a compositori dispersi nel territorio e poi la stampa in proprio. Nasce così lo Stabilimento grafico Milano, a Farigliano, in provincia di Cuneo.
Nel 1977 Milano tenta di estendere il suo gruppo a una casa editrice di più ampio respiro rispetto al solo mercato per le elementari. Insieme a Rizzoli rileva la Sansoni di Firenze, in difficoltà, ma a seguito di una mancata intesa con Rizzoli nella gestione si orienta sulla Cappelli di Bologna.
La Casa editrice è affidata al figlio Giuseppe, e in seguito alla figlia Lia e al genero Mario Musso, che già guidavano con ottimi risultati la Nicola Milano, con sede a Milano, i quali si trasferiscono a Bologna.
La Cappelli della gestione Milano continua ad essere per molti anni un editore generalista, con ben quindici periodici, dalla storia, alla medicina, all’economia, alle lettere classiche; ventinove collane, oltre ai libri strenna fuori collana.
Il parco dei collaboratori si rinnova notevolmente, a partire dal direttore editoriale, l’esperto Umberto Magrini, che rimarrà fino alla metà degli anni Ottanta. Ci si affida a Piero Bertolini per la collana di pedagogia, e a Renzo Canestrari per la psicologia, a Pietro Bellasi per la collana forse più innovativa, Indiscipline, e a Francesco Campione per la rivista forse più innovativa, Zeta, dedicata al tema della morte. Viene ripresa la collaborazione con Renzo Renzi, in un primo tempo interrotta, e con lui si ripubblicano i libri di Federico Fellini.
Tuttavia il mercato dei libri di varia non risponde positivamente, dopo che nei primi anni Ottanta Magrini era stato affiancato per la varia – per un breve periodo – dal giovane Cesare Sughi, poi giornalista al «Resto del Carlino», e allora allievo di Luciano Anceschi e redattore presso Bompiani di «Sipario», la più prestigiosa rivista di teatro.
Negli anni Novanta la proprietà decide di limitare la produzione alla sola editoria scolastica, con un turn over di direttori editoriali che vedono il passaggio di Giulio Forconi, proveniente da Zanichelli, e poi di Massimo Manzoni, proveniente da Calderini.
Anche a livello di proprietà erano intervenuti negli anni Ottanta fatti nuovi, con l’ingresso nella governance dell’intero gruppo Milano (quindi anche della tipografia di Farigliano) di investitori arabi, che tenteranno il rilancio del gruppo e nel giro di pochi anni rinunceranno, restituendo la proprietà integrale alla famiglia Milano. Il mercato italiano si è rivelato troppo complesso per i nuovi arrivati, incapaci di affrontarlo se non con schemi astrattamente manageriali.
La Cappelli resiste al fortissimo processo di acquisizioni e di concentrazioni che caratterizza il ventennio 1990-2010, ma proprio con il passaggio del secolo una rilevante quota di minoranza della proprietà è ceduta alla Scuola di Brescia, che dieci anni dopo rileva l’intera società e la liquida.
Gli ultimi anni
La sede bolognese viene chiusa e il marchio Cappelli entra a far parte del gruppo bresciano, che nel luglio 2016 lo cede, consentendo il suo ritorno a Bologna, dove continua l’attività esclusivamente nella pubblicazione di testi scolastici.(fonte)