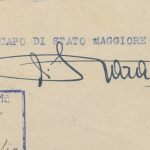ALLEGATO I.
Al Comando Deposito Centrale Truppe Coloniali
Ufficio Amministrazione
NAPOLI
OGGETTO: Dichiarazione per riscossione di assegni arretrati.
Il sottoscritto (1) Sgambato Carmine di Raffaele
(2) 1° Capo Squadra M. V. S. N.[1] – 6° btg. Cc. NN. D’Africa – cl- 1910
Già in servizio presso (3) Sezione Disinfezione – Amara . R. Gov. Amara – Gondar[2]
dichiara sotto la sua personale responsabilità ad ogni effetto di legge:
a) – di aver preso imbarco a Smirne sul piroscafo Argentina[3]
il giorno 9 maggio 1943
b) – di essere sbarcato a Nari il 15 . 5 . 943
(c – che la propria famiglia è composta come segue (4)
Sgambato Carmine – capofamiglia
Esposito Sansone Lucia – moglie
d) – di essere provvisto degli assegni relativi al grado Sergente Maggiore 2° scatto
a datare dal 1-12-941 (atto dispositivo dell’Ufficio Amministrazione del deposito Terri-
toriale -R. Gov. Amara – Gondar – in data 25 – 11 941 –
e) – di aver percepito regolarmente gli assegni a tutto il 15 – 11 – 941 – paga di
£. 14 giornaliere -/Sergente a 4 anni) dal (6) Comando della Sezione Disinfezione Amara[4]
R. Gov. Amara- Gondar –
f) – di essere caduto prigioniero il 27-11- 943[5] e di essere rimasto in soggezio-
ne del nemico fino al 8 – 5 – 943 data sotto la quale (7) venne effettuato
lo scambio dei prigionieri di guerra – personale protetto sanitario
g) – di aver durante la prigionia riscosso dallo stato nemico le seguenti somme quali asse-
gni dovuti ai prigionieri di guerra a norma delle convenzioni internazionali (8)
Dallo stato nemico non riscosse nessuna somma (assegni dovuti ai prigionieri
in guerra) ebbe solo in distribuzione un libretto paga il dicembre 1942 con sterline 28
a credito solamente poche volte-
h) – di aver riscosso inoltre le seguenti somme ai titoli e dagli enti a fianco indicati (9)
1.) N. 4 mensilità anticipate per decreto vicereale = £. 5.100 =
2.) ……………………………………………………………….
3.) ……………………………………………………………….
4.) ……………………………………………………………….
5.) ……………………………………………………………….
6.) ……………………………………………………………….
i) – che sui propri assegni gravano le seguenti ritenute (10) …………………
l) – di aver maturato e non fruito i seguenti periodi di licenz ordinaria coloniale (preci-
sare i periodi di permanenza in A. O. ai quali gli stessi si riferiscono)
dal 17 – 12 – 937 al 27 – 11 – 941 = data di cattura
m) – che l’ultima licenza fruita ebbe inizio il giorno ………..
e termine il giorno ………………..
S. Felice a Comello li 16 – 8 – 943
(Napoli)
IL DICHIARANTE (11)
Sgambato Carmine
Eventuali maggiori chiarimenti che l’interessato ritenesse necessario fornire in merito
alla sua posizione
Lo scrivente espone quanto appena(?) indicato
1.) Dal Comando della Sezione disinfezione Amara Gondar, percepì a tutto il
15-1-941 la paga da sergente a 4 anni;
2.) in data 1-11-41 con foglio del Comando Truppe – R. Gov. Guerra – Ufficio Perso-
nale ottenne la promozione a Sergente Maggiore (1° Capo Squadra M.V.S.N.)
con anzianità dal 25-11-941;
3.) Con atto dispositivo in data 25 – 11 – 41 dell’Ufficio Amministrazione Deposito
Territoriale – R. Gov. Amara – Gondar, venne ammesso allo scatto paga
di 9 anni di £. 19 giornaliere, con decorrenza dal 1-12-941 =
Per quanto sopra è opportuno che codesto Comando tenga
presente che l’interessato in seguito alla cattura, non poté né riscuotere
la seconda quindicina del mese di novembre 1941, né fece in tempo
poter godere della paga di £. 19 giornaliere dal mese di dicembre 9
stesso anno =
IL DICHIARANTE (11)
Sgambato Carmine
Attestazione dell’autorità che riceve la dichiarazione
Attesto che il Sig. Sgambato Carmine
ha steso e firmata la presente dichiarazione in mia presenza, previa esibizione del seguente
documento di riconoscimento
e del quale ho preso personalmente visione.
Arrivo da Bari(?) li 17-8-1943[6]
nulla osta
v.m
NOTE: (1) Cognome, nome e paternità.
(2) Grado e categoria di appartenenza e classe.
(3) Indicare l’ultimo comando e reparto di appartenenza, la dislocazione ed il Governo dal quale dipendeva.
(4) Indicare i nomi e l’attuale recapito delle persone delle persone di famiglia. Il grado di parentela e la data di nascita per i figli a carico. Specificando se e quali di dette persone sono con lui rimpatriate.
(5) Indicare anche se con stipendio o paga iniziale ovvero con il 1, 2, 3, ecc. aumento periodico.
(6) Indicare l’ente che ha provveduto al pagamento.
(7) Precirare la posizione in cui l’interessato si è venuto a trovare. Qualora il militare o militarizzato non sia stato mai catturato prigioniero cancellare il testo della lettera f) ed indicare la posizione in cui e venuto a trovarsi dalla data in cui ha cessato di prestare servizio al reparto di appartenenza.
(8) Indicare le somme riscosse, la valuta ed il periodo cui si riferiscono. Nel caso che non abbià avuto luogo alcuna riscossione dovrà essere esplicitamente dichiarato «di non avere dallo stato nemico riscosso alcuna somma» aggiungendo però se dalle autorità nemiche sia stata ricevuta la somministrazione gratuita del vitto.
(0) Indicare; a) mensilità anticipate per decreto vicereale; b) somme eventualmente ricevute dai comitati di assistenza in conto assegni; c) somme eventualmente riscosse sotto qualsiasi forma all’atto dell’occupazione nemica e durante la permanenza nei territori occupati in conto assegni del grado militare, precisando quelle eventualmente ricevute da autorità nemiche all’infuori delle somme di cui alla lettera g); d) altre somme comunque riscosseprecisandone la causale: vendita di materiali mobili di pertinenza dell’Amministrazione ecc; e) sussidi eventualmente ricevuti durante l’occupazione.
(10) Indicare le ritenute: cessioni di stipendio (precisare la scadenza nonché l’Istituto cessionario); assicurazione; unione militare I N C. I. S. ecc.
(11) Firma e indirizzo.
segnatura a matita
3 copie 1620
Note
[1] La Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (MVSN), spesso genericamente identificata con la locuzione camicie nere dalle camicie di colore nero adottate quale parte della divisa, è stata un corpo di gendarmeria a ordinamento militare che dal 1924 entrò a far parte delle forze armate del Regno d’Italia e che fu sciolto dopo la firma dell’armistizio di Cassibile, nel settembre del 1943.
Storia
Origini
La MVSN affonda le sue radici nella milizia politica, elemento centrale della rapida ascesa del fascismo tra il 1920 e il 1921, grazie all’uso sistematico della violenza politica organizzata. Tradizioni di milizie politiche erano già presenti nei movimenti giacobini, liberali e socialisti del XIX secolo, ma si svilupparono molto coi movimenti fascisti europei. In Italia, l’idea delle “camicie” paramilitari risale a Giuseppe Garibaldi. L’innovazione fascista fu la creazione di una milizia strutturata, aggressiva e altamente organizzata, ispirata in parte ai bolscevichi russi.
Durante l’ascesa del fascismo nel 1919-1921, la spinta degli squadristi indusse Mussolini a trasformare il movimento in “partito milizia”. Il Partito Fascista ereditò dallo squadrismo struttura, ideologia e stile di lotta, fondando la militanza su patriottismo, cameratismo, etica del combattimento e gerarchia. Questa ideologia e approccio organizzativo divennero centrali al movimento prima, e al regime poi. La strutturazione in partito-milizia rese il fascismo un movimento nazionalista di massa innovativo, nato in una democrazia parlamentare con l’obiettivo dichiarato di distruggerla e instaurare uno Stato autoritario, gerarchico e militarizzato.
Il Partito Fascista consolidò il suo predominio in molte regioni dell’Italia settentrionale e centrale grazie alla violenza, al sostegno della borghesia nazionalista e alla tolleranza delle autorità, che lo vedevano come difensore dell’ordine. Nel 1922, con oltre 200.000 iscritti, una milizia armata, organizzazioni femminili e giovanili, e sindacati con mezzo milione di aderenti, il PNF divenne la forza politica più potente del paese, agendo come un “anti-Stato” mentre gli altri partiti erano in crisi.
Costituzione ed evoluzione istituzionale
La MVSN fu costituita accorpando le Squadre d’azione del Partito Nazionale Fascista (Camicie nere) e la milizia dei Sempre Pronti per la Patria e per il Re dell’Associazione Nazionalista Italiana (Camicie azzurre). La sua fondazione fu decisa ed annunciata dal Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 1922, presieduto da Benito Mussolini, e decretata dal re Vittorio Emanuele III con regio decreto-legge 14 gennaio 1923, n. 31, (poi convertito in legge il 17 aprile 1925) entrato in vigore il 1º febbraio 1923.
Nella fase di ascesa al potere, la costituzione della milizia permise a Mussolini di rafforzare il controllo politico e istituzionale sul partito e sull’ordine pubblico. La milizia reclutava volontari provenienti dalle formazioni fasciste, con gradi inferiori affidati a squadristi e superiori a ufficiali dell’esercito. Inizialmente fu pensata come milizia ad uso esclusivo del PNF (rispondeva solo al Capo del governo e a lui solo era dovuto il giuramento, in contrasto con l’obbligo per l’esercito di giuramento al sovrano).
Lo scopo era duplice: legalizzare e stabilizzare la forza armata fascista, accollandone i costi allo Stato, e controllare lo squadrismo, eliminando elementi più turbolenti e riducendo l’influenza dei capi squadristi. La costituzione della MVSN rappresentò una tappa chiave nell’integrazione del Partito Fascista negli organi dello Stato (assieme al riconoscimento del PNF nel 1928 come istituzione pubblica ausiliaria dello Stato, e alla costituzione del Gran Consiglio del Fascismo come organo misto, sia del partito che dello Stato).
L’istituzione della Milizia incontrò resistenze da parte dei dirigenti fascisti locali, che temevano di perdere il controllo dello squadrismo e il proprio potere politico, mentre antifascisti e conservatori iniziarono a richiedere la “normalizzazione” e la soppressione della Milizia. Dopo la crisi del delitto Matteotti, Mussolini fu costretto a riformarla con il decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, che dava un nuovo ordinamento generale alla MVSN. Questa veniva dichiarata parte integrante delle forze armate dello Stato, con giuramento al re e ufficiali in parte provenienti dall’esercito. Tuttavia, la Milizia mantenne un’ambiguità strutturale, diventando sempre più un organo burocratico piuttosto che uno strumento rivoluzionario.
La MVSN assolveva tre principali compiti: il controllo e la repressione della dissidenza attraverso indagini, tribunali speciali e milizie specializzate; l’educazione ideologica e l’istruzione premilitare della gioventù fascista per creare una “nazione armata” e formare l’”uomo nuovo,” un’élite guerriera e patriottica; infine, la mobilitazione di giovani per campagne militari, affiancando l’esercito con i battaglioni di Camicie Nere in operazioni coloniali e servizi di artiglieria.
Con il consolidamento del controllo del regime sull’apparato statale, la MVSN perse progressivamente il legame con il partito e generò tensioni con autorità politiche, esercito e partito stesso. Considerata superflua rispetto all’esercito e marginale nelle attività di polizia politica, la milizia assunse un ruolo prevalentemente amministrativo e coreografico. Nonostante le sue funzioni si estesero in numerosi settori (milizia ferroviaria, milizia portuaria, milizia postale telegrafica, milizia forestale, milizia della strada), nel tempo fu sempre più integrata nell’esercito, perdendo la sua identità rivoluzionaria, mentre l’esercito stesso veniva fascistizzato. Divenne un costoso apparato privo di un ruolo distintivo nel regime.
Dopo la caduta del fascismo, fu sciolta, con il Regio Decreto Legge del 6 dicembre 1943, n. 16/B, dal governo Badoglio I.
Organizzazione
La Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale fu concepita tramite una commissione di studio incaricata da Benito Mussolini e composta da Emilio De Bono, Cesare Maria De Vecchi, Aldo Finzi, Italo Balbo e Attilio Teruzzi. La commissione realizzò un progetto sulla formazione e organizzazione di un corpo di volontari, inquadrato nell’esercito nazionale mediante regolare reclutamento, in una fascia di età compresa tra i 17 e i 50 anni, analogamente ad altri Stati che godevano di altrettante milizie. Questo avvenne per i primi quattro anni. Il servizio di leva obbligatorio poteva essere svolto anche all’interno della milizia. Il primo comandante generale fu Emilio De Bono, con due comandanti generali, Cesare Maria De Vecchi e Italo Balbo, tutti quadrumviri della Marcia su Roma.
La M.V.S.N. era organizzata territorialmente e inizialmente basata sul volontariato, composta da iscritti al Partito Nazionale Fascista tra i 16 e i 50 anni, inclusi reduci della Prima Guerra Mondiale e ufficiali del Regio Esercito, promossi di un grado dopo l’adesione. Dal 1927, l’iscrizione divenne obbligatoria secondo i precetti della leva fascista, reclutando direttamente gli avanguardisti al compimento dei 18 anni (20 anni dal 1930). Dopo i 36 anni, i militi venivano assegnati alle unità territoriali come triari fino ai 55 anni. In caso di mobilitazione, era possibile arruolarsi volontariamente nella M.V.S.N. come alternativa al servizio militare nel Regio Esercito.
Sebbene le cifre siano approssimative, si stima che il numero dei membri sia cresciuto da 190 000 nel 1923 a circa 950 000 nel 1940. Circa un quarto degli ufficiali effettivi proveniva dallo squadrismo e dagli ufficiali di complemento disoccupati dopo la guerra. La maggioranza dei membri era composta da volontari non retribuiti, mobilitati per istruzione militare, manovre, parate e interventi in calamità pubbliche. Dal 1930, i giovani venivano reclutati durante la Festa della Leva CCNN, celebrata il 24 maggio, attirando soprattutto meridionali e disoccupati grazie a benefici come assistenza sanitaria, sussidi, premi e attività sportive. Durante l’impresa etiope del 1935-1936, la M.V.S.N. reclutò oltre 100 000 operai.
L’organizzazione della Milizia si articolava su un comando generale (il comandante generale era Benito Mussolini, con il grado di Primo caporale d’onore; alle sue dipendenze il capo di stato maggiore, preposto a reggere il comando generale). Il territorio del regno era ripartito in quattro raggruppamenti (Milano, Bologna, Roma, Napoli) al comando di luogotenenti generali. Ogni comando di raggruppamento aveva alle proprie dipendenze un certo numero di gruppi (33 in totale) retti da consoli generali e a sua volta più gruppi costituivano un comando di zona. Ciascun comando di gruppo aveva alle proprie dipendenze un certo numero di legioni ordinarie (120 in tutto) comandate da consoli.
La struttura della M.V.S.N. era a ordinamento ternario: ogni legione si componeva di tre coorti, a loro volta formate da tre centurie; ogni centuria era formata da tre manipoli e ogni manipolo da tre squadre. Dopo alcune modifiche sostanziali all’ordinamento, susseguitesi tra 1929 e il 1935, nel 1939 si tornava alla struttura di partenza.
Un gruppo di legioni corrispondeva a una brigata, la Legione corrispondeva a un reggimento, la coorte al battaglione, la Centuria alla compagnia, il manipolo al plotone e alla squadra, con terminologia di ovvia origine romana. Anche i gradi si richiamavano all’antica Roma: i colonnelli della M.V.S.N. erano chiamati consoli, i capitani centurioni e così via.
La M.V.S.N. era costituita dalla Milizia ordinaria e da quelle speciali. Le specialità della M.V.S.N. erano: Forestale, Stradale, Ferroviaria, Postelegrafonica e Portuale. Alla Milizia ordinaria appartenevano la Milizia Confinaria, quella Coloniale e la Milizia Universitaria, che aveva compiti d’istruzione premilitare.
Nel 1930 vennero aggiunte la Milizia per la difesa contraerea (prima D.A.T., poi DICAT) e la Milizia Marittima (MilMart). Per quanto concerne gli ufficiali, vi erano quelli in servizio permanente effettivo, quelli inclusi nei cosiddetti quadri (non abitualmente in servizio, ma richiamabili) e quelli compresi nella riserva. Il sistema prevedeva la possibilità per gli ufficiali generali e superiori, nonché per i centurioni, di transitare a domanda da altre Forze armate alla Milizia. Il Comando generale, delegato per legge, provvedeva alla nomina degli ufficiali.
Il servizio svolto dai miliziani della MVSN fino al grado di caposquadra (che corrispondeva grosso modo a quello di sergente) non era di carattere continuativo, ma si basava su chiamate periodiche, in genere in vista di particolari eventi o per ragioni addestrative. La mobilitazione generale era di esclusiva competenza di Mussolini.
Struttura
Lo stesso argomento in dettaglio: Organizzazione della MVSN nel 1928 e Organizzazione della MVSN nel 1940.
L’organizzazione di tale corpo, oltre ad avere una propria progressione di carriera (succedeva ad esempio che il gerarca Achille Starace fosse contemporaneamente console generale della Milizia e colonnello del Regio Esercito), non poteva prescindere da una propria struttura amministrativa e sanitaria; ugualmente per quanto concerne i cappellani militari.
Squadra (Squadra) = comandata da un caposquadra (sergente)
Manipolo (Plotone) = comandata da un capomanipolo (tenente)
Centuria (Compagnia) = comandata da un centurione (capitano)
Coorte (Battaglione) = comandata da un seniore (maggiore)
Legione (Reggimento) = comandata da un console (colonnello)
Gruppo di Legioni (Brigata) = comandate da un console generale (generale di Brigata)
Zona (Divisione) = comandata da un ispettore generale di zona poi luogotenente generale (generale di Divisione)
Le specialità della Milizia ordinaria
In seno alla Milizia ordinaria erano altresì presenti:
Milizia coloniale: compiti di polizia nelle colonie
Milizia confinaria: compiti di polizia di frontiera in concorso con l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza
Milizia artiglieria contraerea: compiti di difesa dello spazio aereo italiano unitamente alle altre unità delle Forze armate
Milizia marittima di artiglieria: compiti di difesa costiera
Milizia fascista albanese: compiti di polizia in Albania
Milizia ruolo medico: servizio sanitario autonomo della Milizia
Assistenza spirituale della Milizia: ruolo cappellani
A questi si aggiungono i ruoli della Milizia in supporto alle organizzazioni giovanili del Partito Nazionale Fascista:
Milizia ruolo Opera nazionale balilla
Milizia ruolo Fasci giovanili di combattimento
Milizia ruolo Gioventù italiana del littorio
Le Milizie speciali
A fianco della Milizia ordinaria erano presenti le seguenti Milizie speciali:
Milizia ferroviaria: compiti di vigilanza sul demanio ferroviario
Milizia forestale: compiti di tutela del patrimonio boschivo
Milizia portuaria: compiti di vigilanza sul demanio portuale e marittimo
Milizia postelegrafonica: compiti di servizio postale e polizia amministrativa
Milizia della strada: compiti di polizia stradale
Moschettieri del Duce: guardia d’onore di Mussolini a palazzo Venezia
Milizia universitaria: reparto studentesco universitario
Reparto stampa della Milizia
Anche la Milizia era dotata di un Ufficio centrale stampa e propaganda con sede presso il comando generale della Milizia. Del comando di questo ufficio fu incaricato il luogotenente generale Auro d’Alba che la strutturò in quattro sezioni:
Ufficio stampa interna ed estera
Ufficio propaganda
Ufficio storico
Gabinetto cine-fotografico
L’Ufficio stampa provvedeva alla regolare pubblicazione del quindicinale Foglio d’Ordini che funzionava da notiziario divulgativo sull’attività della Milizia e del periodico settimanale Milizia Fascista. Vennero create anche delle biblioteche di legioni che erano sotto il diretto controllo dell’Ufficio stampa e propaganda. L’Ufficio storico provvide alla compilazione degli albi d’oro dei caduti e dei decorati, con 367 nominativi il primo volume e con 333 nominativi il secondo volume. Il gabinetto cine-fotografico comprendeva una biblioteca, una emeroteca e una fototeca.
Divise
Le camicie nere indossavano la stessa uniforme dell’esercito italiano con l’aggiunta di camicia e cravatta nera e un fez nero. La giacca dell’uniforme aveva fiamme nere con due estremità sul colletto al posto delle insegne e i fasci dei littori al posto delle stelle dell’esercito. C’era un’uniforme tutta nera indossata da alcuni ufficiali e dai Moschettieri del Duce, la guardia d’onore di Palazzo Venezia.
L’impiego bellico
Il primo scenario operativo della Milizia può essere considerato quello libico, nel settembre del 1923, quando, a fianco delle Milizie speciali e delle legioni territoriali, vennero create delle legioni destinate a combattere in Libia, dove tre legioni presero parte agli scontri di Beni Ulid, El Regima, El Zuetina e Got el Sass. Il buon rendimento profuso dai reparti convinceva il governo a costituire due legioni stanziali sulla cosiddetta quarta sponda: una a Tripoli e l’altra a Bengasi.
La I legione della Milizia coloniale, reclutata in Sardegna, diede invece pessimo rendimento. Innanzi tutto era stata reclutata all’esterno del partito fascista, vista la scarsità di fascisti nell’isola, e anzi era servita come mezzo propagandistico per aggregare intorno al nascente regime delle simpatie. Per ottenere un buon numero di reclute tra i numerosi reduci della prima guerra mondiale senza impiego era stata promessa una paga di 17 lire al giorno (contro le 7 dei militari), ottenendo quindi un buon numero di adesioni; poi l’unità era stata portata in Africa settentrionale dopo un troppo breve periodo di addestramento e, al momento del primo incontro con il nemico, constatato che la paga percepita era di sole 7 lire e non 17 come promesso, si era ammutinata.
Gli ufficiali avevano completamente perso il polso della situazione e solo l’intervento delle unità del Regio Esercito volse a ripristinare una parvenza di ordine. La legione venne quindi ripartita in centurie presso altri reparti, e reimbarcata verso la Sardegna poco dopo, dove venne sciolta in maniera ingloriosa.
Dopo aver giurato fedeltà a Vittorio Emanuele III, il 28 ottobre 1924, la Milizia si occupava prevalentemente della formazione militare delle giovani schiere e partecipava ad alcune operazioni di soccorso a favore di popolazioni colpite da calamità naturali (Valtellina, 1926). Nel 1934 si rafforzava l’integrazione col Regio Esercito attraverso delle esercitazioni congiunte.
Guerra d’Etiopia 1935-1936
Il vero battesimo del fuoco giungeva nel 1935, durante la guerra d’Etiopia, dove la Milizia arrivò a dislocare sette divisioni e due gruppi di battaglioni, più alcuni reparti minori. Poiché le grandi Unità della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale non disponevano né artiglierie né servizi, venne chiesto al Capo di stato maggiore e sottosegretario alla Guerra Baistrocchi che le divisioni CC. NN. fossero completate ed equipaggiate dal Regio Esercito. Baistrocchi non si oppose, ma a condizione che l’addestramento dei militi e dei reparti venisse rivisto e fosse effettuato sotto la sovrintendenza dello Stato Maggiore del Regio Esercito, e che comandante, vicecomandante e capo di Stato Maggiore delle divisioni della M.V.S.N. fossero ufficiali dell’esercito e non della Milizia. A ogni modo la Milizia poteva schierare le proprie grandi unità a fianco di quelle dell’esercito e va anche detto che il comando della 5ª Divisione CC.NN. “1 febbraio” andò a un ufficiale della M.V.S.N., il luogotenente generale Attilio Teruzzi.
Le divisioni Camicie Nere erano strutturate su tre legioni, la cui consistenza era però inferiore a quella dei reggimenti del Regio Esercito, avendo due battaglioni anziché tre. A ciascuna legione era aggregata una compagnia mitraglieri e una di artiglieria someggiata con pezzi da 65/17. Ogni battaglione CC.NN. comprendeva tre compagnie, ciascuna con sei mitragliatrici leggere. Il battaglione aveva un organico nominale di 20 ufficiali, 650 tra sottufficiali e militi, 52 quadrupedi, 2 autocarri e 18 mitragliatrici leggere. La compagnia comprendeva tre plotoni moschettieri. Ogni divisione Camicie Nere era rinforzata da reparti del Regio Esercito: un gruppo d’artiglieria su tre batterie più la compagnia comando, recante il numero della divisione.
La chiamata alle armi in occasione delle operazioni nel Corno d’Africa, incominciate il 3 ottobre del 1935, coinvolgeva circa 5.611 ufficiali e 162.390 camicie nere, secondo altre fonti circa 3.751 ufficiali e 112.000 militi, secondo altre ancora in totale, su 167.000 Camicie Nere mobilitabili ne vennero inviate in Africa 117.000. La campagna militare in Africa orientale si concluse sette mesi dopo con l’entrata ad Addis Abeba delle truppe italiane e con circa 1.290 caduti per la Milizia. Parte dei militi che avevano partecipato al conflitto rientravano quindi in Italia, altri invece rimanevano in loco con compiti di polizia coloniale.
Le divisioni CC. NN. create per l’Africa Orientale utilizzarono la normale terminologia militare per le unità minori, compagnia anziché centuria, plotone anziché manipolo, mentre per quelle maggiori si continuarono a usare gruppo e legione al posto di battaglione e reggimento. Le legioni mobilitate per l’Africa Orientale ebbero il proprio numerale aumentato di cento: così la 1ª Legione “Sabauda” di Torino divenne 101ª Legione, la 80ª Legione “Alessandro Farnese” di Parma, 180ª Legione e così via.
Le divisioni Camicie Nere mobilitate furono sette. Le prime cinque “23 marzo”, “28 ottobre”, “21 aprile”, “3 gennaio” e “1º febbraio” erano su tre legioni, mentre la 6ª Divisione CC.NN. “Tevere”, che operò in Somalia, ebbe quattro legioni e la 7ª Divisione CC.NN. “Cirene”, di presidio in Libia, ne ebbe otto.
In particolare si distinse la Divisione “28 ottobre”, con il 1º Gruppo battaglioni CC.NN. d’Africa al comando del console generale Filippo Diamanti, che nel corso della 1ª battaglia del Tembien nel combattimento per il controllo di Passo Uarieu, praticamente senza interruzione e senza che, in quel periodo, arrivassero rifornimenti di nessun genere alle truppe italiane assediate, resistette per tre giorni, dal 21 al 24 gennaio 1936, fermando i ventiquattromila uomini di ras Cassa e di ras Sejum. Fra i caduti della colonna Diamanti padre Reginaldo Giuliani, cappellano militare, ucciso mentre impartiva l’assoluzione ai morenti.
Al termine della guerra, molte unità di Camicie Nere rimasero in Africa Orientale con compiti i polizia coloniale e di controguerriglia.
Guerra di Spagna 1936-1939
Nel 1936 con l’inizio della guerra civile spagnola, si costituiva il Corpo truppe volontarie italiane, inviato in appoggio alle forze del generale Francisco Franco. Di tale contingente, circa 20.000 unità erano militi inquadrati su tre divisioni (“Dio lo vuole!”, “Fiamme Nere” e “Penne Nere”), che nel 1937 saranno ridotte a due divisioni e successivamente a una, a cui se ne affiancherà un’altra fornita dal Regio Esercito (4ª Divisione fanteria “Littorio”). Nel 1938 anche l’ultima divisione della Milizia veniva smobilitata; permanevano invece sul territorio spagnolo alcune unità minori di camicie nere. I volontari della Milizia furono protagonisti nella conquista di Malaga e Bilbao e ancora nelle battaglie dell’Ebro e di Santander, nonché a Guadalajara, Tortosa e Levante, per poi entrare a Madrid assieme ai nazionalisti di Francisco Franco. La guerra civile spagnola si concludeva il 1º aprile 1939; la Milizia annoverava tra i suoi caduti circa 3.298 persone.
L’occupazione dell’Albania
Lo stesso argomento in dettaglio: Occupazione italiana dell’Albania (1939-1943).
Nel 1939 sei battaglioni della Milizia partecipavano all’Occupazione italiana del Regno di Albania. Nello stesso anno era costituita l’omologa milizia albanese, retta da ufficiali italiani e albanesi, che in seguito sarà impiegata sul fronte greco.
All’armistizio dell’8 settembre 1943 erano presenti in Albania la 80ª “Farnese”, la 92ª “Ferrucci”, la 109ª “Corridoni” e la 115ª “Del Cimino” più l’8° e il 29° Btg M.
La MVSN nella seconda guerra mondiale 1940-1943
Lo stesso argomento in dettaglio: Organizzazione della MVSN nel 1940 e Battaglioni M.
Alla vigilia della seconda guerra mondiale in Italia e nelle Colonie vi erano 132 legioni. Ogni legione territoriale era strutturata su due battaglioni, uno attivo, formato dai militi dai ventuno ai trentasei anni, destinato in caso di mobilitazione all’impiego in linea, e un secondo formato dai militi più anziani, dai quaranta ai cinquantacinque anni, destinato a compiti di difesa territoriale; a essi si affiancavano il battaglione complementi e i reparti ausiliari. Quando mobilitato, il I° battaglione assumeva il numerale romano della legione d’appartenenza: ad esempio, la 63ª Legione “Tagliamento” venne mobilitata con il I° battaglione dell’omonima legione di Udine, che prese la denominazione di LXIII° e dal I° battaglione della 79ª Legione Cispadana di Reggio Emilia, che assunse il numero romano LXXIX°.
All’entrata in guerra dell’Italia, il 10 giugno 1940, vennero mobilitati circa 220 battaglioni (seguiti poi da altri 81 battaglioni costieri, 51 territoriali e 29 compagnie costiere) della MVSN, nelle varie specialità, e impiegati su tutti i fronti inquadrati in quattro divisioni: la 1ª Divisione CC.NN. “23 marzo”, la 2ª Divisione CC.NN. “28 ottobre”, la 3ª Divisione CC.NN. “21 aprile” e la 4ª Divisione CC.NN. “3 gennaio”. Tutte le 4 grandi unità al momento della dichiarazione di guerra erano stanziate in Africa settentrionale. La 1ª la 2ª e la 4ª presero parte alla prima fase della guerra in Libia mentre la 3ª venne smembrata e i suoi reparti servirono per completare le altre 3 grandi unità.
Di tale novero, circa 85.000 uomini erano in forza alla Milizia artiglieria contro aerei, inquadrati in 22 legioni. La Milizia artiglieria marittima, subordinata alla Regia Marina, si articolava invece su 10 legioni; gli organici erano di eterogenea provenienza: in genere ufficiali artiglieri in congedo e individui esenti dagli obblighi militari.
In base alla struttura organizzativa prebellica, la Milizia doveva mobilitare una legione d’assalto da aggregare a ciascuna divisione di fanteria ordinaria del Regio Esercito (quindi escluse le divisioni motorizzate, autotrasportabili e alpine). Ciascuna legione d’assalto era costituita da 2 battaglioni d’assalto (mobilitati ciascuno da una diversa legione territoriale) e da una compagnia mitraglieri. A causa del numero insufficiente di battaglioni d’assalto disponibili per carenze di organico, addestrative e di equipaggiamenti all’inizio della guerra la maggioranza delle divisioni di fanteria del Regio Esercito avevano tuttavia un solo battaglione di Camicie Nere, e alle volte neppure quello, mancanza che venne comunque colmata nel corso del conflitto.
La Milizia mobilitò inoltre quattro divisioni composte interamente da “camicie nere” (eccetto artiglierie e servizi, forniti dal Regio Esercito) per la Libia, ma una di queste venne sbandata prima dell’inizio delle operazioni per rinforzare le altre tre. Successivamente la Milizia mobilitò diversi raggruppamenti (Grecia, Russia, Difesa del Territorio Nazionale), unità circa equivalenti a una brigata di fanteria e utilizzate prevalentemente come elementi della riserva di corpo d’armata o di armata.
Nell’ottobre 1941 nacquero su spinta dell’allora capoufficio coordinamento della MVSN console generale Virgilio Nurchis anche i Battaglioni M, reparti d’élite formati dai battaglioni d’assalto e da montagna della Milizia che si erano particolarmente distinti in combattimento.
Nell’estate 1942 per la progettata invasione di Malta, (Operazione C3) fu creato un raggruppamento speciale da sbarco di camicie nere da affiancare al Reggimento San Marco, con i seguenti reparti: XLII Battaglione CC.NN. da sbarco “Vicenza”, XLIII Battaglione CC.NN. da sbarco “Belluno”, L Battaglione CC.NN. da sbarco “Treviso”, LX Battaglione CC.NN. da sbarco “Pola”. Si addestrarono in Corsica, ma l’operazione fu bloccata nel novembre 1942.
Grecia
Lo stesso argomento in dettaglio: Campagna italiana di Grecia.
Dall’ottobre 1940 alla fine della campagna di Grecia nell’aprile del 1941, la MVSN impiegò in combattimento ben 56 battaglioni. Le perdite subite furono ingentissime se si considera che ben 27 battaglioni andarono persi e fra questi 7 vennero sciolti perché ridotti agli estremi. Alla fine della tremenda campagna i battaglioni che maggiormente si erano distinti vennero trasformati in battaglioni M che da allora costituirono il fior fiore dei reparti combattenti della MVSN. Loro distintivo di onore erano le “M” rosse nella grafia di Mussolini traversate da fascetti dorati, indossate sulle mostrine nere. Nel loro inno essi si definiscono “battaglioni della morte creati per la vita”.
I primi battaglioni a trasformarsi in “M” furono i battaglioni del raggruppamento del generale Galbiati e i 2 della 15ª Legione CC.NN. d’Assalto “Leonessa” che inquadrava militi provenienti dalle zone del bresciano. Successivamente il settore balcanico assorbirà lo sforzo di circa 144 battaglioni in compiti di guarnigione tra il 1941 e il 1943.
All’armistizio dell’8 settembre 1943 erano presenti in Grecia la 23ª “Bersaglieri del Mincio”, 28ª 45ª “Alto Adige”, la 112ª “Dell’Urbe”, la 136ª “Tre Monti” e la 166ª “Peloro” più il 18° Btg M. Nelle isole dell’Egeo vi erano inoltre a Rodi la 201ª “Conte Verde” e a Creta la 201ª “Capuana” affiancata dal 141° Btg autonomo “Creta”.
Nord Africa
Lo stesso argomento in dettaglio: Campagna del Nordafrica.
In Nordafrica, le tre divisioni di camicie nere presenti subivano nel dicembre 1940 l’offensiva delle forze inglesi, che giungevano a occupare la Cirenaica. Nell’ambito dell’operazione sopra citata tutte e tre furono distrutte in combattimento e non più ricostituite. Il X Battaglione d’Assalto “M” venne trasferito in Tunisia nel febbraio 1943 e assegnato sulla linea difensiva del Mareth fino alla resa delle forze dell’Asse in Africa avvenuta nel maggio dello stesso anno.
Africa Orientale Italiana
Lo stesso argomento in dettaglio: Campagna dell’Africa Orientale Italiana.
In Africa orientale le forze della MVSN (circa trenta battaglioni), inquadrate nelle Forze armate dell’Africa Orientale Italiana, presero parte a tutte le fasi della campagna, dall’invasione italiana della Somalia britannica, alla battaglia di Cheren alla (battaglia di Gondar nel novembre del 1941). Alla data del 10 giugno 1940 giorno della dichiarazione di guerra a Francia e Gran Bretagna, alla difesa dell Africa Orientale Italiana erano preposti complessivamente 255.950 uomini, di cui 26.643 appartenevano alla MVSN.
Fronte orientale
Lo stesso argomento in dettaglio: Reparti italiani al fronte orientale.
Undici battaglioni della Milizia parteciparono ai combattimenti sul fronte russo all’interno del Corpo di spedizione italiano in Russia prima e dell’ARMIR dopo. Le offensive sovietiche condotte sul fronte orientale nel corso del 1942 vedevano la distruzione di gran parte di questo contingente (rimanevano sul campo circa il 90% dei comandanti di battaglione, il 70% degli ufficiali e il 55% dei militi).
Difesa del territorio nazionale
Nell’estate stesso anno, alcuni battaglioni d’assalto e costieri della MVSN partecipavano alla difesa delle coste siciliane dallo sbarco alleato.
Nel maggio del 1943 nasceva la 1ª Divisione corazzata CC.NN. “M”, composta da circa 5.700 uomini e costituita su una ossatura di veterani del fronte greco e russo integrati da giovani volontari. In base a un accordo diretto tra il Comando generale della Milizia e le Schutzstaffeln, i tedeschi fornirono il materiale pesante, ossia 36 mezzi corazzati (carri armati Panzer IV Ausf. G e Panzer III Ausf. N e cannoni d’assalto Sturmgeschütz III) e 18 cannoni Flak 36 da 88 mm. Dopo la caduta del fascismo (25 luglio 1943) la divisione passò sotto il controllo del Regio Esercito, venne epurata dai suoi elementi più marcatamente fascisti e fu ribattezzata 136ª Divisione corazzata “Centauro II”. Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 venne disarmata dai tedeschi che si riappropriarono dei suoi equipaggiamenti pesanti.
La caduta del fascismo
Alla caduta del regime fascista, il 25 luglio 1943, nonostante qualche reazione isolata da parte di singoli plotoni, la maggioranza dei reparti della MVSN rimaneva in attesa di ordini da parte del Comando generale. Lo stesso battaglione M di Como, in marcia su Roma, veniva fermato poco lontano dalla capitale in seguito a un ordine impartito dal capo di stato maggiore della Milizia, generale Galbiati.
La Divisione M riceveva l’ordine tra il 25 e il 26 luglio 1943 di continuare l’attività di addestramento. Tale reparto si era peraltro messo in contatto con il comando della 3. Divisione Panzergrenadier, onde coordinare un’eventuale reazione armata, ma la cosa era rimasta lettera morta. Di lì a poco il generale Galbiati usciva di scena, lasciando l’incarico di capo di stato maggiore al generale del Regio Esercito Conticelli. Il maresciallo d’Italia Pietro Badoglio dava quindi l’ordine alla Milizia di rimuovere i fasci dal bavero della giubba e di sostituirli con le stellette.
Nominò quale comandante generale il generale Quirino Armellini, che prendeva così il posto di Benito Mussolini. La stessa sorte subivano tutti i comandanti delle Milizie speciali, rimpiazzati con alti ufficiali del Regio Esercito o dell’Arma dei Carabinieri. Le legioni d’assalto di camicie nere aggregate alle divisioni del Regio Esercito furono brevemente rinominate come unità “legionarie” e successivamente incominciarono a essere assorbite come terzo Reggimento di fanteria divisionale (trasformazione ancora in corso nella maggioranza delle divisioni al momento dell’armistizio).
Lo scioglimento
Con l’armistizio dell’8 settembre 1943, la Milizia si dissolse nello sbandamento generale delle Forze armate italiane. I reparti schierati nel nord della penisola, in Francia e nei Balcani aderirono in gran parte alla Repubblica Sociale Italiana. I reparti della MVSN passati alla RSI, comandati dal 15 settembre da Renato Ricci, furono quindi assorbiti l’8 dicembre 1943 dalla Guardia Nazionale Repubblicana.
Nel Regno del Sud il 6 dicembre 1943 il re, su proposta del Capo del governo Badoglio, decretava lo scioglimento definitivo della Milizia a partire dal 9 dicembre, disponendo il passaggio del personale in servizio nei ruoli della forza armata in cui prestava servizio al momento, con il grado ricoperto nella forza armata di provenienza.
Alla data del suo scioglimento la MVSN annoverava 14 142 caduti. Tra le onorificenze e decorazioni si annoveravano 57 conferimenti alla bandiera, tra cui 20 Ordini militari di Savoia. Tra le ricompense individuali:
20 Ordini militari di Savoia
90 Medaglie d’oro al Valor militare
1 232 Medaglie d’argento al Valor Militare
2 421 Medaglie di bronzo al Valor Militare
2 658 Croci di Guerra al Valor militare
Le grandi unità
L’organigramma della MVSN non prevedeva unità operative permanenti di livello superiore alla Legione (equivalente al Reggimento). Solo in caso di mobilitazione potevano venire formate delle grandi unità, che venivano poi sciolte alla fine della campagna.
Guerra di Etiopia (1935-1936)
1ª Divisione CC.NN. “23 marzo”
2ª Divisione CC.NN. “28 ottobre”
3ª Divisione CC.NN. “21 aprile”
4ª Divisione CC.NN. “3 gennaio”
5ª Divisione CC.NN. “1 febbraio”
6ª Divisione CC.NN. “Tevere”
7ª Divisione CC.NN. “Cirene”
Guerra di Spagna (1936-1939)
1ª Divisione CC.NN. “Dio lo Vuole”
2ª Divisione CC.NN. “Fiamme Nere”
3ª Divisione CC.NN. “Penne Nere”
Brigata “XXIII Marzo”
Brigata “Flechas Azules”
Brigata “Flechas Negras”
Brigata “Flechas Verdes”
Seconda Guerra Mondiale (1940-1943)
Campagna di Libia
1ª Divisione CC.NN. “23 marzo”
2ª Divisione CC.NN. “28 ottobre”
3ª Divisione CC.NN. “21 aprile”
4ª Divisione CC.NN. “3 gennaio”
Campagna di Grecia e occupazione dei Balcani
Raggruppamento Battaglioni CC.NN. “Galbiati”
Raggruppamento Battaglioni CC.NN. “Diamanti”
Raggruppamento Battaglioni CC.NN. “Biscaccianti”
Progettata invasione di Malta
Raggruppamento CC.NN. da Sbarco
Campagna di Russia
Raggruppamento Battaglioni CC.NN. “3 gennaio”
Raggruppamento Battaglioni CC.NN. “23 marzo”
Difesa del territorio metropolitano
1ª Divisione corazzata CC.NN. “M”
Raggruppamento CC.NN. “21 aprile”
30º Raggruppamento CC.NN.
Comandanti generali della Milizia
Emilio De Bono (1º febbraio 1923-31 ottobre 1924) 1º comandante
Italo Balbo (1º febbraio 1923- fino al 21 novembre 1924)
Cesare Maria De Vecchi (1º febbraio 1923 – fino al 10 luglio 1925)
Asclepia Gandolfo (1º dicembre 1924 – 31 agosto 1925)
Maurizio Ferrante Gonzaga (12 settembre 1925 – 9 ottobre 1926)
Benito Mussolini (12 ottobre 1926 – 25 luglio 1943)
Quirino Armellini (26 luglio 1943- 8 settembre 1943)
Renato Ricci (dal 20 settembre 1943 – fino alla costituzione della GNR l’8 dicembre 1943)
Capi di stato maggiore della Milizia
Francesco Sacco (1º febbraio 1923 – 1º dicembre 1924)
Enrico Bazan (1º dicembre 1924 – 23 dicembre 1928)
Attilio Teruzzi (1929 – 1935)
Luigi Russo (3 ottobre 1935 – 3 novembre 1939)
Achille Starace (3 novembre 1939- 16 maggio 1941)
Enzo Emilio Galbiati (25 maggio 1941 – 26 luglio 1943)
Renzo Montagna ad interim (17 settembre 1943 – 20 settembre 1943)(fonte)
[2] L’Amara era un governo dell’Africa Orientale Italiana istituito il 1º giugno 1936. Nel 1938 parte del territorio venne staccato e annesso al nuovo governo dello Scioa. Era uno dei 4 governi dell’Africa Orientale Italiana che costituivano l’Impero italiano d’Etiopia.
Commissariati
Alla sua istituzione comprendeva i commissariati di Beghemeder, di Debre Berhan, del Goggiam Orientale, di Gondar, di Semien, dell’Uollo Jeggiu, dell’Uag Lasta, del Goggiam Occidentale.
Simboli
Lo stemma era stato concesso con regio decreto del 18 aprile 1938.
«Troncato, nel primo d’oro al braccio destro vestito di nero, impugnante con la mano di carnagione un gladio romano, d’argento, il tutto posto in fascia; nel secondo, di rosso alla croce copta d’oro, ripiena del campo. Capo del Littorio.»
Governatori
Alessandro Pirzio Biroli (dal 1º giugno 1936 al 15 dicembre 1937)
Ottorino Mezzetti (dal 15 dicembre 1937 al 1º gennaio 1939)
Luigi Frusci (dal 1º gennaio 1939 al 19 maggio 1941)
Guglielmo Nasi (dal 19 maggio 1941 al 27 novembre 1941)(fonte)
[3] L’Argentina fu un piroscafo passeggeri, costruito nel 1907 per l’Unione Austriaca di Navigazione di Trieste. Dopo diversi passaggi di proprietà, nel 1936 entrò a far parte della flotta della Tirrenia di Navigazione; sopravvissuto anche al secondo conflitto mondiale, rimase in servizio per la compagnia statale fino al 1960.
Caratteristiche
Lungo 124,2 metri e largo 14,6, l’Argentina aveva uno scafo in acciaio chiodato, diviso da sette paratie stagne e sei ponti, tre dei quali erano continui da poppa a prua. Era spinto da due macchine alternative a vapore a triplice espansione Dunsmuir & Jackson Ltd, con una potenza complessiva di 3 500 cavalli. Poteva trasportare 88 passeggeri in prima classe, 94 in seconda e 182 in terza classe.
Le sistemazioni per i passeggeri furono ristrutturate più volte; nell’ultimo periodo di servizio per Tirrenia, la nave poteva trasportare un massimo di 771 passeggeri, i quali avevano a disposizione 34 cabine di prima classe (per un totale di 68 letti), 28 cabine di seconda classe (per un totale di 83 posti) e 20 cabine di terza classe (separate tra donne e uomini, per un totale di 220 posti). Nei corridoi delle stive tre e quattro potevano poi essere allestiti dei dormitori di terza classe, con un’aggiunta di ulteriori 90 posti letto, ed erano presenti a bordo anche una cella con 8 letti per eventuali detenuti e una cabina da due posti per i carabinieri della scorta. Le sale comuni per i passeggeri comprendevano tre sale da pranzo (una per classe) e due bar (per prima e seconda classe). La nave disponeva infine di quattro stive per il carico, con una capacità complessiva di 3 130 metri cubi.
L’intervento di ristrutturazione più cospicuo nella lunga storia del piroscafo fu eseguito nel 1938, quando il sistema di alimentazione a carbone delle caldaie fu sostituito con uno più moderno a nafta; nella stessa occasione, fu sostituito il fumaiolo e furono riallestiti gli spazi dedicati ai passeggeri.
Servizio
L’Argentina fu varato il 26 agosto 1907 presso i cantieri Russell & Co. di Port Glasgow. Il 31 ottobre dello stesso anno fu consegnato all’Unione Austriaca di Navigazione, che lo impiegò nei collegamenti tra Trieste e Buenos Aires e, più tardi, sulla linea Trieste – Patrasso – Palermo – New York. Messo in disarmo nel 1914 per via dello scoppio della prima guerra mondiale, nel 1918 fu requisito e trasformato in nave ospedale. Al termine del conflitto, l’Argentina passò alla Cosulich, assumendo bandiera italiana e riprendendo i collegamenti verso Buenos Aires. Dal 19 gennaio al 10 novembre 1925 la nave fu noleggiata alle Ferrovie dello Stato.
Il 16 gennaio 1926 il piroscafo fu acquistato dalla Florio Società Italiana di Navigazione e nel 1932 confluì, insieme al resto della flotta, nella nuova società Tirrenia – Flotte Riunite Florio-Citra. Nell’aprile del 1935 l’Argentina fu utilizzato per aprire un nuovo collegamento tra Napoli e Massaua, dopo essere stato sottoposto a interventi di ristrutturazione che compresero la sostituzione della macchina del timone e l’installazione di una piscina. Nel gennaio 1937, in seguito alla riorganizzazione dei servizi marittimi sovvenzionati, passò nuovamente di mano, questa volta alla Tirrenia di Navigazione. Nell’ottobre del 1938 la nave fu sottoposta presso i Bacini di Napoli a dei nuovi importanti lavori di ristrutturazione, descritti in dettaglio nella sezione precedente, che comportarono un esborso di 7 200 000 Lire e durarono fino al marzo successivo. Riconsegnato alla Tirrenia, il piroscafo fu destinato al ruolo di riserva.
Il 16 ottobre 1940 l’Argentina fu requisito dal Ministero della Marina, venendo in seguito utilizzato principalmente per il trasporto di truppe verso l’Albania e la Grecia . Il 9 settembre 1943, all’indomani dell’armistizio, la nave fu catturata dai tedeschi e data in gestione alla Mittelmeer Reederei, ma il 13 ottobre fu nuovamente catturato dai cacciatorpediniere britannici HMS Tyrian e HMS Tumult . Requisito dagli Alleati, fu utilizzato come trasporto truppe anche al termine della guerra, venendo restituito alla Tirrenia nel giugno 1947 . Fu quindi dato in noleggio all’Adriatica, che lo impiegò sulla linea Genova – Alessandria d’Egitto – Haifa – Beirut. Restituito alla Tirrenia nel marzo 1949, fu poi impiegato prevalentemente nei collegamenti per la Libia, su una rotta con scali a Napoli, Catania, Siracusa, Malta e Tripoli . Vi rimase fino al 1958, quando fu sostituito dalla motonave Città di Alessandria e posto in disarmo. Nel 1959 l’Argentina tornò brevemente in servizio, per sostituire le navi della classe Regione ferme per l’installazione dell’impianto anti-rollio. Posto definitivamente in disarmo il 29 febbraio 1960, nel giugno dello stesso anno fu venduto per la demolizione, che fu completata a Genova nel marzo 1961.(fonte)
[4] A partire dal 15 agosto777 ed entro il 1° settembre, il CMT di Napoli iniziava a costituire: un Comando Forze Armate, un Comando Truppe Esercito, tre battaglioni motoblindati di fanteria, un deposito misto, una compagnia di sussistenza, un ospedale da campo, un ospedale territoriale, un’infermeria quadrupedi, una sezione disinfezione e nucleo bagni, un comando tappa, un ufficio imbarchi sbarchi, tre magazzini materiali, per artiglieria, per il genio e materiale veterinario. Altri reparti, per la specificità dell’impiego, furono costituiti nel territorio di altri CMT.
……
Per la particolarità del clima risultò molto importante la sezione disinfezione difesa antimalarica e nucleo bagni. Composta da due ufficiali medici, un capitano e un malariologo e 44 sottufficiali e truppa. Il compito era di controllare lo stato igienico degli accantonamenti e dei locali dove le unità erano dislocate.
…….
Nelle disposizioni generali lo SME inserì un particolare momento addestrativo dedicato ai servizi. Era ritenuto necessario che il personale delle varie armi conoscesse l’impiego dei servizi a disposizione, a partire da quello sanitario e di disinfezione, passando per il commissariato dove veniva evidenziata la modalità di conservazione del cibo e dei materiali in generale, tenendo conto delle condizioni climatiche in Somalia. In particolare, fu previsto che per ogni compagnia fossero individuati 6-7 militari per apprendere presso la scuola panificatori l’impiego dei forni Weiss, la realizzazione di forni di circostanza in caso il reparto si trovasse isolato e senza la possibilità di ricevere i rifornimenti. Da “L’Esercito e la questione coloniale italiana dalla fine della Seconda guerra mondiale al corpo di sicurezza in Somalia” di Emanuele Di Muro(fonte)
[5] La battaglia di Gondar fu una battaglia della seconda guerra mondiale combattuta in Etiopia, a Gondar, nella regione dell’Amhara dal 10 maggio al 30 novembre 1941. Rappresentò la fase finale della campagna dell’Africa Orientale Italiana e vide contrapposti gli schieramenti italiani e anglo-abissini.
Di fronte alla travolgente controffensiva britannica in Africa Orientale Italiana il Viceré d’Etiopia Amedeo di Savoia diede alle sue truppe l’ordine di proseguire la lotta nei ridotti dell’Amba Alagi, del Galla Sidama e della regione degli Amara.
Il ridotto di Gondar
Il ridotto, situato nell’Amhara, già mesi prima era stato fortificato dal generale Nasi e comprendeva un’area centrale con Gondar Azozo dove risiedeva il comando e quattro capisaldi esterni: Culqualber, Blagir, Tucul e Ualag. Inoltre due presidi a Debrà Tabor e Uolchefit. La ridotta era difesa da 13 battaglioni nazionali, 15 battaglioni coloniali e pochi squadroni di cavalleria indigena. All’incirca 40 000 uomini. Le truppe italiane al comando del generale Guglielmo Nasi vennero schierate nell’Amhara. Il generale Nasi, persi i rifornimenti da Addis Abeba, dovette amministrare le poche scorte rimaste per farle durare il più a lungo possibile riducendo le razioni e organizzando un mercato indigeno, una sezione recuperi per sfruttare ogni materiale e una sezione pesca sul lago Tana. Furono anche realizzati degli improvvisati carri armati riutilizzando trattori agricoli opportunamente blindati. Nei mesi di settembre e ottobre, tramite voli segreti dalla Libia, Nasi ricevette denaro dall’Italia per comprare derrate alimentari. Il 19 luglio il generale Nasi lanciò una canzone intitolata “I gondarini”.
Il primo attacco britannico fu scatenato il 17 maggio 1941 e portò alla momentanea occupazione di Anguavà, ripresa subito dopo grazie all’azione della brigata del colonnello Torelli. Nei giorni seguenti, altri attacchi britannici in altri settori portarono all’occupazione del presidio di Debrà Tabor, comandato dal colonnello Angelini, che si arrese quasi senza combattere a differenza del presidio di Uolchefit. All’inizio dell’assedio, le forze aeree presenti nella base aerea di Gondar – Azozo era formata da due caccia Fiat CR.42 “Falco” ed un bombardiere Caproni Ca.133. Il Caproni venne utilizzato per rifornire dal cielo il presidio di Uolchefit, fino al suo danneggiamento da parte degli aerei inglesi l’8 agosto e la sua distruzione per probabile sabotaggio il 21 settembre.
Il presidio di Uolchefit
Il presidio di Uolchefit, composto da due battaglioni di Camicie Nere al comando del tenente colonnello Mario Gonella invece resistette a oltranza. Alle Camicie Nere si affiancarono due gruppi bande, formate da irregolari indigeni, di cui una era la “banda Bastiani” al comando dell’allora sergente maggiore Angelo Bastiani, e l’altra la Gruppo Bande Amhara al comando del tenente Enrico Calenda. Già dal 17 aprile, a seguito del tradimento di ras Ajaleu Burrù, il presidio fu completamente isolato e il 10 maggio il tenente colonnello Gonella rifiutò una prima richiesta di resa pervenuta dai britannici, così il 28 maggio un duro assalto inglese obbligò gli italiani ad abbandonare le posizioni più avanzate a passo Ciank e Debarech. Il 22 giugno un nuovo contrattacco italiano, effettuato all’arma bianca dalle Camicie Nere e dalla “banda Bastiani”, portò alla distruzione del presidio e alla rioccupazione del passo Ciank. Nel corso di questa operazione Angelo Bastiani, in combinazione con gli uomini di Calenda, catturò personalmente ras Ajaleu Burrù. Il comandante inglese Ringrose sfuggì alla cattura nascondendosi in un cespuglio. Informato della cattura di ras Ajaleu Burrù, il generale Nasi ordinò di non fucilarlo. In Italia Achille Beltrame dedicò all’azione una delle sue celebri copertine sulla Domenica del Corriere e Bastiani ottenne la Medaglia d’oro al Valor Militare.
Il 19 luglio il comando inglese, inviò al colonnello Gonella una seconda intimazione di resa, che fu respinta. In agosto il presidio di Uolchefit fu posto sotto assedio anche dalla 12ª divisione al comando del generale Charles Fowkes. Il tenente Calenda cadde durante un bombardamento al passo Mecan, venendo insignito anch’egli della Medaglia d’oro al Valor militare. Per integrare gli scarsi viveri ci si adattò a procurarseli con scorribande notturne per alcuni giorni, ma il 25 settembre questi furono esauriti completamente. Il 18 e il 25 settembre furono effettuate le ultime due sortite poi il 28 settembre il presidio, dopo 165 giorni di battaglia, si arrese con l’onore delle armi. La resa del presidio di Uolchefit permise agli inglesi di completare l’accerchiamento della ridotta di Gondar e molte truppe furono destinate alla successiva Battaglia di Culqualber.
Il presidio di passo Culqualber
Lo stesso argomento in dettaglio: Battaglia di Culqualber.
Nel corso degli scontri di Culqualber il Primo gruppo mobilitato dei Carabinieri e il CCXL Battaglione camicie nere si immolò quasi al completo. Si distinse in particolare il muntaz Unatù Endisciau che rifiutando di arrendersi agli inglesi, in seguito alla capitolazione del ridotto avanzato di Debre Tabor, oltrepassate le linee nemiche raggiunse le linee italiane per portare in salvo il gagliardetto del battaglione. Ferito a morte nell’adempimento della missione, unico soldato di colore, fu decorato con la medaglia d’oro al valor militare. Il 21 novembre 1941, la caduta del presidio di Culqualber spianò definitivamente la strada all’assedio della ridotta di Gondar.
La caduta di Gondar
Il 23 novembre gli inglesi arrivarono sotto Gondar, il cui presidio era sguarnito poiché diversi ascari avevano disertato non avendo più ricevuto la paga. L’unico caccia Fiat CR.42 “Falco” ancora funzionante partì per un’azione sul più vicino campo di aviazione inglese, e il pilota, Ildebrando Malavolta, morì nell’azione. I sudafricani resero onore il giorno seguente lanciando sul campo un messaggio con scritto “Un omaggio al pilota del Fiat; è stato un valoroso – South African Air Force”.
Il 27 novembre 1941 iniziò l’attacco finale degli inglesi diretto subito sull’aeroporto di Azozo. Nella mattinata cadde Azozo e le truppe britanniche raggiunsero il castello di Fasilades. Alle 14.30 il generale Guglielmo Nasi inviò in Italia l’ultimo dispaccio: “La brigata di riserva, lanciata sul fronte sud, non è riuscita a contenere l’attacco. Il nemico ha già superato il reticolato e i mezzi blindati sono penetrati in città. Ritengo esaurito ogni mezzo per un’ulteriore resistenza ed invio i parlamentari”. Poco dopo il comando italiano di Gondar, locato nella Banca d’Italia, fu preso d’assalto e costretto alla resa. Il 30 novembre deposero le armi gli italiani negli ultimi presidi che ancora resistevano. L’ultima piazzaforte nell’Africa Orientale Italiana fu completamente conquistata dagli inglesi.(fonte)
[6] Napoli, agosto 1943
I bombardamenti sulla città e l’occupazione tedesca
Per tutto il primo quadriennio di guerra (1940-1943) i bombardamenti su Napoli da parte delle forze Alleate erano stati durissimi e avevano causato ingenti perdite in termini di vite umane anche tra la popolazione civile. Si calcola che oltre 25 000 furono le vittime di questi attacchi alla città; solo nel bombardamento del 4 agosto 1943 perirono oltre 3 000 persone; circa 600 morti e 3 000 feriti si ebbero per lo scoppio della nave Caterina Costa nel porto, il 28 marzo 1943.[5][6] Molto gravi anche i danni al patrimonio artistico e culturale: la Basilica di Santa Chiara, ad esempio, fu semi-distrutta il 4 dicembre 1942.
L’inizio della campagna d’Italia, con lo sbarco Alleato in Sicilia il 9 luglio 1943, la caduta del fascismo il 25 luglio e la successiva avanzata delle forze Alleate nell’Italia meridionale all’inizio di settembre avevano indotto esponenti dell’antifascismo partenopeo tra cui Fausto Nicolini e Adolfo Omodeo a stabilire più stretti contatti coi comandi Alleati, invocando la liberazione della città.
A partire dall’8 settembre, giorno dell’entrata in vigore dell’Armistizio di Cassibile, le forze armate italiane – a Napoli come in tutto il resto del Paese – si trovarono allo sbando per mancanza di ordini dai comandi militari. La situazione, già difficile per i bombardamenti pregressi e per lo squilibrio delle forze in campo (oltre 20 000 tedeschi a fronte di soli 5 000 italiani in tutta la Campania), ben presto si fece caotica dopo la diserzione di molti alti ufficiali, incapaci di assumere iniziative quando addirittura non conniventi con i tedeschi; significativa in tal senso la fuga in abiti borghesi dei generali Riccardo Pentimalli ed Ettore Deltetto, cui era affidata la responsabilità militare della provincia di Napoli: gli ultimi atti di Deltetto furono proprio la consegna della città all’esercito tedesco e la stesura di un manifesto che vietava gli assembramenti, autorizzando i militi a sparare sulla folla in caso di inadempienza. Al vacillare dei vertici seguì lo sbando delle truppe, a loro volta incapaci di difendere la popolazione civile dalle angherie tedesche. Sporadici tentativi di resistenza si ebbero solo alla Caserma Zanzur, alla Caserma dei Carabinieri «Pastrengo» e al 21º Centro di Avvistamento di Castel dell’Ovo.(fonte)
Considerazioni a margine
Un fermo immagine nella tempesta: la dichiarazione di Carmine Sgambato tra memoria privata e dramma collettivo
Nel pieno della devastazione che travolse l’Italia tra il 1940 e il 1943, e in particolare la città di Napoli, il documento redatto da Carmine Sgambato si impone come una testimonianza minuta ma potentissima. Apparentemente si tratta di un modulo amministrativo, redatto con precisione e scrupolo per ottenere il pagamento di arretrati militari. Tuttavia, a una lettura attenta, questo testo rivela un valore ben più profondo: è lo specchio della condizione esistenziale di un uomo, e insieme di un intero popolo, travolto dalla guerra e in cerca di un ancoraggio.
La Napoli dell’estate 1943 è una città ferita. I bombardamenti alleati hanno lasciato dietro di sé un cumulo di macerie, morte e disperazione; il potere statale si è dissolto con la caduta del fascismo, mentre la popolazione è esposta alle angherie dell’esercito tedesco occupante. In questo contesto tragico, la voce di Carmine Sgambato – reduce dalla prigionia, ex sergente maggiore della M.V.S.N. – emerge con una sorprendente lucidità. Il suo modulo, redatto il 16 agosto 1943, pochi giorni prima dell’insurrezione delle “Quattro Giornate”, assume i contorni di una memoria individuale che resiste al crollo delle istituzioni.
Nel documento, ogni dettaglio è meticolosamente registrato: date, gradi, stipendi non riscossi, periodi di servizio e prigionia. Sgambato ricostruisce con cura il proprio percorso militare, come a voler ricomporre la trama spezzata della propria esistenza. Non vi è rabbia né retorica, ma un tono sobrio e preciso, quasi notarile, che conferisce forza alla narrazione. È l’espressione di un uomo che, nonostante tutto, cerca giustizia e riconoscimento. E lo fa non gridando, ma appellandosi a ciò che resta della legalità: un modulo, un timbro, un’autorità che possa ancora dare senso all’esperienza vissuta.
Questa ricerca di ordine nel caos assume un valore emblematico. Sgambato rappresenta tutti quei cittadini che, pur oppressi dalla guerra e abbandonati dallo Stato, non rinunciano a rivendicare la propria dignità. La sua vicenda personale si intreccia con quella di migliaia di italiani che, tra burocrazie interrotte, famiglie smembrate e miseria crescente, continuavano a sperare in un futuro diverso, in un’istituzione giusta, in un ritorno alla normalità.
Il documento, così, si trasforma in una fonte preziosa non solo per ricostruire vicende militari, ma anche per comprendere lo stato d’animo e la condizione esistenziale dell’Italia di quegli anni. È un esempio di microstoria che illumina la grande storia. E in questo senso, la voce di Carmine Sgambato – umile, precisa, determinata – diventa memoria condivisa, patrimonio da preservare.TSS