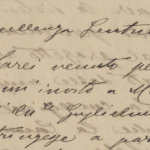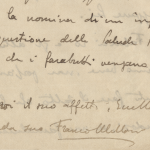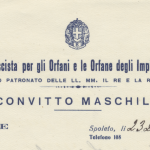Il Guardasigilli
Ministro di Grazia e Giustizia
Roma, 20 Ottobre 1939/XVII
Mio caro Giorgio,
ti ringrazio affettuosamente della tua lettera
la quale, come sempre, testimonia la tua franca e sin-
cera amicizia.
Ho voluto cominciare con gli Avvocati, i quali
stanno pagando il fio delle colpe dei padri, ecc. ecc.
Non si può fare molto. Ma io farò tutto quello che sa_
rà possibile per rialzarne il prestigio morale ed an=
che per diminuire un po’ la crisi della nostra profes=
sione che purtroppo trova le sue radici in fenomeni di
tale vastità e complessità per cui tutto quanto potrò
fare non sarà che un cataplasma. Ma lo farò.
Tutti i consigli che tu colla tua esperienza e
col tuo ingegno vorrai darmi saranno per me preziosi.
Dico sul serio.
Il Duce[1] mi ha dato la consegna di ultimare il Co-
dice Civile e il Codice di Procedura Civile per il
1940. Studio, compulso, notte e giorno, aven-
do sempre fissi gli occhi alla bussola del buon senso,
ossia del senso comune. È una stella polare indispen=
sabile ai naviganti e al legislatore.
./.
Il Guardasigilli
Ministro di Grazia e Giustizia
– 2 –
Ti ringrazio di avermi mandato la tua pregevolissi=
ma relazione sul Progetto del Codice di Procedura Civile
che avevo però già letto – è la verità – scorrendo i vo=
lumi dei pareri inviati al mio predecessori Solmi[2]. Sono
d’accordo con te in buona parte, se non in tutte le tue
osservazioni.
Gli Avvocati bolognesi per una volta tanto, si so=
no trovati d’accordo nel constatare l’ingegno e il pre=
gio del lavoro di un loro collega. Hai ragione di consi=
derare la cosa come fatto strano ed eccezionale. Parle=
remo di tutto ciò con calma o qui a Roma o a Bologna.
Non sono ancora riuscito a dare un corso normale alla
mia vita. Quando dico corso normale intendo riferirmi a
qualche buona giornata bolognese. Più gli anni passano
più mi convinco che le grandi strade del mondo non val=
gono nessuna Via Orefici[3] o via Pescherie[4] con tutto quel
profumato ben di Dio esposto al tepido sole autunnale
con pantagruelica generosità.
Ti abbraccio, mio vecchio amico.
Grandi[5]
Gr.Uff. Avv. GIORGIO GHIGI[6] = BOLOGNA =
Note
[1] Benito (Amilcare Andrea) Mussolini. Uomo politico (Dovia di Predappio 1883 – Giulino di Mezzegra, Dongo, 1945). Socialista, si andò staccando dal partito, fino a fondare i Fasci da combattimento (1919). Figura emergente nell’ambito del neoformato Partito nazionale fascista, subito dopo la “marcia su Roma” (1922) venne incaricato dal re della formazione del governo, instaurando nel giro di pochi anni un regime dittatoriale. In politica internazionale M. affrontò l’esperienza coloniale in Etiopia, si fece coinvolgere dai buoni rapporti con la Germania di Hitler nella persecuzione degli Ebrei, fino poi alla partecipazione al conflitto mondiale. I pessimi risultati bellici portarono il Gran Consiglio a votare la mozione Grandi presentata contro di lui (1943). Arrestato, fu liberato dai Tedeschi e assunse le cariche di capo dello Stato e del governo nella neonata Repubblica sociale. Alla fine della guerra fu catturato e fucilato dai partigiani per ordine del Comitato di liberazione nazionale. Dominò la storia italiana per oltre un ventennio, divenendo negli anni del suo potere una delle figure centrali della politica mondiale e incarnando uno dei modelli dittatoriali fra le due guerre.
Di estrazione popolare (il padre, Alessandro, era fabbro, e la madre, Rosa Maltoni, maestra), dotato di una personalità ribelle e intemperante, aderì giovanissimo alle idee socialiste e rivoluzionarie professate dal padre. Nel 1901, al termine di un disordinato corso di studi, conseguì il diploma magistrale e, iscritto al partito socialista, iniziò a collaborare alla Giustizia di C. Prampolini, specie con articoli antimilitaristi. Espatriato in Svizzera (1902-04) per sottrarsi alla leva, si sostenne facendo vari mestieri e si segnalò come acceso propagandista soprattutto sul versante anticlericale, mentre alcune letture soreliane contribuirono forse a indirizzarlo verso il sindacalismo rivoluzionario. Condannato per diserzione e poi amnistiato, rientrò a Predappio nel gennaio 1905, espletò gli obblighi di leva e si impiegò come maestro. Riprese quindi l’attività giornalistica e nel 1908 fu arrestato a seguito di uno sciopero bracciantile. Nel febbraio 1909, chiamatovi da C. Battisti, assunse la segreteria della camera del lavoro di Trento e la direzione dell’Avvenire del lavoratore. Espulso dai territori asburgici (settembre 1909), divenne dirigente della federazione socialista di Forlì e direttore del settimanale Lotta di classe. In questo periodo si unì con Rachele Guidi, che avrebbe sposato nel 1915, dalla quale ebbe i figli Edda, Vittorio, Bruno, Anna Maria e Romano. Nel 1911 subì una nuova condanna per aver guidato, con il repubblicano P. Nenni, le manifestazioni contro l’intervento in Libia, ma stava ormai emergendo come il più noto oratore e giornalista socialista, per cui, allorché i massimalisti prevalsero sui riformisti (congresso socialista di Reggio Emilia, luglio 1912), fu acclamato tra i maggiori dirigenti del partito e gli venne affidata, nel dicembre, la direzione dell’Avanti!. Si trasferì a Milano, dove aveva sede il quotidiano, che sotto la sua direzione acquistò molto in diffusione e influenza, perseguendo una linea classista e rivoluzionaria che in alcune occasioni (per es., allorché intese estendere lo sciopero generale scaturito dalla sollevazione di Ancona nel 1914) attirò la sconfessione di F. Turati e del gruppo parlamentare socialista. Nel dibattito sulla guerra M. sostenne per vari mesi una posizione rigidamente neutralista, anche in contrasto con i molti che avevano fatto un percorso politico analogo al suo e che ora andavano orientandosi in favore dell’intervento, finché il 18 ottobre 1914, con una svolta improvvisa, pubblicò un proprio editoriale interventista. Il partito reagì immediatamente sottraendogli la direzione dell’Avanti! ed espellendolo, ma già il 14 novembre usciva il primo numero del Popolo d’Italia, quotidiano interventista da lui diretto. Consumata la rottura con il PSI, non era ancora consumato il rapporto con il movimento socialista, nel quale M. avrebbe continuato ad avere un qualche seguito. Richiamato alle armi nel settembre 1915, nel febbraio 1917 venne ferito in un’esercitazione e tornò alla direzione del giornale. Nelle tensioni del dopoguerra M. operò dapprima un cauto avvicinamento alle posizioni nazionaliste con la fondazione dei Fasci di combattimento (Milano, 23 marzo 1919), costituiti da un centinaio di ex combattenti (tra questi sindacalisti, arditi, ex socialisti, repubblicani, futuristi), il cui programma manteneva visibili impronte socialiste; quindi, anche alla ricerca di una base di massa per il suo movimento, intessé un confronto con i dannunziani, che avevano motivazioni largamente analoghe alle sue, e fece propria la parola d’ordine della vittoria mutilata; ma soprattutto cercò di unificare in un’unica tendenza i movimenti antiliberali e antigiolittiani, di destra come di sinistra, senza peraltro conseguire un successo nelle elezioni politiche del novembre 1919. Dopo l’occupazione delle fabbriche (autunno 1920) e la sconfitta del movimento operaio, nel corso di una crisi politica che vedeva declinante l’iniziativa socialista e in sempre maggior difficoltà la classe dirigente liberale, M., operando una visibile svolta, tese a presentarsi come capo di una forza capace di rappresentare le tendenze antiliberali della piccola e media borghesia spaventata dall'”ondata bolscevica”, nonché il bisogno di ristabilire l’ordine gerarchico dell’organizzazione economico-produttiva scosso dalle lotte proletarie. Nell’aprile 1921 il movimento elesse oltre trenta parlamentari, tra i quali M., in liste comuni con i giolittiani, e nel novembre successivo l’ingrossarsi delle sue file consigliò la costituzione del Partito nazionale fascista. Gli agrari e ampi settori della borghesia industriale sostennero e incoraggiarono l’opera di smantellamento sistematico delle roccaforti del potere proletario (giornali, sezioni di partito, cooperative, sindacati, ecc.) attuato dai fascisti con violenza, mentre alcuni settori dell’apparato statale (magistrati, prefetti, responsabili della sicurezza ecc.) garantirono agli squadristi, quando non il sostegno, l’impunità. In questa fase M., che appariva figura emergente in grado di raccogliere una massiccia forza d’urto per dare la scalata al potere, seppe abilmente alternare intimidazioni brutali e rassicurazioni di legalità, fino alla prova di forza che si ebbe con la mobilitazione fascista del 22 ottobre 1922 (la “marcia su Roma”) a seguito della quale cadde il governo Facta e il re lo incaricò di formare il governo. M. sarebbe rimasto ininterrottamente a capo del governo dal 31 ottobre 1922 al 25 luglio 1943 (dal 24 dicembre 1925 con il titolo di primo ministro e segretario di stato), tenendo altresì per vari periodi i ministeri degli Esteri (1922-29, 1932-36, 1943), degli Interni (1922-24, 1926-43), delle Colonie, della Marina, delle Corporazioni e altri; egli fu cioè il supremo esponente dell’Italia fascista. Gli anni tra il 1922 e il 1924 videro un governo di coalizione cui partecipavano liberali, nazionalisti, popolari, governo che perseguì una politica genericamente di destra e si servì di norma di mezzi legali per la repressione dell’antifascismo. Ma il problema di M. era conciliare l’anima “rivoluzionaria” del movimento fascista, che largamente gli sfuggiva e rischiava di coalizzare le opposizioni, con la necessità di consolidare i nuovi equilibri politici governativi. Con la costituzione del Gran Consiglio del fascismo (dic. 1922), presieduto dallo stesso M., e l’istituzione della Milizia volontaria per la difesa dello stato (genn. 1923), che legalizzava e imbrigliava lo squadrismo, M. tentò una prima soluzione del problematico rapporto movimento-governo, apprestandosi a divenire garante di ciascuno nei confronti dell’altro, mentre la confluenza dei nazionalisti nel PNF e la legge elettorale Acerbo (luglio 1923), che assicurava un forte premio di maggioranza alla lista vincitrice, ne rafforzavano la posizione. A interrompere il consolidarsi del connubio tra fascismo e stato intervenne la crisi dell’Aventino, a seguito dell’assassinio da parte di alcuni sicari fascisti del leader socialista G. Matteotti (giugno 1924), fase che poteva segnare la fine del governo di coalizione ma che si concluse con il discorso di M. alla Camera del 3 gennaio 1925, nel quale era rivendicata la continuità tra il movimento fascista e il governo in carica. Sconfitta con il concorso della Corona l’opposizione aventiniana, e con essa l’antifascismo tutto, per M. si apriva la strada dell’edificazione del regime, cui il governo (ormai completamente composto da fascisti) diede mano varando una serie di leggi che tra il 1925 e il 1929 modificarono sostanzialmente l’assetto costituzionale. Il partito unico, la soppressione delle libertà di associazione e di stampa, l’istituzione del Tribunale speciale, il rafforzamento dell’esecutivo e dei poteri del capo del governo, l’attribuzione di funzioni costituzionali al Gran Consiglio del fascismo e, in breve, l’insieme della legislazione di questi anni, abolivano la divisione costituzionale dei poteri e posero M. nella posizione di un esercizio del potere sostanzialmente illimitato, regolatore unico dell’intero ingranaggio amministrativo, istituzionale ed economico della nazione; a questa funzione si accompagnava una gigantesca macchina propagandistica esaltatrice delle virtù nazionali e guerriere del “duce” – figura carismatica destinata a riprodursi in altri contesti politici totalitari, attorno a cui si consolidò il consenso -, mentre si diffondevano come cultura di massa i simboli, il linguaggio, i riti collettivi, gli istituti del regime. Il regime mussoliniano in senso stretto durò dunque dalla fine degli anni Venti al 1943, perfezionando col tempo l’integrazione totalitaria di partito, società e stato; pertanto, specie in questo periodo, la vita e le scelte di M. costituiscono gran parte della politica interna ed estera dell’Italia. Se l’apice del prestigio, non solo all’interno, venne toccato alla metà degli anni Trenta, è nello stesso periodo che inizia a delinearsi un quadro internazionale che, con la guerra, avrebbe portato la rovina di M. e del fascismo, oltre la sconfitta dell’Italia. La politica estera del fascismo fu sostanzialmente prudente e in linea con la politica estera liberale fino all’ascesa al potere di A. Hitler e alla revisione dell’equilibrio politico europeo che questa comportava. Dopo aver preso posizione contro la minaccia di un’annessione dell’Austria da parte della Germania e aver promosso il convegno di Stresa con Francia e Gran Bretagna (1935) che parve creare un fronte antitedesco, M., per prevalenti motivi di prestigio interno e internazionale, volle la conquista dell’Etiopia, che gli confermò il consenso degli italiani ma depauperò l’economia nazionale, costretta a provvedere all’Impero, e provocò l’urto con la Gran Bretagna e la Società delle Nazioni. Inoltre i legami di solidarietà con la Germania, nella tensione internazionale causata anche dall’intervento nella guerra civile spagnola, trasformatisi presto in una rigida complementarità, portarono M. all’accettazione (1938) dell’Anschluss e alla persecuzione degli Ebrei. Alla vigilia del conflitto mondiale, M. parve svolgere a Monaco (1938) un ruolo di efficace moderatore; si trattò in effetti di una dilazione dell’attacco a fondo che Hitler stava per sferrare. Scoppiata la guerra, che a lungo aveva minacciato, giungendovi peraltro militarmente impreparato, M., dopo un periodo di incertezza dissimulata dalla formula della “non belligeranza”, decise l’intervento ritenendo imminente la vittoria tedesca. Gli insuccessi della sua opera di comandante supremo – carica che nel maggio del 1940 gli era stata ceduta dal re -, la constatazione che egli aveva perso ogni controllo della situazione, che andava precipitando dopo le spedizioni in Grecia e in Russia e l’occupazione alleata di parte del territorio italiano, offrirono la possibilità al Gran Consiglio del fascismo di approvare (24 luglio 1943) un ordine del giorno, presentato da D. Grandi, contro di lui, cui seguì da parte del re l’immediata revoca del mandato governativo. Crollato il regime, M. fu trasferito in stato di fermo prima a Ponza, poi alla Maddalena, quindi al Gran Sasso; di qui venne liberato dai tedeschi con un colpo di mano e portato in volo in Germania all’indomani dell’8 settembre. Tornò in Italia per raccogliere quel che restava dello sfacelo fascista nella Repubblica sociale italiana, nella quale esercitò le funzioni di capo dello Stato e capo del governo. Installato a Gargnano (sul Lago di Garda), seguì le vicende belliche apparendo raramente in pubblico. Dichiarò come obiettivo la riconciliazione degli italiani e la socializzazione, ma la crisi militare dell’Asse, gli scioperi operai del 1943-44 e il movimento di Resistenza ne evidenziarono la funzione di puntello dell’occupazione tedesca. Al crollo della “linea gotica” si trasferì a Milano (17 apr. 1945) e tentò di contrattare la propria incolumità con il Comitato di liberazione nazionale. In fuga verso Como, in divisa da soldato tedesco, fu arrestato dai partigiani e passato per le armi per ordine del CLN il 28 aprile 1945. Il suo cadavere (insieme a quelli di Claretta Petacci, la donna cui era legato dal 1936, e di altri gerarchi fucilati) fu esposto dai partigiani a Milano in piazzale Loreto, a simbolo della fine del fascismo. L’edizione dell’Opera omnia è curata da E. e D. Susmel, 36 voll., 1951-63.(fonte)
[2] Arrigo Solmi. – Primo di dieci figli, nacque a Finale nell’Emilia (Modena) il 27 gennaio 1873, da Angelo, segretario comunale, e da Amalia Stucci. Fratello dell’appena più giovane Edmondo (1874-1912), che sarà storico della filosofia e cattedratico a Pavia, si laureò a Modena, con lode, il 28 giugno 1895 discutendo una tesi sui rapporti tra Stato e Chiesa. Vinto il concorso per sottobibliotecario reggente, fu destinato alla Biblioteca nazionale di Palermo (aprile 1898) con il modesto stipendio di cento lire mensili, ma immediatamente riuscì a ottenere il trasferimento presso la Biblioteca estense (d.m. 31 maggio 1898). Mirava comunque alla carriera accademica: dopo una breve esperienza di insegnamento a Modena, nel 1899 conseguì la libera docenza in storia del diritto italiano e l’incarico nell’Università di Camerino (ordinario dal 1901), mantenendo il posto all’Estense, sebbene con frequentissimi periodi di aspettativa. La situazione si fece tuttavia insostenibile tra le denunce del direttore e le proteste dei colleghi, tanto che il ministero lo trasferì alla Biblioteca governativa di Cremona (1° dicembre 1901). Il copione si ripeté però anche lì (in un anno prestò servizio solo due mesi), finché il problema dell’assenteismo si risolse allorché fu ternato al concorso di Cagliari e vi fu chiamato quale professore straordinario (a.a. 1902-03, stipendio d’ingresso 3000 lire annue).
Il 28 aprile 1900 sposò Ines Dallari, sorella del filosofo del diritto Gino, con il quale Solmi aveva condiviso la formazione liceale e il periodo di studentato nell’Ateneo modenese (si erano laureati nello stesso giorno) e più tardi la colleganza accademica a Siena, Parma, Pavia e Milano. Al cognato lo accomunava l’impostazione metodologica, di tipo sociologico-positivista; con lui lavorò spesso di sponda, nell’università e nell’attività politica e culturale.
La prima monografia (Le associazioni in Italia avanti le origini del comune. Saggio di storia economica e giuridica, Modena 1898) suscitò discussioni sia nelle sedi concorsuali, sia nel dibattito storiografico: pur apprezzata per la vasta conoscenza della letteratura (specialmente tedesca), sembrava sottovalutare l’‘elemento romano’ e dedicare poco spazio ai profili giuridici del tema trattato, votata com’era alla comprensione del diritto attraverso le interconnessioni con la struttura sociale.
Caratteristica di Solmi, già nelle opere giovanili, fu la visione di sintesi e la ricerca della chiave interpretativa dei fenomeni analizzati. Dopo alcuni lavori finalizzati ai concorsi e perciò corrispondenti ai gusti prevalenti nella disciplina (attenzione al problema delle origini, argomenti longobardistici), presto varcò i confini dell’Alto Medioevo e si dedicò a indagini su personaggi (Alberto Gandino, Baldo degli Ubaldi) espressivi di tematiche proiettate quasi al di là dell’età medievale (il processo e la questione delle falsificazioni; la produzione statutaria e il diritto nuovo). Il secondo lavoro monografico (Stato e Chiesa secondo gli scritti politici da Carlomagno fino al Concordato di Worms (800-1122). Studio storico e giuridico, Modena 1901), mentre accoglieva uno dei rilievi critici sollevati dall’opera precedente – la mancata rilevanza accordata al fattore religioso –, confermava gli interessi poco conformisti di Solmi, ora rivolti agli intrecci tra il diritto pubblico e la politica. A un certo disinteresse della storiografia giuridica per il libro fece riscontro il giudizio positivo di Francesco Ruffini, l’ecclesiasticista che veniva da una formazione storica.
Il periodo cagliaritano lo segnalò tra i professori più promettenti della nuova generazione. Lo aprì con una prolusione (La funzione pratica della storia del diritto italiano nelle scienze giuridiche, 1903) che, pur ribadendo i capisaldi della metodologia sociologico-positivista, si incentrava sul concetto di svolgimento della storia giuridica e profilava una strada originale evitando le secche, da un lato, delle polemiche tra romanisti e germanisti e, dall’altro, di indagini meramente erudite. Utilizzando spesso fonti inedite e rivelando attitudini comparatistiche, studiò la costituzione fondiaria dell’isola (gli ademprivi, il feudo), le istituzioni (i giudicati, il Parlamento del 1355, il servaggio), le fonti (la carta de logu cagliaritana, i condaghi) oltre a proporre rassegne storiografiche e a fondare una rivista (Archivio storico sardo, 1905) che si attestò su un buon livello. L’esperienza giuridica isolana fu una sorta di laboratorio che non smise di frequentare anche successivamente, nel quale vide le forme di un diritto autoctono che, espressione connaturata alle condizioni socioeconomiche del territorio, nel corso dei secoli e grazie anche all’azione delle repubbliche di Pisa e Genova sarebbe andato confluendo nella tradizione delle genti italiche.
Partecipe della irrequietezza della generazione di giuristi postrisorgimentali che salivano alla ribalta nel tumultuoso periodo giolittiano, presto Solmi concepì l’attività scientifica in stretta connessione con l’impegno culturale e politico. Da qui l’attenzione crescente per lo studio del nucleo pratico del fenomeno giuridico, originatosi nel Tardo Antico (diritto volgare) e sviluppatosi poi come diritto comune nelle specifiche condizioni culturali e sociali dell’età comunale. L’interesse per Dante, certo stimolato dal colloquio con Dallari e con il fratello Edmondo, segnala appunto la ricerca di nessi tra figure essenziali del pensiero politico-letterario e l’esperienza giuridica fatta di dottrine, norme e istituzioni tipiche del genio italico (secondo una sua terminologia ricorrente). La civiltà comunale diventerà un centro fondante dei suoi interessi di studio perché coagulo di spirito associativo e di organizzazione sociale, che precipitavano in una forma istituzionale e in un diritto nuovo. Liberale e liberista, aveva un’idea forte di nazione, come soggetto che impersonava una tradizione di civiltà antica e che, mentre scontava l’incompiuta esperienza del Risorgimento, abbisognava di espandersi dopo i rovesci coloniali di fine secolo.
Tutto questo si precisò meglio nel prosieguo della sua attività. Passato all’ordinariato a Cagliari (dicembre 1905), vinse subito dopo il concorso a Siena, ove insegnò dal febbraio 1906 all’ottobre 1907 e maturò l’idea di preparare un manuale, la Storia del diritto italiano, che effettivamente pubblicò nel 1908, allorché era stato appena trasferito a Parma.
Nell’ambito storico-giuridico il genere manualistico vantava allora già una consistente sperimentazione che soddisfaceva alle esigenze didattiche e contribuiva a stabilire i contenuti e i confini specifici della materia accademica secondo le differenti impostazioni metodologiche presenti nella disciplina. In particolare il manuale di Solmi si proponeva come un testo essenziale, diretto a presentare lo svolgimento storico unitario del diritto italiano: nessuna esposizione specifica del diritto germanico o bizantino, bensì una visione ricostruttiva che guardava all’affermarsi in Italia degli istituti giuridici, quale che fosse la rispettiva origine. Dei quattro ‘elementi’ che il giurista emiliano riteneva concorrenti nella formazione di questo diritto – il romano, il germanico, l’ecclesiastico e l’italico o volgare – quest’ultimo era considerato assorbente perché prodotto ed espressione dei nuovi bisogni e quindi in grado di assimilare gli altri. Per cogliere le variazioni dello svolgimento del diritto, l’autore utilizzava le ‘ricerche comparative’, ovvero «l’esame dei fattori politici ed economici che determinarono i rivolgimenti giuridici» (prefazione, datata Siena, 22 agosto 1907). Di contro al metodo cronologico e a quello sistematico, Solmi adottava un sistema misto che definiva sincronistico o storico: suddivisa l’esposizione in tre grandi periodi (età romano-barbarica, 476-1100, del risorgimento, 1100-1748, moderna, 1748-1870), ognuno dei quali, tranne l’ultimo, si suddivideva in vari sottoperiodi, trattava partitamente lo svolgimento dei singoli istituti privatistici e pubblicistici.
Gli anni di Parma furono un momento eccezionalmente vivo. In quel cenacolo che vide ruotare molti protagonisti ma che ebbe sempre come animatore Angelo Sraffa nel quindicennio (1898-1913) della sua permanenza – lavorarono insieme giuristi della levatura di Giuseppe Chiovenda e Alfredo Rocco, Agostino Berenini e Gino Segrè, Pietro Bonfante e Francesco Brandileone – Solmi si inserì attivamente, aprì gli orizzonti della sua cultura e cooperò, tra l’altro, a quell’autentico periodico d’avanguardia (la Rivista del diritto commerciale) che lo stesso Sraffa aveva fondato con Cesare Vivante. Lì pubblicò diversi saggi dicendo la sua nel dibattito sulle lacune nell’ordinamento e sull’interpretazione (innescato da un libro di Donato Donati del 1910), sul metodo (recensione e postilla a Giovanni Brunetti: Solmi sosteneva la non liceità di isolare «l’elemento formale nel diritto separandolo dai suoi complessi elementi informatori»: ibid., 1913, pt. I, p. 801) e occupandosi di storia del diritto commerciale (rassegne bibliografiche, considerazioni sulle origini dell’avallo).
Nell’ottobre del 1912 passò a Pavia a insegnare diritto ecclesiastico, in attesa che si liberasse la cattedra di storia del diritto italiano tenuta da Pasquale Del Giudice (il che avvenne nel 1917). Si intensificò intanto l’impegno politico-culturale. Frequentatore dei circoli nazionalisti, simpatizzò con le proposte di Giovanni Borelli e di Alberto Caroncini, quindi collaborò a L’Azione vicino alle posizioni di Paolo Arcari e, soprattutto, di Gioacchino Volpe, con cui iniziò un sodalizio di cooperazione storiografica e di condivisione ideale in un comune percorso che li portò all’adesione al fascismo. Nel clima successivo all’impresa libica, al pari di tanti altri letterati, storici e giuristi, si occupò della cultura e delle costumanze delle popolazioni africane (Lo stato e l’islamismo nelle nuove colonie italiane, in Rivista di diritto pubblico, I (1913), pp. 129-145; e La Tripolitania studiata nella vita sociale, in Patria e colonie, III (1914), 5, pp. 335-339). Acceso interventista e in prima fila nelle giornate del maggio 1915, Solmi pose sempre più al centro della sua storiografia la visione di un diritto italiano fieramente nazionale e largo dispensatore di civiltà giuridica alle popolazioni europee e in specie al legislatore napoleonico; sicché i calchi dei codici francesi recepiti poi in Italia sarebbero la continuazione di un autonomo svolgimento dell’ordinamento italico. Da qui l’interesse per la storia risorgimentale e per la politica internazionale, con opere spesso di carattere divulgativo. Abilitata dalla sua tradizione storica, quella nazione doveva espandersi sull’altra sponda dell’Adriatico – era la chiave di spiegazione dell’intervento nel 1915 – e ovviamente in Africa. Con altri giuristi sostenne l’entrata nel conflitto partecipando al volumetto La nostra guerra (Firenze 1915) con un contributo intitolato Necessità e ragioni della nuova guerra alla Turchia.
Nel 1919, Solmi riprese la militanza nei circoli liberal-nazionalisti di Milano, dove risiedeva, ma presto se ne distaccò, approvando l’impresa di Fiume. Nel 1920 fu eletto consigliere comunale in una lista che fece opposizione al governo socialista della città (ottenne pure un secondo mandato, fino al 1926). Uomo d’ordine, dai primi anni Venti vide nel partito di Benito Mussolini l’interprete della tradizione della civiltà italiana e la sola forza capace di soddisfare le esigenze della nazione: quelle espansive all’esterno e quelle di coesione interna, di contro ai conflitti sociali e di classe. Più tardi, nel 1931, egli stesso dipinse la sua militanza nazionalista come un pericoloso (e perciò meritorio) fiancheggiamento del fascismo.
Conobbe Mussolini, che lo stimò al punto di appoggiarne personalmente la candidatura nel listone alle elezioni del 1924 (fu puntualmente eletto). Intanto nel 1922 cominciò una lunga e intensa collaborazione con la Gerarchia, mentre nel 1923 il governo lo nominò rettore dell’Università di Pavia, dopo il rifiuto dell’incarico da parte di Giorgio Errera (sarà uno dei 12 professori che rifiutarono il giuramento del 1931). Per Solmi furono forse gli anni più intensi della vita, con il doppio impegno di consigliere comunale e di parlamentare e soprattutto con il compito di fascistizzare l’Ateneo pavese. Era del resto in conflitto d’interessi come consigliere della città che fortemente voleva fondare la propria università e come rettore dell’Ateneo ticinese, che resisteva non volendo perdere prestigio e risorse economiche. A Pavia fu altresì protagonista della istituzione della Scuola di scienze politiche, poi (1926) facoltà, nella quale teneva per incarico il corso di diplomazia e storia dei trattati: una materia in cui in quegli anni diede forse il meglio di sé, con indagini fondate su una buona esplorazione di documenti. Ebbe anche diversi allievi, alcuni destinati a larga fama (Mario Toscano, Rodolfo Mosca).
Nel destreggiarsi sul piano locale Solmi non parve all’altezza dei compiti. Attaccato dalle gerarchie pavesi del Partito nazionale fascista (si era iscritto nell’ottobre 1925) come dagli ambienti universitari che gli rimproverarono la debolezza nella vicenda dell’istituzione dell’Ateneo milanese, diede le dimissioni da rettore nel 1926, prima della scadenza del mandato. Ma aveva perso anche forza propositiva nel suo campo primario della storia del diritto. L’agile libretto su La storia del diritto italiano (Roma 1922), pur utile a fini divulgativi, proponeva una panoramica priva di guizzi innovativi e solo si fa notare per l’ammissione che il legislatore ottocentesco italiano nel redigere i codici aveva ceduto alla suggestione imitativa del modello francese (leggi: i diritti individuali sanciti dall’Ottantanove). Occorreva dunque ripristinare il genuino spirito italico e procedere alle riforme (pp. 44 s.), secondo la linea che apparterrà al programma della codificazione fascista nel ventennio (lui stesso da guardasigilli la riprese nel 1939: L’idea fascista nel nuovo codice civile, nella raccolta di saggi dallo stesso titolo, Roma 1940, pp. 22 s., 27). Quanto al manuale, ebbe due ulteriori edizioni (1918 e 1930), senza rinnovare l’impianto originario, ricalcato pedissequamente anche nei saggi d’occasione. Così nel 1929 pubblicò Gli elementi costitutivi del diritto civile italiano (ora nella raccolta Contributi alla storia del diritto comune, Roma 1937, pp. 45-67), in cui riproponeva le quattro componenti storiche dell’ordinamento nazionale. La stessa silloge ora citata era una mera riedizione di scritti precedenti e non risentiva del vivace dibattito sul diritto comune che dal 1932 aveva visto protagonisti Salvatore Riccobono e Francesco Calasso, Giuseppe Ermini ed Emilio Bussi. Questo declino nella produzione storico-giuridica – peraltro abbondantissima – fu velatamente riconosciuto persino da un allievo che pure verso di lui nutriva gratitudine e rispetto, Gian Piero Bognetti (altro importante discepolo fu Carlo Guido Mor).
Rieletto in Parlamento nel 1929 (e ancora nel 1934 e 1939) e sempre più proiettato nella vita politica, fu chiamato alla Statale di Milano sulla cattedra di scienza politica (decorrenza 1° dicembre 1931: tagliente il commento di Arturo Carlo Jemolo in Lettere a Mario Falco, II, Milano 2009, p. 200) e, dal 1936, di diritto comune. Ma l’impegno a Roma era assorbente, tanto più che nel 1932 fu nominato sottosegretario all’Educazione nazionale e poi, nel gennaio 1935, guardasigilli. I corsi erano perciò gestiti da supplenti (per ben cinque anni su sette dal cognato Dallari, persino per l’insegnamento di diritto comune, per altri due da Enrico Besta). Era giunto il suo momento: mai stato un movimentista, Solmi saliva ai vertici dello Stato fascista nella fase della stabilizzazione del regime. La facoltà giuridica della Sapienza nel 1935 irritualmente ne evocò la futura chiamata, non appena libero dal ministero.
Il vezzo autoassolutorio che ha pervaso la dottrina giuridica del dopoguerra ha influenzato anche recenti biografie, che tacciono del profilo politico del giurista. Conviene invece ricordarlo. Uomo di fiducia del dittatore – che per la carica di guardasigilli pensò sempre a personaggi dalla cultura robusta in grado di costruire e di raffrontarsi con il complesso mondo della scienza giuridica – e incline al culto della personalità (Monzali, 1994, p. 451), Solmi fu del tutto inserito nell’apparato del potere fascista.
Nel valutare l’attività ministeriale non decisive appaiono le denunce anonime di debolezza dell’uomo, che sarebbe stato in mano a consiglieri e all’onnipresente Dallari (è vero comunque che il guardasigilli inopinatamente inserì l’altro suo cognato Guido Dallari, avvocato a Modena, nella commissione incaricata del progetto di codice di procedura civile). Si tratta di accuse legate alla lotta interna tra i faccendieri del regime. Spesso definita inconcludente, in realtà la sua gestione del ministero appare tale solo se si usa come parametro l’attività di Alfredo Rocco o se si contano i codici realizzati da Dino Grandi. Sono almeno tre i settori in cui il guardasigilli Solmi lasciò tracce significative. Innanzi tutto l’abbandono del progetto italo-francese sulle obbligazioni e il riavvio dei lavori sul codice civile. Nel I libro (vigente dal 1° luglio 1939) «il marchio razzista era impresso nel suo primo articolo», che niente meno prevedeva deroghe per ragione di razza al principio di uguaglianza nella capacità di diritto; altri precetti discriminatori riguardavano poi tutti gli istituti familiari (Treggiari, 2013, p. 105). In secondo luogo l’approvazione delle leggi razziali, per le quali le indagini recenti hanno definitivamente accertato la responsabilità del giurista emiliano (soprattutto Gentile, 2013 e Acerbi, 2014), di contro a benevole interpretazioni (Monzali, 1994, pp. 466 s.): del resto in numerose occasioni Solmi, che firmò un pezzo nel primo numero di La difesa della razza (1938) e che compare quale membro del comitato scientifico di Il diritto razzista (come Santi Romano, Pier Silverio Leicht, Giangastone Bolla e Fulvio Maroi), ribadì ex professo le aberranti tesi a tutela della stirpe ariana e la concezione di un ordinamento avente «la funzione di conservare la stirpe e di renderla capace di opere civili» (Prefazione a H. Frank, Fondamento giuridico dello Stato nazionalsocialista, Milano 1939, p. 8, e si veda inoltre Da Roma a noi: unità di storia, unità di popolo, in Politica fascista della razza, Roma 1940, in partic. p. 36). Infine il progetto di codice di procedura civile, sul quale la storiografia è divisa tra ‘revisionisti’, che lo indicano come un testo autoritario di marca fascista, e ‘negazionisti’, che non rinvengono tale carattere ideologico al di là delle frasi a effetto usate dal ministro stesso e dai giuristi del tempo per compiacere il regime.
Non sembra comunque questione di etichette definitorie. Solmi teneva particolarmente al codice di rito perché il processo era avvertito come farragine e sequenza di manovre dilatorie delle parti, sicché dalla sua riforma dipendeva la percezione di un salto di qualità nell’amministrazione della giustizia. Insediò una commissione di giuristi pratici – faceva eccezione la presenza di Enrico Redenti, autore solitario del progetto precedente – da lui stesso presieduta e con un sistema diretto a coinvolgere gli operatori del diritto nella discussione di un testo preliminare (1937). Nel merito il codice accentuava la posizione del giudice ‘signore della causa’ (poteva disporre prove d’ufficio, interrogare liberamente le parti, sanzionare le condotte ‘abusive’), contemplava l’obbligo di verità per le parti, prevedeva il giudice monocratico nei tribunali: affermava insomma il ruolo preminente dello Stato (Cipriani, 2006, pp. 360 s.; Ansanelli, 2017, pp. 260 s.).
Discusso in alcune sue parti, il progetto appare certamente esprimere lo spirito del fascismo al potere, di cui Solmi fu puntuale esecutore e divulgatore. Emblematico il suo affresco in La crisi dello Stato democratico (1937, tradotto in francese, inglese e tedesco) che spiegava sul terreno storico, sociale e istituzionale i benefici dello Stato fascista in opposizione alla ineluttabile degenerazione dei regimi democratici (decadenza della civiltà e della razza: già nel 1937).
Se il duce decise che occorreva dare nuovo impulso al ministero (non inusuale l’improvviso esautoramento dalle funzioni di guardasigilli, l’11 luglio 1939), Solmi ottenne però immediata udienza presso Mussolini: segno della stima perdurante di cui godeva o, più probabilmente, del potere contrattuale di cui disponeva. Come chiedeva, fu trasferito a Roma, senza chiamata della facoltà (1939: non memorabile la prolusione di inaugurazione del corso di diritto comune, che si concludeva con un inno alle conquiste del fascismo) e, seduta stante (12 luglio), ottenne la nomina a senatore nonché vari benefici economici e di status. Numerose ancora le sue pubblicazioni sul diritto fascista (alcuni saggi, per esempio, furono raccolti in L’idea fascista nel nuovo codice civile, cit.). La sua fortuna però declinava. Il mondo universitario gli dedicò due volumi (Studi di storia e diritto in onore di Arrigo Solmi, Milano 1941, che contengono anche una bibliografia dei suoi scritti fino al 1941: I, pp. XV-XXVII), ma Solmi dovette subire la decisione di conferire la cattedra di diritto civile alla Sapienza al suo successore quale guardasigilli, Grandi, che nessuna esperienza o titolo accademico poteva vantare per meritarla.
In pensione dal 29 ottobre 1943, ormai vedovo si divideva tra la casa di Grottaferrata e la residenza romana di via de’ Cavalieri 11. A breve distanza di tempo dalla madre morì il 5 marzo 1944 a Grottaferrata, giusto tre mesi prima della liberazione della città dal nazifascismo.(fonte)
[3] Via degli Orefici Bologna, prima piccolo vicolo, è ora una via conosciutissima della città ricca di ristoranti, bar e locali alla moda (tra cui il celebre Mercato di Mezzo) dove prenotare per cene romantiche o gustosi aperitivi con gli amici. La via comincia dalla Via delle Spaderie e termina a quella delle Caprarie. Si disse Gorgadello perché era una continuazione del Gorgadello, vicolo dei Ranocchi, si chiamò via di S. Cataldo per la piccola Chiesa di questo Santo che vi aveva la sua facciata, poi del Pavone da una spezieria con questa insegna che del 1500 trovandosi nel lato opposto degli Orefici sull’angolo del vicolo dei Ranocchi dalla parte della Piazza appartenente ai Lamberiini, la quale spezieria esisteva ancora nel 1546. Nel precitato anno 1506 era dell’eredità d’ Ulisse del fu Guidantonio Lambertini frate dell’ Osservanza dell’ ordine de’ minori di S. Francesco, nel cui inventario è qualificata per casa grande con la Chiesa piccola di S. Cattaldo in confine della via detta del Pavone, di Francesco Cavazza, e degli eredi di Giacomo Ringhieri, sotto la quale sono sei botteghe finalmente è conosciuto in oggi per stallatico del Sole. Divideva esso le case dei Lambertini da quelle dei Scannabecchi , rogito Pirro Beliossi. La cura d’anime fu data a S. Michele del Mercato di Mezzo. Si diceva che in questo vicolo vi corrispondessero le case di Giovanni degli Indovini già ambasciatore dei Bolognesi, e che per ragione di partito gli furono atterrate circa il 1320.(fonte)
[4] via Pescherie Vecchie nasce da Pescarie, il nome che indicava i luoghi in cui erano le botteghe per la vendita del pesce. Anticamente le Pescarie erano presso piazza di Porta Ravegnana.
Furono poi traslocate nella scomparsa via Pelliccerie, ed infine il 13 febbraio 1583 furono trasferite in questa via che cominciò ad essere chiamata Pescarie o Pescarie Nuove (per distinguerle dalle vecchie in via Pelliccerie).
La riforma toponomastica napoleonica del 1801 fissò il nome di questa via in Pescarie Nuove.
Nel 1817 le pescarie furono trasferite ad un nuovo locale predisposto tra via degli Orefici ed il Mercato di Mezzo (poi diventata via Rizzoli). Ciò determinò il cambio del nome della nostra via da Pescarie Nuove a via Pescherie Vecchie, cambio ufficializzato dalla riforma toponomastica del 1873-78.(fonte)
[5] Dino Grandi. Nacque a Mordano, presso Imola, il 4 giugno 1895, da Lino e Domenica Gentilini.
Il padre era un piccolo imprenditore agricolo fattosi da sé; la madre una maestra elementare. In famiglia il G. respirò un’aria di robusto patriottismo, alimentata da memorie risorgimentali ancora fresche; e si appassionò presto alla politica in un clima caratterizzato dalle lotte contadine della Valle Padana. In casa poté conoscere A. Costa, amico dei suoi; ed ebbe, come insegnanti elementari, un socialista e un repubblicano, protagonisti di accese discussioni col padre, liberale e monarchico, ma con un debole per la passione nazionale di G. Mazzini.
Al liceo classico Ariosto di Ferrara il G. incontrò Italo Balbo, fervente repubblicano; e si accostò a Pagine libere, rivista di un sindacalismo rivoluzionario attivissimo nella città estense. Nel pensionato cattolico, dove viveva, il G. fu introdotto alle idee della Lega democratica nazionale postmurriana, per la quale inizialmente simpatizzò. Innamoratosi delle opere di A. Oriani, seguì con passione le riviste allora dette d’avanguardia, con particolare interesse per La Voce di G. Prezzolini. Si formò, così, nell’atmosfera severamente contestatrice del giolittismo in nome del nazionalismo e del radicalismo nazionale in politica e del neoidealismo e delle “filosofie della vita” sul piano della lotta al positivismo in campo culturale.
Iscrittosi, nel 1913, a giurisprudenza nell’ateneo bolognese, il G. si scoprì vocato alla professione giornalistica. Decisivo fu l’incontro con N. Quilici e, tramite lui, con M. Missiroli, direttore de Il Resto del Carlino.
Il primo lo avviò al praticantato, portandoselo dietro, fra l’altro, sia a Vienna alla vigilia dell’attentato di Sarajevo, sia a Roma, dove il G. fece il “pastonista” parlamentare, timidamente accostandosi agli ambienti del grande giornalismo dell’epoca (conobbe anche personalmente Prezzolini). Il secondo gli fece da maestro; e in specie la sua opera Monarchia socialista rafforzò nel G. la convinzione che la questione sociale dovesse trovare la sua soluzione in un rinnovamento e potenziamento della funzione dirigente del liberalismo senza cedimenti alla controcultura socialista. Solo così il movimento di ascesa dei ceti popolari avrebbe potuto servire la causa del compimento dello Stato risorgimentale, eliminando la frattura tra paese legale e paese reale con la nazionalizzazione delle masse; mentre G. Giolitti era accusato di indebolire lo Stato, “infeudandone” pezzi alle organizzazioni extraistituzionali e internazionalistiche del socialismo. Non stupisce che il G., spintovi dallo stesso Quilici, abbia più che simpatizzato, in questo periodo, per il “giovane liberalismo” di G. Borelli, e poi per i gruppi nazional-liberali, staccatisi dall’Associazione nazionalista italiana dopo la sua svolta antiliberale del 1914. Tanto da operare, il G., nel 1915, quale segretario di redazione del neonato settimanale L’Azione, fondato e diretto da P. Arcari e A. Caroncini (allievo di V. Pareto e M. Pantaleoni e professore a Bologna).
Inviato dal Resto del carlino a raccogliere notizie sulla famosa riunione della direzione socialista che espulse B. Mussolini, nel novembre 1914, il G. volle, tuttavia, manifestare subito per iscritto la sua ammirazione per il “convertito” all’interventismo. Le cui ragioni finì per condividere assai più di quelle di A. Salandra, tanto da essere protagonista, insieme con S. Panunzio, del grande comizio studentesco per la guerra, organizzato all’Università di Ferrara, nell’aprile 1915, dal Fascio rivoluzionario estense.
Entrata l’Italia nel conflitto nel maggio successivo, il G. presentò invano domanda di arruolamento volontario. Richiamato alle armi con la sua classe, fu ufficiale degli alpini, guadagnandosi sul campo la promozione a capitano, oltre a una medaglia d’argento e a una di bronzo.
Partì con la camicia rossa sotto quella di ordinanza e con l’entusiasmo tipico della sua generazione educata alla scuola “carducciana”; convinto, come tanti coetanei, di andare a compiere il Risorgimento con una guerra di popolo, che avrebbe “educato” e “riformato” la nazione, costituendola in unità morale e proiettandola da protagonista sul proscenio europeo. La lunga e dura realtà del conflitto di trincea, così poco romanticamente garibaldino e così tanto anonimo nella sua natura di estenuante cozzo di logoramento di mezzi e di masse, lo restituì al dopoguerra voglioso, soprattutto, di normalità privata.
Approfittando delle speciali provvidenze per gli studenti ex combattenti, tra la fine del 1919 e i primi del 1920 il G. si laureò e conseguì il diploma di procuratore legale. La sua tesi in economia politica, per la quale chiese lumi anche a Pareto, G. Salvemini e F. Turati, e di cui fu relatore F. Flora, rivelava fin dal titolo una fede liberista: “La Società delle Nazioni e il libero scambio”, visto, quest’ultimo, quale unica soluzione per impedire una nuova “lotta di classe internazionale” fra nazioni “proletarie” e nazioni “plutocratiche”.
Il G. continuava, infatti, a proclamarsi liberale, come attestato dalla sua assidua collaborazione a La Libertà economica di A. Giovannini; ma coniugava tale idea con categorie desunte dal nazionalismo, dagli eretici della sinistra, da certe sintesi operate nel crogiolo interventista. Fu, pertanto, convinto assertore della tesi dei due pesi e delle due misure adottate dagli ex alleati in materia di giustizia internazionale, con conseguente “mutilazione” della vittoria italiana; avversò duramente il “bolscevismo” nostrano, ma sperò in una conversione al liberalismo e alla nazione del socialismo riformista; considerò positivamente il leninismo quale atto di ribellione di una nuova Russia nazionalrivoluzionaria alle “prepotenze” degli occidentali, equiparando il significato di tale rivoluzione a quello, per l’Italia, dell’impresa fiumana di G. D’Annunzio.
Deluso dagli esiti di un dopoguerra così diverso dai sogni del “maggio radioso”, e ormai rassegnato alla resa dello Stato liberale, la cui classe dirigente gli appariva incapace di rinnovarsi, il G. si sarebbe probabilmente dedicato solo all’avvocatura o al giornalismo, se non fosse stato fatto oggetto, a Imola, di un attentato da parte di elementi dell’estrema sinistra nell’ottobre 1920. Subito dopo i tragici fatti di palazzo d’Accursio (21 novembre), il G. si iscrisse al Fascio di combattimento di Bologna, dove assunse immediatamente un ruolo di primo piano, come direttore dell’organo L’Assalto, per divenire in seguito segretario politico regionale dei fasci emiliano-romagnoli.
Inizialmente il G. attribuì al fascismo una semplice funzione “reattiva”, di restaurazione della legalità, tanto da cercare un dialogo con i socialisti per convincerli a schierarsi su posizioni turatiane. Ma poi il solco scavato dalle violenze, l’entusiasmo per le vittorie conseguite dallo squadrismo, la nuova realtà dei sindacati nazionali edificati sulle macerie delle brutalizzate organizzazioni della sinistra, persuasero il G. del contrario. E cioè che il fascismo, pur rimanendo, alla lunga, un fenomeno transitorio, rappresentasse in toto la nazione, e che, dunque, da esso sarebbero dovuti nascere nuovi partiti e sindacati in sostituzione di quelli vecchi, giudicati o antinazionali o nazionalmente inadeguati.
Eletto deputato nella lista del Blocco nazionale nel maggio 1921 (ma dichiarato decaduto, perché sotto i trent’anni, nel giugno 1922), il G. si oppose al patto di pacificazione (voluto da Mussolini nell’estate di quello stesso anno) per non privare i sindacati nazionali della Valle Padana dell’indispensabile ombrello dello squadrismo.
La contestazione dei fascisti padani fu, allora, durissima, al punto da causare quasi la spaccatura del movimento; e proprio il G., con Balbo, venne inviato a visitare D’Annunzio a Gardone per offrirgli la guida dello squadrismo ribelle. La deludente risposta del “vate”, la constatazione che per il fascismo Mussolini rimaneva un leader insostituibile, l’esperienza del congresso romano dell’Augusteo – tenutosi, nel novembre successivo, al chiuso d’un teatro e in un clima quasi di “assedio” -, così inusitata per capi e capetti abituati a spadroneggiare in periferia, convinsero il G. della bontà di molte delle ragioni del contestato. Perciò, una volta ottenuti il sacrificio del patto e il riconoscimento del peso del fascismo padano in un movimento non più solo “milanese”, il G. fu il primo, fra i “signori” della rivolta, a rendersi conto della necessità di assecondare la linea politico-parlamentare di Mussolini, giudicando assolutamente velleitaria, e quindi suicida, l’opposta attitudine “rivoluzionaria” dei ras di provincia.
Durante la marcia su Roma il G. – capo di stato maggiore del quadrumvirato fascista – fu persino più moderato di Mussolini: tanto da dover subire l’accusa di tentata “mutilazione” della vittoria per essersi dichiarato favorevole a una soluzione V.E. Orlando o Salandra. Sottoposto a un periodo di “quarantena” politica, nel corso del quale rifiutò di fatto l’offerta mussoliniana del vicecommissariato generale per l’emigrazione, il G. fu poi eletto deputato nell’aprile 1924, e ricoprì la carica di vicepresidente della Camera. Durante la crisi seguita all’assassinio di G. Matteotti il G. sostenne intransigentemente Mussolini, da cui fu nominato sottosegretario all’Interno nel luglio 1924 (ministro L. Federzoni).
Al Viminale il G. si distinse per il totale allineamento con le posizioni di Mussolini: avverso, ovviamente, all’antifascismo, contrastò anche l'”illegalismo” del radicalismo fascista, predicando l’assoluta necessità della “normalizzazione” del Partito nazionale fascista (PNF) e della sua stretta subordinazione allo Stato. Agli uni oppose il principio dell’irreversibilità della conquista fascista del potere; agli altri il dovere per il fascismo, ottenuto il governo, di farsi Stato, risolvendo la rivoluzione in una nuova legalità, con inevitabile sacrificio della “santa canaglia” estremista, da lui giudicata sempre dannosa una volta finito il tempo delle barricate. Non a caso, quando a Firenze, il 31 dic. 1924, a tre giorni dal famoso discorso mussoliniano alla Camera del gennaio 1925, le camicie nere di T. Tamburini si presentarono in forze davanti al carcere delle Murate per liberare i camerati reclusi, il G. ordinò personalmente ai carabinieri di sparare sui fascisti in caso di attacco.
Nel maggio 1925 il duce volle il G. sottosegretario agli Esteri (ministro Mussolini) con l’esplicito incarico di fascistizzare un dicastero quasi nemmeno lambito dai nuovi venuti. Sulle prime il G. non apprezzò affatto questo suo allontanamento dalla politica interna e di partito (a vantaggio di L. Arpinati a Bologna), e giudicò la decisione un ingrato cedimento alle richieste del segretario del PNF, R. Farinacci (cogliendo in parte nel segno). Ben presto, tuttavia, la scelta mussoliniana si dimostrò azzeccata e lo stesso G. arrivò a definire gli Esteri la vera vocazione della sua vita.
L’opera del G. consistette essenzialmente nella massiccia immissione, mediante concorso, di elementi fascisti nei ruoli ministeriali, nell’assunzione in proprio delle funzioni di segretario generale (cioè di capo della “carriera”), nella ristrutturazione del dicastero e nella riforma dell’intero ordinamento diplomatico e consolare.
Nel settembre 1929 il G. fu promosso ministro con l’incarico di rendere unitaria, organica e autonoma la politica estera italiana.
Ormai pressoché risolto il problema della stabilizzazione del regime, e parzialmente rimessasi in movimento la situazione internazionale, il duce intendeva dinamicizzare la diplomazia fascista, fin lì subalternizzata alle esigenze prioritarie della politica interna. Di qui la decisione di “delegare” a un altro la conduzione del ministero, anche per poter eventualmente usare il G. come capro espiatorio in caso di insuccesso. La scelta dimostrava, poi, quanto Mussolini apprezzasse il lavoro di un uomo che identificava ormai il fascismo nella dittatura “di salute pubblica” del duce e concepiva il rapporto tra quest’ultimo e i gerarchi nei termini di quello tra Napoleone e i suoi marescialli.
La consegna ricevuta dal “capo” prevedeva che l’Italia approfittasse del rinnovato attrito franco-tedesco, dopo la fase distensiva di A. Briand e G. Stresemann, per costringere Parigi a soddisfare le richieste di Roma, ottenendone in cambio la collaborazione per la difesa dell’ordine europeo.
Pur consapevoli che la questione dell’indipendenza austriaca avrebbe continuato a dividere Italia e Germania, Mussolini e il G. intendevano esibire una politica di “fredda equidistanza” tra Parigi e Berlino per convincere la prima a saldare il “debito” contratto con gli Italiani nel 1919 a Versailles. In tale ottica sarebbe stato necessario conseguire l’obiettivo dell’intesa con la Francia prima che la Germania costituisse una minaccia reale per tutti; impresa, questa, per nulla facile, visto che Parigi riteneva di avere con Roma il coltello austriaco dalla parte del manico, e che l’Italia pretendeva di essere riconosciuta dalla Francia come grande potenza a livello paritario in Europa e nel Mediterraneo.
Per premere sulla controparte il G. finì per giudicare non sufficienti né le iniziative antifrancesi nell’area danubiano-balcanica (satellizzazione dell’Albania, nonché sostegno al revisionismo ungherese e ai separatismi macedone e croato), né i segnali distensivi lanciati alla Germania. Decise, allora, di mutare atteggiamento nei confronti della Società delle Nazioni, trasformandola nel polmone della sua azione diplomatica. E ciò non per un improvviso amore per l’istituzione tanto invisa al fascismo quanto per l’opinione che Ginevra fosse comunque la sede di dibattimento delle grandi questioni europee e potesse costituire un ottimo campo di manovra per una potenza mirante a ottenere per via diplomatica un rango superiore a quello corrispondente alla sua effettiva forza economica e militare. Occorreva, in sostanza, mostrarsi sostenitori della Società delle Nazioni al solo scopo di servirsene in funzione dei programmi italiani.
Autorizzato da Mussolini all’impiego del “più spudorato linguaggio della menzogna”, il G. inaugurò una stagione del tutto anomala nella politica estera fascista, caratterizzata da una linea apparentemente societaria, locarnista, persino disarmista e pacifista. Tutto ciò al fine di accreditare gli Italiani presso gli Inglesi (e, al di fuori della Società delle Nazioni, presso gli Americani) quali soci più affidabili dei Francesi in materia di stabilizzazione europea, “nevrastenizzando” al contempo Parigi con l’attraversare sistematicamente i suoi piani, col patrocinare la causa della pari dignità tedesca, con l’avanzare proposte miranti a far ricadere sulla Francia la responsabilità dell’eventuale fallimento delle trattative in corso sul disarmo (a proposito delle quali basterà ricordare la Conferenza navale di Londra del 1930 e quella generale di Ginevra del 1932).
L’azione del G. valse, indubbiamente, ad accrescere il prestigio internazionale dell’Italia fascista, che ebbe ottimi rapporti con Londra e con Washington. Ma – a parte un’avance di P. Laval nel luglio 1931, lasciata cadere da Roma, perché giudicata prematura, nonostante un esplicito riferimento all’Etiopia – essa non recò il frutto di un decisivo ammorbidimento francese, né quello di una significativa pressione britannica su Parigi a beneficio del punto di vista italiano. Al contrario, l’aggravarsi della crisi economica e politica europea sfociò in un rafforzamento dell’intesa anglo-francese, manifestatosi alla Conferenza di Losanna sui debiti e le riparazioni di guerra, nel luglio 1932. Già sottoposto a frequenti e pesanti critiche all’interno per una politica giudicata contraria all’ideologia fascista, il G. scontò l’insuccesso con il licenziamento, svolgendo la funzione preventivata di capro espiatorio di una linea voluta, in realtà, da Mussolini; anche se il G. aveva finito per distinguervisi per fervore societario.
Fu Balbo, da tempo ai ferri corti con l’ex amico per rivalità personale e per dissidio politico, a rendersi clamorosamente portavoce, su Il Popolo d’Italia del 31 luglio, del malcontento fascista e della volontà di uno stile più “littorio” in diplomazia. Ma che il duce non fosse così insoddisfatto del proprio collaboratore fu dimostrato dalla successiva destinazione del G.: la strategica ambasciata di Londra. La Gran Bretagna avrebbe dovuto svolgere un ruolo centrale nel progetto mussoliniano di patto a quattro, ovvero di “direttorio” europeo, con Roma e Londra a elementi arbitrali dell’attrito franco-tedesco, negli auspici così foriero di una vantaggiosa, per l’Italia, intesa italo-francese.
Il G. si era già attirato molte simpatie in terra d’Albione e pareva l’uomo giusto per trattare con gli Inglesi; e, in effetti, divenne un anglofilo sincero e adottò persino un certo stile britannico. Non solo: come ambasciatore si dimostrò abilissimo nello sfruttare l’arma dell’amicizia personale, comunque cruciale con gli Anglosassoni. E non mancò di suscitare l’ammirazione di diplomatici e politici operanti a Londra, abbellendo la sede di Grosvenor square con opere d’arte prelevate dai magazzini dei nostri musei, dove esse giacevano inutilizzate. Riorganizzò, poi, tutta la “macchina” dell’ambasciata, adeguandola, a modo suo, alle esigenze del regime cui apparteneva. Grosvenor square divenne, pertanto, il centro di una molteplice attività organizzativa e propagandistica, rivolta non solo alla comunità italiana, ma anche agli interlocutori britannici, e che tornò assai utile nei momenti di maggior contrasto tra Roma e Londra, a cominciare dall’affaire abissino. Freddo nei confronti dell'”universalfascismo” e ostile all’interferenza ideologica nella politica estera, il G. sostenne le camicie nere di O. Mosley più per dovere (cioè per obbedienza a Roma) che non per convinzione. Salvo una prima, breve illusione, egli non credette mai alla possibilità di una “fascistizzazione” del sistema politico inglese; e dunque giudicò più conveniente operare sui tradizionali partiti britannici, senza escludere i laburisti, almeno fino alla crisi etiopica. Con i conservatori, infatti, il G. giocò la carta del Mussolini anticomunista e “disciplinatore” del popolo italiano; con i laburisti quella del Mussolini riformatore sociale, grazie al corporativismo; con entrambi valorizzò la ben diversa moderazione del duce rispetto ad A. Hitler sulle questioni europee. Particolare fu la cura dedicata dal G. ai rapporti con la stampa britannica; e in ciò gli giovò assai l’amicizia acquisita con lord W. Beaverbrook e lord H. Rothermere, proprietari di importanti testate.
Fermo alla concezione della transitorietà del fascismo (che, a suo parere, in quanto regime a partito unico, non sarebbe sopravvissuto a Mussolini) e a quella della sua esclusiva funzione di strumento dell’imperialismo italiano, il G. non ebbe mai alcuna debolezza per il nazionalsocialismo, se non come spauracchio da agitare davanti alla Francia per costringerla a patti con l’Italia. Fu, dunque, favorevole all’uso della carta tedesca a scopo tattico, ma nella inalterata convinzione che gli interessi strategici di Roma e Berlino rimanessero opposti. Persuaso, al pari di Mussolini, che i tempi del revanscismo germanico sarebbero stati più lenti di quanto poi, invece, avvenne, il G. giudicò raggiunti gli obiettivi italiani con l’intesa Mussolini-Laval del gennaio 1935 e con il “fronte di Stresa” dell’aprile successivo. Intransigente sul “diritto” italiano a “marciare” in Etiopia, il G. arrivò ad “annacquare” i rapporti inviati a Roma sull’ostilità inglese alla campagna abissina, pur di spingere il duce a trarre il dado nel momento della sua incertezza sull’attitudine britannica; e contribuì a combinare un pasticcio, come dimostrato dall’invio della Home Fleet nel Mediterraneo, in settembre, e dalle sanzioni della Società delle Nazioni, in novembre. Capita l’antifona, il G. usò lo stesso metodo per comporre quanto prima il dissidio anglo-italiano e impedire un eccessivo avvicinamento italo-tedesco.
Il G. e R. Vansittart, sottosegretario permanente al Foreign Office, negoziarono di fatto il piano Laval-Hoare, che andò a un passo dalla composizione diplomatica del conflitto già nel dicembre 1935; e fu il G., disobbedendo a Mussolini, a votare con Londra e Parigi contro Berlino, in sede di Consiglio della Società delle Nazioni, sulla questione della rimilitarizzazione della Renania (marzo 1936). Pure decisiva risultò, naturalmente, la mediazione del G., a impresa etiopica conclusa, per il ritiro della Home Fleet dal Mediterraneo e la revoca delle sanzioni nel luglio 1936, tanto che il Daily Express arrivò a definire l’ambasciatore italiano “the winner”. Solo l’inizio della guerra civile spagnola indusse un irritatissimo Mussolini a non trasferire il G. a Rodi o Buenos Aires, come suggerito dal geloso neoministro degli Esteri, G. Ciano, entrato in carica nel mese precedente.
Gli anni seguenti furono assai difficili per il G., preoccupato per le conseguenze negative sulle relazioni italo-britanniche dell’intervento italiano in Spagna e dell’Asse Roma-Berlino. Fervido sostenitore di F. Franco in funzione anticomunista e antisovietica, il G. fece di tutto per convincere gli Inglesi che l’Italia non aveva mira alcuna sulla penisola iberica e che avrebbe ritirato i propri “volontari” appena garantita la vittoria ai “nazionali” spagnoli. Al contempo si adoperò per un’intesa paritaria fra i due Imperi, quale unico mezzo per impedire un epilogo matrimoniale del “fidanzamento” italo-tedesco, previa anche pressione britannica sui Francesi perché abbandonassero la linea degli intransigenti “jamais” opposti alle ulteriori richieste italiane. Su questo cammino il G. individuò tre ostacoli: A. Eden, J. von Ribbentrop, G. Ciano.
Del primo ebbe ragione nel febbraio 1938, quando N. Chamberlain sostituì al Foreign Office Eden con lord E. Halifax, pure per effetto dei rapporti diretti instaurati con il G. grazie anche allo spregiudicato uso, da parte del G., di ogni mezzo per convincere il premier, inclusa l’invenzione di inesistenti messaggi personali di Mussolini al primo ministro britannico. Verso il secondo nutrì un’avversione permanente, nata nel periodo in cui, fra l’ottobre 1936 e il febbraio 1938, Ribbentrop fu ambasciatore tedesco a Londra ed esecutore del “doppio gioco” germanico mirante a usare la minaccia italiana per invogliare gli Inglesi a un’intesa con Berlino. Del terzo il G. diffidava assai, non ritenendolo capace di “moderare” Mussolini, di padroneggiare con equilibrio una situazione delicatissima, di vincere la propria ambizione protagonistica, che lo induceva, anzi, a un’attitudine “eccitatrice” del duce in Spagna, con Hitler e nelle aree di tensione con l’Impero britannico (a cominciare dal mondo arabo). Ma più di tutti lo preoccupava Mussolini, che il G. giudicava sempre meno il Realpolitiker e il “cancelliere” del passato, in quanto sempre più posseduto dal “demone” ideologico e cesaristico, e quindi dalle sirene della solidarietà totalitaria con il Führer e del mito, dal duce stesso creato, della propria infallibilità e dell’invincibilità del fascismo.
Il lavoro del G. – svolto non di rado indipendentemente dalle istruzioni di Roma, e, talora, addirittura in contrasto con esse – contribuì alla firma sia del gentlemen’s agreement, nel gennaio 1937, sia, soprattutto, degli “accordi di Pasqua” (aprile 1938), con cui Londra riconobbe formalmente l’Impero italiano, con mutua garanzia dello status quo mediterraneo. Creato conte di Mordano nel giugno 1938, il G. riuscì anche a spingere Chamberlain a rivolgere un appello personale a Mussolini, nel settembre successivo, per esortarlo a convincere Hitler al negoziato sulla questione dei Sudeti, aprendo così la strada alla conferenza di Monaco. Ma non riuscì ovviamente, il G., né a persuadere gli Inglesi a privilegiare l’amicizia italiana rispetto a quella francese, né, tanto meno, a impedire il Patto d’acciaio (maggio 1939), che fu all’origine del suo stesso richiamo da Londra (luglio successivo), con sincero dolore di quei britannici favorevoli a una distensione definitiva con l’Italia.
Analogamente a quanto accaduto nel 1925, anche nel 1939 Mussolini impose al G. un radicale cambiamento d’attività, affidandogli, tuttavia, un incarico difficilmente interpretabile nell’ottica del siluramento: ministro di Grazia e Giustizia per il completamento, fra l’altro, della riforma dei codici. Il ritorno al governo di un fascista del tipo del G. fu volutamente un messaggio rivolto agli interlocutori esteri e agli stessi elementi radicali del partito. Di fatto il G. si oppose a ogni interferenza del PNF nel funzionamento della giustizia e nella stesura dei codici civile, di procedura civile e navale (entrati in vigore il 21 apr. 1942), valendosi anzi, nel relativo “cantiere”, della collaborazione di giuristi antifascisti, come P. Calamandrei, ed ebrei, come C. Vivante.
Inoltre il G. puntò sempre, persino in piena guerra, a sottolineare e valorizzare la diversa natura del diritto fascista e di quello nazionalsocialista, da lui definiti specchio di due identità nazionali irriducibili l’una all’altra. Infine egli si dichiarò fermo sostenitore della continuità dello Stato dal Risorgimento al fascismo, e, in qualità di guardasigilli, cioè di “coscienza del re”, si atteggiò a difensore dei meccanismi “costituzionali”, a cominciare, in epoca di vicenda “diarchica”, dalle prerogative della Corona. E ciò, in realtà, per significare la propria avversione al totalitarismo “integrale” così di moda nel fascismo di fine anni Trenta, che giudicava troppo incline all’imitazione dei camerati del Führer.
Scoppiata la guerra, nel settembre 1939, il G. sarebbe stato favorevole alla denuncia del Patto d’acciaio per inadempienza tedesca, invece che alla semplice “non belligeranza” filogermanica. In ogni caso, il comune atteggiamento ostile all’intervento italiano spinse G. Ciano a chiedere, dopo la morte del padre Costanzo, che fosse il G. a prenderne il posto, alla fine di novembre del 1939, alla presidenza della Camera dei fasci e delle corporazioni.
Vivamente preoccupato dal possibile effetto sul duce dell’attacco hitleriano a Ovest nell’aprile 1940, il 21 dello stesso mese il G., unico fra i gerarchi, scrisse un’inutile lettera a Mussolini, esortandolo a non entrare in un conflitto tutt’altro che deciso e che, piuttosto, imponeva all’Italia di fortificarsi e di riarmare per fronteggiare in piena libertà qualsiasi futuro.
Entrata l’Italia in guerra, il 10 giugno seguente, il G. si adeguò al motto inglese “right or wrong, my country”, e sperò naturalmente, finché lo ritenne possibile, nella vittoria delle armi italiane. Il disastroso esito della campagna di Grecia, cui egli partecipò, inviato al fronte con gli altri gerarchi, da tenente colonnello degli alpini, lo convinse della necessità di una pace separata, onde evitare agli Italiani la satellizzazione alla Germania. Per questo il G. rifiutò la carica di governatore civile di un’Ellade piegata e occupata solo grazie all’aiuto tedesco, senza, tuttavia, poter fare alcunché, a Roma, per modificare il corso degli eventi. Anzi, dimesso da ministro nell’ambito del “cambio della guardia” governativo del febbraio 1943 (che costò il posto anche a Ciano e a G. Bottai), ma, ricevuto il collare dell’Ordine dell’Annunziata nel marzo successivo, il G. provò a convincere il re a licenziare Mussolini, trovandolo, però, assai refrattario, e comunque disponibile a muoversi esclusivamente nel caso di un voto di sfiducia al duce da parte di un organo costituzionale.
Unicamente nel corso delle drammatiche vicende del luglio 1943, seguite al vittorioso sbarco angloamericano in Sicilia, si presentò al G. l’occasione per tentare di attuare i propri propositi, grazie, paradossalmente, a un “pronunciamento” di gerarchi guidati da C. Scorza e Farinacci, che “estorse” a Mussolini la convocazione del Gran Consiglio. Fu allora che il G., sostenuto soprattutto da Federzoni e, con qualche equivoco, da Bottai, concepì il noto ordine del giorno (comunicato pure al “capo” nel corso di un lungo colloquio svoltosi a palazzo Venezia il 22), che provocò, il 25 luglio, la caduta del duce, al termine di una drammatica seduta in cui si dimostrarono decisive l’energia e la risolutezza dello stesso G. ma anche l’impossibilità, per Mussolini, di accettare l’opposta linea radical-assista di Scorza e Farinacci.
Il programma del G. prevedeva la restituzione al re dei suoi poteri politici e militari, la formazione di un governo di unità nazionale aperto all’antifascismo monarchico e cattolico, nonché privo di gerarchi, un immediato rovesciamento del fronte per trattare con gli ex nemici già da alleati di fatto. Ciò al fine di evitare la resa a discrezione e di tentare il traghettamento del paese dal fascismo al postfascismo, invece che all’antifascismo (cioè, secondo il G., al comunismo), salvando la monarchia e il “meglio” del fascismo stesso: un sistema politico costituzional-autoritario, l’ordinamento corporativo, la nazionalizzazione delle masse, una, sia pur ridotta, dimensione di potenza per l’Italia.
Il governo di P. Badoglio (cui il G. avrebbe preferito di gran lunga E. Caviglia, perché di Badoglio non si fidava) prese un’altra strada e, del resto, gli Angloamericani, per ragioni diverse, non avevano alcuna intenzione di usare la manica larga con gli Italiani. Il G. non approvò affatto né la natura non politica del ministero (di militari e funzionari), né l’arresto di Mussolini, né la decisione di proseguire la guerra al fianco della Germania, né le successive misure contro i gerarchi con aperture all’antifascismo. Solo il 18 ag. 1943 ottenne di essere inviato a trattare con gli Inglesi, che egli s’illudeva di poter ammorbidire; ma non giocò alcun ruolo nelle trattative armistiziali, se non quello di contribuire, con il suo viaggio in Spagna e Portogallo, a depistare i Tedeschi. Sempre fedele al re (nonostante le critiche per la gestione della crisi, ufficialmente rivolte al capo del governo e al ministro della Real Casa, P. Acquarone) e sottoposto a un’occhiuta vigilanza da parte dei “servizi” della Repubblica sociale italiana (RSI; i relativi rapporti da Estoril, sulla costa lusitana, nuova residenza del G., furono sempre visionati e vistati personalmente da Mussolini) e dei nazisti (che provarono anche a rapirlo), il G. fu naturalmente condannato a morte in contumacia al processo di Verona del gennaio 1944 ed ebbe i beni posti sotto sequestro dalla RSI (gli furono in buona parte restituiti nel dopoguerra, previo concordato).
La sua carriera politica ebbe termine definitivo quando F.D. Roosevelt pose il veto, alla fine di settembre del 1943, a un suo reimpiego in incarichi di governo, probabilmente quale nuovo ministro degli Esteri dopo la liberazione di Roma, secondo il desiderio manifestato da Vittorio Emanuele III a uno scettico Badoglio. Ai guai giudiziari con i fascisti, seguirono quelli con gli antifascisti.
Non potendo ottenere l’estradizione del G. dal Portogallo, in quanto la convenzione del 1878 non prevedeva il caso del reato politico, nel periodo del governo di F. Parri l’alto commissario per le sanzioni contro il fascismo, P. Nenni, tentò la via della traduzione del G. davanti alla corte alleata per i crimini di guerra; ma ne fu impedito con sdegno dagli Inglesi, Eden in testa.
Giudicandosi un “vinto” e un “sopravvissuto” nel mondo politico del dopoguerra, temendo l’avvento del comunismo in Italia e mirando a rifarsi un’esistenza esclusivamente privata, il G. non approfittò della sentenza di assoluzione, emessa nel 1947 dalla corte d’assise speciale di Roma al termine del processo intentatogli quale ex gerarca fascista, per rientrare subito in patria. Dal Portogallo, dove aveva condotto vita assai modesta, si spostò a San Paolo del Brasile, iniziandovi una nuova fortunata carriera nel campo delle professioni e degli affari.
Prima aprì uno studio di avvocato internazionale, decollato grazie all’incarico di consulenza legale ricevuto da J.P. Kennedy, che era stato per un periodo suo collega in quanto ambasciatore statunitense a Londra. Poi fondò, in Brasile, una società per la vendita di trattori agricoli della FIAT, riuscendo a rompere il monopolio dei Rockefeller. Infine diventò vicepresidente della Techint di A. Rocca.
Tornato in Italia a fine anni Cinquanta, il G. creò ad Albareto (Modena) un’azienda agricola modello. Nonostante alcune sollecitazioni di parte monarchica, egli non volle più svolgere alcun ruolo politico, salvo intervenire discretamente, quando richiesto, in difesa di interessi italiani presso ambienti statunitensi e inglesi, sempre molto disponibili con lui, rimasto assai legato anche a W. Churchill. Grande amico dell’ambasciatrice statunitense in Italia dal 1953 al 1956, Clara Boothe Luce, consorte del proprietario di Time-Life, il G. esercitò pure opera mediatrice tra l’Ente nazionale idrocarburi (ENI) di E. Mattei (personaggio dal G. stimato) e le compagnie petrolifere statunitensi.
Salvo qualche intervento giornalistico (in particolare la riflessione Ecco Mussolini, pubblicata su Epoca il 18 apr. 1965), solo negli anni Ottanta il G., definendosi né nostalgico né pentito, ritenne che vi fossero le condizioni per fornire la sua versione dei fatti. Videro, così, la luce volumi in cantiere da gran tempo, come quelli sul 25 luglio e sulla politica estera italiana tra il 1929 e il 1932, nonché quello delle memorie, in cui il G. cercò soprattutto di spiegare il suo particolare “mussolinismo”, controverso rapporto di “fedeltà disubbidiente” con il duce, nel tentativo di dimostrare di non aver mai tradito il proprio paese, e nemmeno, al di là delle apparenze, il proprio capo.
Il G. morì a Bologna il 21 maggio 1988.(fonte)
[6] Capo della Direzione di Governo Agricoltura e Lavoro di Rodi, Giorgio Ghigi.
Già nel novembre del 1923, portando i saluti del Governo Egeo al Congresso Nazionale per l’Espansione Economica e commerciale all’Estero, il segretario di Governo Ghigi, affermava, che la principale preoccupazione era quella di «prepararsi, lì in luogo sicuro, i mezzi [per poter] meglio di ogni altro affrontare il problema di trarre dalla vicina Asia i maggiori vantaggi». Pertanto, nel breve «periodo di sosta» che sarebbe passato fino alla “riapertura” del mercato turco, occorreva preparare all’immigrazione italiana mettendo in atto «tutte le provvidenze necessarie per assicurare a chi venga la possibilità di una vita quale ogniuno che sia abituato al mondo civile ha diritto di avere». Il saluto del Governo di Rodi, in D. Doria (a cura di), Atti del congresso nazionale per l’espansione economica e commerciale all’estero: Trieste, 4-8 novembre 1923, Il circolo di studi economici, Trieste 1924, pp. 349-351.
In un intervento all’Istituto Agricolo Coloniale di Firenze, il Segretario Generale di Governo, Ghigi avrebbe dichiarato che: «[gli abitanti di lingua greca] sono portati più al commercio e alla navigazione che all’agricoltura. Anzi in rapporto a quest’ultima la loro aspirazione è quella di ridurre sempre più al minimo la fatica. Valga un esempio che dice la loro psicologia. Un professore di agricoltura spiegava una volta ad un contadino i procedimenti applicando i quali avrebbe potuto raddoppiare la produzione del suo campo. Il contadino lo ascoltò con molto interesse ed alla fine con effusione gli disse: ti sono molto grato perché mi hai insegnato come potrò, d’ora innanzi, lavorare soltanto la metà del mio campo!» G. Ghigi, Le condizioni, cit.(fonte)
I nazionalisti confluiscono nel fascismo. 1 Marzo 1923
Il Comitato Centrale Nazionalista, riunito a Roma il 5 marzo, approva la fusione con il partito fascista.
Il 2 marzo erano convenute a Bologna le sezioni dell’Emilia-Romagna.
L’avv. Giorgio Ghigi aveva salutato la fusione come un fatto compiuto cui dare esecuzione “con perfetta e scrupolosa lealtà”.
I nazionalisti bolognesi Luigi Federzoni e Maurizio Maraviglia saranno nominati membri del Gran Consiglio del Fascismo.
Mussolini definirà l’unione coi nazionalisti “un matrimonio di convenienza” per motivi politici.(fonte)