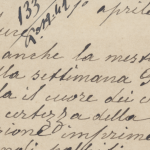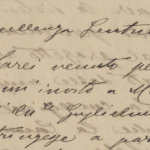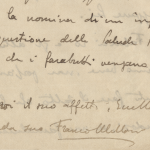CAMERA DEI DEPUTATI
Caro Bruchi[1],
la tua lettera meriterebbe una lunga risposta che in
questo momento non ho la possibilità di darti e mi limito
a far presente che pur ammettendo la nostra fallibilità
abbiamo in questi anni proceduto fra continue insidie per
una serie di passaggi obbligati.
Uno di questi è stata l’elezione di Gronchi[2] a cui siamo
stati costretti di aderire per secondare il pronunciamento
di quella parte della democrazia cristiana a cui appartengo-
no tutti gli uomini meritevoli di qualche fiducia e per
quanto mi riguarda non ti nascondo che ha influito anche
la speranza di veder messa in crisi la repubblica da un pre-
dente per il quale la tua profezia appare tuttaltro che in-
fondata.
Aggiungi a ciò che l’altro sarebbe stato un fiduciario
del governo o il procuratore del quadripartito mentre per il
pisano esistevano anche dei veti dall’altra riva del Tevere
e dell’Atlantico a cui bisognava reagire.
Quanto a Fanfani[3] che non credo valga più del suo con-
terraneo, fu De Gasperi[4] a volerne la caduta perché fin dal 13
dicembre del 54 aveva designato col discorso di novara. Scel-
a successore di Pella[5].
Ora io credo che a noi resti l’opposizione più intran-
sigente se vogliamo far salvo l’avvenire con questa dc[6] che
ha tutto l’interesse a mantenere il pericolo comunista allo
scopo di perfezionare l’instaurazione dello stato Pontificio
in Italia. E se noi siamo in qualche modo gli eredi del ri-
sorgimenti dovremo presto pronunsirci contro l’ingerenza del
potere religioso nel potere civile.
È una confidenza che ti faccio ma, come disse un giorno
un tale che da ultimo fu dominato dal timore di Hitler, non
bisogna aver paura di aver coraggio.
Quanto infine ai Vanoni[7] ai Segni[8], sono demagoghi della
peggiore specie e comincio a temere che lo stesso Pella non
meriti gli entusiasmi che ha suscitato, pur essendo indub-
biamente più onesto e serio degli altri.
In conclusione l’Italia non tornerà ad essere l’Italia
fino a quando non sarà spazzato questo mondo di profittatori
della sconfitta e speriamo che ciò possa farsi senza nuovi
capovolgimenti.
Io e mia moglie ringraziamo te e la signora dell’invito
a Lucignano e a proposito della colazione dobbiamo dirti che
fu eccellente e che tu sei ingiusto verso la padrona di casa
a lamentarti.
Abbimi con affetto
Carlo Delcroix[9]
18 giugno
1955 A matita
1° pagina in alto
2° pagina on. Delcroix Carlo
Firenze
Note
[1] Alfredo Bruchi. Nacque a Grosseto il 10 febbr. 1873 da Valentino e da Egle Landi, di ricca e nobile famiglia senese. Il padre era un brillante e famoso avvocato ed esercitava così a Siena come a Grosseto, dove d’estate, a causa della malaria, la vita quasi si arrestava e anche gli uffici pubblici venivano trasferiti in un più salubre paese dell’interno, Manciano. I Bruchi, originari dell’Amiata, possedevano terre in Maremma e dei maremmani benestanti avevano tutte le caratteristiche, delle quali il B. ereditò senz’altro la perseveranza e lo spirito combattivo. Dopo aver seguito gli studi a Siena, si laureò in giurisprudenza nel 1895 e, allo scopo di perfezionare la sua preparazione professionale, si recò a Genova per lavorare nello studio di F. Ruffini.
Tornato a Siena nel 1898, il B. commciò a esercitare la professione forense, ma molti altri interessi occupavano la sua giornata: coltivava, infatti, lo studio della poesia (era un fervente carducciano) e quello della storia risorgimentale ed era – per la sua stessa natura – attratto dalla lotta politica. Nel 1899 fu eletto consighere del comune di Siena per il gruppo monarchico-liberale, iniziando così un’attività che lo portò a ricoprire importanti cariche pubbliche.
Nel Consiglio comunale di Siena il B. fu eletto più volte, assumendo anche vari assessorati; nel 1902 fu anche presidente della Società senese di mutuo soccorso fra gli operai. Ma la sua prima importante battaglia fu quella delle elezioni politiche del 1913: in tale occasione, infatti, pose la sua candidatura come rappresentante dell’Unione liberale monarchica Umberto I, un raggruppamento politico nato a Siena nel 1909 con l’intento di ricostruire il partito liberale dopo la sconfitta subita dal suo candidato, E. Falaschi nelle elezioni politiche di quell’anno. L’Unione liberale scelse però di nuovo il Falaschi, già eletto alla Camera nel 1904; e il B., non rispettando gli accordi presi per un unico candidato, si presentò come indipendente, appoggiato da un gruppo degli stessi liberali, tra i quali G. Sarrocchi, dai consiglieri comunali, dal prefetto, dall’aristocrazia e da buona parte del clero della campagna. I due giornali liberali di Siena, Il libero cittadino e La Lupa, si scagliarono violentemente contro di lui, accusandolo di aver tradito il partito e di aver rovinato le finanze comunali nella sua qualità di assessore ai Lavori pubblici. Da parte sua, il B. si difese dalle colonne della Vedetta senese e organizzò una potente e intimidatoria campagna elettorale, riuscendo a sconfiggere il Falaschi ed entrando in ballottaggio col candidato dei socialisti riformisti, Q. Nofri. Le votazioni di ballottaggio videro la netta vittoria di quest’ultimo, che ottenne anche molti voti liberali. La sconfitta del B. fece entrare in crisi il Consiglio comunale, che dette le dimissioni e fu sostituito, nel dicembre 1913, da un commissario regio.(fonte)
[2] Giovanni Grónchi. Uomo politico italiano (Pontedera 1887 – Roma 1978). Organizzatore sindacale; volontario e decorato nella prima guerra mondiale; nel 1919 fu tra i fondatori del Partito popolare per il quale fu deputato (1919-26). Presidente della Confederazione dei lavoratori cristiani; sottosegretario per l’Industria e commercio nel 1922, si dimise nel 1923, passando all’opposizione. Dichiarato decaduto dal mandato parlamentare (1926) per la sua attività aventiniana, tornò alla vita politica dopo il 25 luglio 1943; con A. De Gasperi, rappresentò la Democrazia cristiana nel CLN. Ministro dell’Industria e commercio (1944-46), fu alla Costituente presidente del gruppo parlamentare democristiano. Deputato per il collegio di Pisa nelle prime due legislature repubblicane, fu presidente della Camera dei deputati dal 1948 al maggio 1955 quando fu eletto, a grande maggioranza, presidente della Repubblica. Notevole importanza politica ebbero i suoi viaggi in visita ufficiale, primo capo di Stato italiano, negli Stati Uniti e nel Canada (26 febbraio -15 marzo 1956) e in Francia (aprile 1956). Allo scadere del mandato (maggio 1962) divenne senatore a vita di diritto.(fonte)
[3] Amintore Fanfani. Uomo politico italiano (Pieve Santo Stefano 1908 – Roma 1999). Fu segretario della DC (1954-59 e 1973-75) e più volte presidente del Consiglio (1958-59; 1960-62; 1962-63; 1982-83; 1987). Schierò la DC contro il divorzio nel referendum abrogativo del 1974. Aderì infine al Partito popolare italiano (1994).
Fu dal 1936 prof. di storia economica all’univ. del Sacro Cuore di Milano e dal 1955 al 1983 all’univ. di Roma. Dirigente della DC dal 1945, ininterrottamente parlamentare dal 1946 (deputato fino al 1968, quindi senatore), fu ministro del Lavoro e della Previdenza sociale nei governi De Gasperi (maggio 1947 – genn. 1950), poi ministro dell’Agricoltura (luglio 1951 – luglio 1953) e quindi ministro dell’Interno (luglio 1953 – genn. 1954) nei governi De Gasperi e Pella. Infruttuoso un suo tentativo di formare il governo (genn. – febbr. 1954), nel luglio dello stesso anno fu eletto segretario del partito; dopo le elezioni, nel luglio 1958 formò un governo bicolore DC-PSDI e nel febbr. 1959, in seguito alla scissione verificatasi in seno alla corrente di Iniziativa democratica della quale era leader, si dimise da entrambe le cariche. Il terzo governo F. (luglio 1960 – febbr. 1962) e, soprattutto, il quarto (febbr. 1962 – giugno 1963) aprirono la strada alla formazione dei governi di centro-sinistra. Senza successo una sua candidatura alla presidenza della Repubblica nel 1964, fu ministro degli Esteri (marzo – dic. 1965; febbr. 1966 – giugno 1968), e presidente della 20a sezione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite (ott. 1965 – sett. 1966). Eletto presidente del Senato dopo le elezioni del maggio 1968, fu confermato per le quattro legislature successive, alternando questa ad altre cariche politiche e governative. Senatore a vita dal marzo 1972, nel giugno 1973 fu rieletto segretario della DC, che guidò nello scontro referendario per l’abrogazione della legge sul divorzio (maggio 1974) e nella competizione per le elezioni amministrative del giugno 1975. Presidente del partito (apr. – ott. 1976), nel dic. 1982 assunse la presidenza del Consiglio di un governo quadripartito (DC, PSI, PSDI, PLI) rimasto in carica fino al giugno 1983. Dall’apr. al luglio 1987 presiedette il suo sesto governo; fu poi ministro dell’Interno nel governo Goria (luglio 1987 – apr. 1988) e del Bilancio nel successivo governo De Mita (apr. 1988 – luglio 1989). Nel 1994 aderì al Partito popolare italiano (PPI).(fonte)
[4] Alcide De Gàsperi. Statista (Pieve Tesino, Trento, 1881 – Sella di Valsugana 1954). Studente in lettere a Vienna, partecipò nel 1904 alle dimostrazioni universitarie di Innsbruck per l’istituzione d’una facoltà giuridica italiana, subendo per ciò un arresto di 22 giorni. Laureatosi, militò nel 1905 nell’Unione politica popolare; direttore del giornale Il Trentino (1906), difese l’italianità culturale e gli interessi economici della sua regione. Deputato del collegio di Fiemme nel 1911, prese posizione per una sempre più completa autonomia trentina, finché il 25 ott. 1918, insieme con gli altri deputati italiani al parlamento di Vienna, proclamò la volontà delle popolazioni trentine di essere annesse all’Italia. Dopo l’annessione egli, tra i membri più in vista del Partito popolare italiano, fu deputato alla Camera (1921). Ostile al fascismo, dopo la marcia su Roma sostituì L. Sturzo, andato in volontario esilio, alla direzione del partito e fu membro attivo del Comitato dell’Aventino; fu condannato a 4 anni di carcere per antifascismo. In seguito fu impiegato nella Biblioteca Vaticana. Riorganizzò durante la Resistenza il Partito popolare con il nome di Democrazia cristiana; dopo la liberazione di Roma, fece parte del ministero Bonomi come ministro senza portafogli. Ministro degli Esteri nel secondo gabinetto Bonomi e in quello Parri (dic. 1944 – dic. 1945), fu poi ininterrottamente presidente del Consiglio fino all’ag. del 1953, governando dapprima insieme coi socialisti e coi comunisti e, dopo il 31 maggio 1947, con la partecipazione soltanto dei partiti di centro. Tentò poi, nel breve ministero del 16 luglio 1953, un governo di soli democristiani. Presidente della CECA dal maggio 1954, resse anche, dal sett. 1953 al luglio 1954, la segreteria del suo partito. Di particolare significato rimane l’opera svolta da De G. per la ricostruzione del paese dalle rovine della guerra. La sua politica estera fu inoltre risolutamente tesa all’inserimento dell’Italia nell’ambito dell’Alleanza atlantica e alla realizzazione dell’Europa unita.(fonte)
[5] Giuseppe Pella. Uomo politico, nato il 18 aprile 1902 a Valdengo (Vercelli). Esperto di problemi economici e finanziarî, consulente di varî complessi aziendali, ha partecipato a numerose conferenze economiche internazionali (OECE, GATT, ecc.). Deputato all’Assemblea costituente, eletto deputato nella I legislatura repubblicana, e nelle successive, per la Democrazia Cristiana, fu sottosegretario alle Finanze nel secondo e terzo gabinetto De Gasperi. Ministro delle Finanze nel IV gabinetto De Gasperi (maggio 1947-maggio 1948), del Tesoro nel V (maggio 1948-giugno 1950) e nel VI gabinetto De Gasperi (gennaio 1950-luglio 1951), del Bilancio nel VII gabinetto De Gasperi (luglio 1951-luglio 1953) e del Bilancio e del Tesoro nell’VIII gabinetto De Gasperi (luglio 1953-agosto 1953), fu promotore di una politica finanziaria fondata sulla difesa della lira. Avendo ricevuto il 15 agosto 1953 dal presidente Einaudi un mandato per un “governo d’affari” limitato nel tempo e nel programma, ottenne la fiducia dalle Camere presentando un governo prevalentemente tecnico. L’atteggiamento assunto in occasione dell’aperta richiesta d’annessione della zona B da parte della Iugoslavia, ottenne al governo P. cordiali consensi delle destre; ciò venne presto a suscitare riserve e diffidenze da parte della sinistra della Democrazia Cristiana. Il 4 gennaio 1954 P. rassegnò le dimissioni. Dal novembre 1954 al novembre 1956 è stato presidente dell’Assemblea della CECA. Nel gabinetto Zoli (maggio 1957-giugno 1958) P. ritornò a responsabilità di governo come vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri. Nuovamente ministro degli Esteri nel II gabinetto Segni (febbraio 1959-marzo 1960), è ritornato a reggere il ministero del Bilancio nel III gabinetto Fanfani (luglio 1960).(fonte)
[6] Democrazia cristiana. Espressione utilizzata per designare un insieme di movimenti di natura prevalentemente sociale, sorti nell’ultimo scorcio del 19° sec., in parte avallati e incoraggiati dalla istituzione ecclesiastica e dal papato. Ufficialmente fu riconosciuta con le teorie enunciate da G. Toniolo e nell’enciclica Graves de communi di Leone XIII (1901).
GENESI E PRIMI SVILUPPI IN EUROPA
La tematica sollevata dal concetto di d. era stata al centro di ampie discussioni già nell’Ottocento. Varie forme di cattolicesimo sociale si erano sviluppate nei paesi europei dove il capitalismo aveva posto le sue basi e il socialismo compiva i primi passi fra le masse operaie collegandosi con la soluzione della ‘questione operaia’. Fra gli esponenti più significativi di questa tendenza furono il vescovo di Magonza, W.E. von Ketteler e, in Gran Bretagna, il cardinale H.E. Manning, mentre in Francia il cattolicesimo sociale ebbe la sua massima espressione nell’Oeuvre des cercles catholiques d’ouvriers, fondata da A. De Mun, R. La Tour du Pin e L. Harmel.
Nel periodo precedente allo scoppio della Prima guerra mondiale il movimento democratico cristiano si sviluppò in vari paesi europei: oltre ai democratici cristiani belgi e ai Vereinigte Christen in Austria, in Francia M. Sangnier fondò il movimento del Sillon che raccolse adesioni anche da parte del clero e dell’episcopato francese e apprezzamenti da Roma. Tuttavia, successivamente, Pio X lo condannò, prescrivendone il frazionamento in gruppi diocesani col nome di Sillons catholiques. Solo nel 1912 Sangnier dette vita alla Ligue de la jeune république, che, sul piano politico, tentò di opporsi all’altra organizzazione cattolica di tipo monarchico-nazionalista, l’Action française.
In Italia, dopo la nascita della Società della gioventù cattolica italiana a opera di G. Acquaderni e M. Fani, nel 1874 fu fondata l’Opera dei congressi e comitati cattolici, che per 30 anni fu l’organizzazione del cattolicesimo di opposizione allo Stato liberale. Sulla base dottrinale dell’enciclica di Leone XIII Rerum Novarum (1891) intorno alla condizione operaia, si formarono i primi fasci o circoli democratici cristiani europei; tra i primi tentativi di delineare un piano di riforme concrete per l’Italia, nello spirito dell’enciclica leonina, fu il Programma dei cattolici di fronte al socialismo enunciato nel 1894 a Milano nel II Congresso dell’Unione cattolica per gli studi sociali: la ‘preparazione nell’astensione’ segnò un primo passo verso la partecipazione dei cattolici alle elezioni. La formulazione de Il concetto cristiano di democrazia di G. Toniolo fu il punto di partenza di tutto il movimento della d. italiana, le cui forze più vive si riunirono intorno alla rivista Cultura sociale, diretta da R. Murri. Nel 1900 fu pubblicato il programma di un nuovo giornale democratico cristiano, Il domani d’Italia, che annunciò la costituzione di un partito democratico cristiano; ma con l’enciclica Graves de communi (1901) il pontefice affermò che non era «lecito di dare un senso politico alla democrazia cristiana», pur esprimendo il proprio consenso alle istanze sociali dei giovani. Gli esiti del XVIII Congresso cattolico (1901), in cui la presidenza dell’Opera dei congressi non ratificò l’accordo fra la corrente sociale dei giovani e gli intransigenti, indebolì la posizione di Murri all’interno del movimento, trovando più ampi consensi l’azione moderata di F. Meda. Seguirono lunghe polemiche, finché nel 1904 il segretario di Stato R. Merry del Val annunciò la soppressione dell’Opera dei congressi (a eccezione della seconda sezione presieduta da S. Medolago). Lo scioglimento dell’Opera colpì le aspirazioni dei giovani democratici cristiani, ma inferse anche un duro colpo agli intransigenti, mentre Pio X, sul problema della partecipazione cattolica alla vita politica, seguì una linea più elastica rispetto al suo predecessore: il non expedit fu osservato sempre con minor rigidezza fino a giungere alle elezioni del 1913 allorché, mediante il Patto Gentiloni, si raggiunse il culmine della politica ‘clerico-moderata’ seguita nel decennio giolittiano.
In reazione, alcuni giovani democratici cristiani, tra cui Murri, proseguirono la loro azione nella Lega democratica nazionale (1905), la cui opera fu rivolta alla presenza dei cattolici nel mondo proletario e alla rivendicazione del principio di autonomia politica del cattolico nei confronti dell’autorità religiosa. Pio X, con l’enciclica Pieni l’animo, condannò la Lega e proibì ai sacerdoti di aderirvi (1906). La sospensione a divinis di Murri (1907) e la scomunica (1909), dopo la sua elezione a deputato, ebbero gravi contraccolpi nella Lega e il congresso di Imola (1910) ne segnò la fine. Un anno più tardi a Firenze nacque la Lega democratica cristiana italiana (Cacciaguerra, Donati), ma alla fine della guerra questa corrente dissidente confluì nel filone più importante del movimento politico dei cattolici italiani, il Partito popolare, la cui attività fu poi bloccata dal regime fascista.
IL PARTITO DELLA DC IN ITALIA
La ricostruzione del partito cattolico avvenne tra il 1942 e il 1943, attorno a ex dirigenti del Partito popolare (A. De Gasperi, G. Spataro, M. Scelba, P. Campilli ecc.) e a giovani cattolici (G. La Pira, G. Dossetti, A. Moro, A. Fanfani, G. Andreotti ecc.). La DC – che aderì al CLN e partecipò alla lotta di liberazione antifascista – propugnava nel suo programma la democrazia parlamentare e l’autonomia politica e amministrativa degli enti locali, mentre difendeva i valori e il ruolo della famiglia e rivendicava la libertà dell’insegnamento privato; sul piano sociale si impegnava a limitare l’accentramento della ricchezza capitalistica e a sostenere la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese. Partecipò ai governi Badoglio, Bonomi e Parri, finché nel dicembre 1945 fu varato il primo gabinetto De Gasperi. La DC, partito interclassista e popolare, la cui matrice cattolica si accompagnava a una visione della politica sostanzialmente laica, si configurò subito come forza di governo e di centro, costruendo la propria base soprattutto tra le masse contadine, i ceti medi e la borghesia imprenditoriale, mentre sul terreno ideologico si pose come forza avversa a ritorni reazionari e alla minaccia totalitaria del comunismo. Tendenzialmente repubblicana (I Congresso, 1946), la DC ottenne la maggioranza relativa all’Assemblea costituente; problemi interni, riguardanti le scelte della ricostruzione, e internazionali (l’inizio di una fase di tensione fra USA e URSS) spinsero De Gasperi a liquidare (1947) la formula di governo che aveva guidato i primi passi del dopoguerra, fondata sull’alleanza con socialisti e comunisti, e a inaugurare l’epoca del centrismo (1947-60). Questa scelta sortì il successo delle elezioni del 1948 che videro assegnata alla DC la maggioranza assoluta dei seggi.
Sul finire degli anni 1940, attorno alla rivista Cronache sociali di G. Dossetti si formò una corrente critica della politica degasperiana, confluita poi (dopo il ritiro di Dossetti nel 1951) nella corrente di Iniziativa democratica guidata da A. Fanfani, P.E. Taviani e M. Rumor. La seconda legislatura (1953-58) fu caratterizzata dalla prevalenza di Iniziativa democratica, sulle cui posizioni convergeva la corrente di Base (G. Galloni, G. Marcora), e sanzionata dal V Congresso (1954) che elesse Fanfani segretario. Nel 1958 Fanfani formò un governo DC-PSDI che suscitò la spaccatura della sua corrente e opposizioni interne tali che egli fu costretto a dimettersi dalla presidenza del Consiglio e anche dalla segreteria del partito. I nuovi equilibri interni (era nata la corrente dorotea, sostenitrice del partito come asse politico centrale e riequilibratore dei rapporti politici e sociali, facente capo a Rumor, A. Segni, F. Piccoli ecc.) portarono alla segreteria di A. Moro (1959), anch’egli convinto dell’esaurimento della politica centrista ma meno propenso di Fanfani a forzare i tempi. Il varo del centrosinistra era stato preparato nell’VIII Congresso (1962), e, nel 1963 Moro formò il primo governo organico di centrosinistra. Le elezioni del 1968 segnarono uno scacco per il centrosinistra. L’instabilità politica (6 governi nel 1968-72) era accentuata da quei fenomeni – dal movimento degli studenti all’‘autunno caldo’ – che, segnalando un profondo bisogno di rinnovamento nella società civile e politica, contribuirono a minare il quadro politico; nuovi fermenti segnavano la fine del collateralismo politico-religioso, per cui alla DC era tradizionalmente riconosciuta la rappresentanza del mondo cattolico. La strategia della DC in questi anni non fu univoca: se l’XI Congresso (1969) affiancò al segretario Piccoli il presidente B. Zaccagnini, espressione delle aspirazioni di rinnovamento, alle presidenziali del 1971 i parlamentari della DC preferirono, al candidato ufficiale Fanfani, G. Leone, eletto con l’appoggio della destra, per giungere infine alla liquidazione del centrosinistra e alla riedizione del centrismo (1972-73). Al XII Congresso (1973), un accordo tra le correnti sancì la riedizione del centrosinistra e la segreteria Fanfani, che utilizzò la ricostituita unità interna nella perdente campagna referendaria per l’abrogazione della legge sul divorzio (1974). Con la segreteria Zaccagnini (1975) riprese vigore la linea di Moro, descritta come ‘strategia dell’attenzione’ verso il PCI, che uscì confermata dal XIII Congresso (1976). Nelle elezioni politiche anticipate del 1976 il 34,4% di preferenze avuto dal PCI (la DC ottenne il 38,8%) imponeva un’accelerazione del confronto fra i due maggiori partiti italiani. La soluzione concordata furono i 2 governi monocolore Andreotti (luglio 1976-marzo 1979) detti di ‘solidarietà nazionale’: il primo con l’astensione di PCI, PSI, PSDI, PRI, PLI, e il secondo – inaugurato il giorno del rapimento di Moro da parte delle Brigate rosse, 16 marzo 1978 – con il voto favorevole di PCI, PSI, PSDI, PRI e Democrazia nazionale. Con la crisi del secondo governo di solidarietà nazionale si chiuse il periodo dell’attenzione verso il PCI. In via di esaurimento il terrorismo, dopo la pubblicazione di documenti sulla loggia massonica P2 (1981) fu sollevata dall’opposizione, specie comunista, la ‘questione morale’, cioè la critica di gravi distorsioni dei meccanismi del potere interpretate come conseguenza del mancato ricambio della classe di governo.
La DC cedette nel giugno 1981 la presidenza del Consiglio con i governi Spadolini, e il congresso del 1982 elesse segretario C. De Mita, esponente della sinistra, col mandato di ‘moralizzare’ alcuni settori del partito e renderlo più permeabile alle trasformazioni della società. Nelle elezioni anticipate del 1983 la DC arretrò vistosamente (32,9%), ed emerse come contestatore dell’egemonia democristiana il PSI, cui la DC lasciò la guida del governo (gabinetti Craxi, 1983-87). De Mita fu confermato alla segreteria nel 1984 e nel 1986 e dal 1988 fu anche presidente del Consiglio, ma al congresso del 1989 una maggioranza a lui sfavorevole (e meno ostile verso il PSI) guidata da G. Andreotti, A. Gava e A. Forlani, elesse quest’ultimo alla segreteria. Nel 1991, con il passaggio all’opposizione del PRI, emersero nuovi fermenti anche nel mondo politico tradizionalmente legato alla DC. Le elezioni politiche anticipate del 1992 videro la DC scendere ancora al 29,7%.
Alla fine degli anni Ottanta del 20° sec. conobbe una crisi politica che si saldò a quella generale della cd. prima repubblica. Fu quindi travolta da tangentopoli e infine (1994) si frantumò in una serie di formazioni minori (PPI, CCD, UDC, Democrazia cristiana ecc.).
I PARTITI DEMOCRISTIANI IN EUROPA E AMERICA LATINA
Forze di ispirazione democratico cristiana si diffusero dopo la Seconda guerra mondiale in vari paesi dell’Europa occidentale: nella Repubblica Federale di Germania si affermarono la Christlich-demokratische Union e la Christlich-soziale Union (Baviera); in Austria l’Österreichische Volkspartei; in Belgio il Christelijke volkepartij (fiammingo) e il Parti social chrétien (vallone); nei Paesi Bassi il Christen democratisch appel (costituito nel 1980 come federazione di più movimenti); in Francia il Centre des démocrates sociaux (1976); in Irlanda il Fine Gael ecc. All’Unione europea democratica cristiana (costituita nel 1965) aderiscono altresì partiti di più recente formazione quali il portoghese Partido do centro democrático social (fondato nel 1974), la spagnola Democracia cristiana (1982; a carattere regionale sono il Partito nacionalista vasco e l’Unió democrática de Catalunya), la greca Nèa Dimokratìa (1974). I partiti democratici cristiani dei paesi aderenti alla UE hanno costituito (1979) il gruppo denominato Partito popolare europeo. I partiti democratici cristiani fanno capo all’Internazionale democratica cristiana (1982), con sede a Bruxelles, cui fanno riferimento anche le formazioni politiche sviluppatesi dopo la fine dei regimi comunisti nell’Europa orientale (1989).
In America Latina si sono formati partiti democratici cristiani per l’esigenza di fronteggiare da un lato le dittature militari, dall’altro i movimenti di ispirazione rivoluzionaria e castrista. Oltre al Partido social cristiano del Venezuela (1946), nel continente hanno svolto un ruolo rilevante i partiti democratici cristiani del Cile (1957), del Salvador (1960), del Guatemala (1968).(fonte)
[7] Ezio Vanoni. Economista e politico, contribuisce a costruire il modello di economia sociale di mercato che si afferma in Italia negli anni della Repubblica. Nella vita di Vanoni, vista retrospettivamente, si scorgono tre nitide fasi: la fase della ricerca scientifica (1927-42), durante la quale esamina il rapporto tra Stato e mercato; la stagione della mediazione culturale (1943-47), in cui partecipa, insieme ai conterranei Sergio Paronetto e Pasquale Saraceno, alla stesura del Codice di Camaldoli che prepara i cattolici all’elaborazione della più impegnativa Carta costituzionale e, infine, il decennio dell’azione governativa (1946-56), in cui si dispiega il tentativo di attuare un programma di politica economica conforme ai principi del cattolicesimo sociale.
LA VITA
Ezio Vanoni nasce a Morbegno, in Valtellina, il 3 agosto 1903. Il padre Teobaldo è segretario comunale e geometra. La madre Luigia Samaden, diplomata maestra, aiuta il marito nella libera professione. Primo di quattro figli, riceve un’educazione classica connotata dall’influente religiosità della madre. Grazie a una borsa di studio, frequenta l’ambito Ginnasio Piazzi di Sondrio.
Nel 1921 si iscrive, ancora con una borsa di studio, alla facoltà di Giurisprudenza del prestigioso Collegio Ghislieri di Pavia. Qui diventa uno degli allievi prediletti di Benvenuto Griziotti, fondatore di una ‘scuola’ di scienza delle finanze e studioso di ideali socialisti. Negli anni universitari attraversa una crisi religiosa e aderisce al socialismo democratico. Dopo il delitto Matteotti, diventa il capo degli studenti socialisti, procurandosi la fama di sovversivo e una scheda segnaletica presso gli archivi della polizia di Stato che lo accompagnerà per tutti gli anni del fascismo.
Il 25 luglio 1925 si laurea in giurisprudenza, con il massimo dei voti e la lode, discutendo con Griziotti una tesi su natura e interpretazione delle leggi tributarie. Inizia una tormentata carriera universitaria. Nel 1927, dopo due anni di servizio militare, vince la borsa di studio Lorenzo Ellero dell’Università Cattolica di Milano. Nel 1928, prima ancora che fosse scaduta la Ellero, vince la borsa Rockefeller per un soggiorno di studio in Germania. Nel 1930, tornato dalla Germania, ottiene l’incarico triennale di scienza delle finanze e diritto finanziario presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Cagliari, e nel 1931 apre a Milano uno studio di avvocato civilista.
Il 1932 è un anno denso di avvenimenti: si sposa, a Morbegno, con Felicita dell’Oro, consegue la libera docenza, pubblica la monografia Natura e interpretazione delle leggi tributarie, e perde il concorso a cattedra presso l’Università di Messina. Vanoni ha un passato socialista e non ha la tessera del Partito fascista. Nel 1933 nasce la prima figlia, Marina, e ottiene l’incarico alla Sapienza di Roma. Nel 1934 nasce la seconda figlia, Lucia, e nel 1935 perde ancora un concorso a cattedra presso l’Università di Camerino.
Il 1937 è un anno importante. Vanoni ottiene l’incarico all’Università di Padova. In soli tre anni dà alle stampe tre volumi e una serie di saggi di finanza pubblica. Collabora con il ministro delle Finanze, Paolo Thaon di Revel, e prende la tessera del partito. Nel 1939 vince (finalmente) il concorso a cattedra presso la facoltà di Economia dell’Università di Venezia.
Negli anni di guerra è membro di un’autorevole commissione incaricata di preparare la riforma del sistema tributario italiano.
Il 1943 è un anno di svolta. Vanoni si trasferisce a Roma con la famiglia. Partecipa alla resistenza nei quadri direttivi della Democrazia cristiana e contribuisce alla stesura del Codice di Camaldoli e di altri programmi sociali dei cattolici italiani. Nel giugno del 1946 è eletto all’Assemblea costituente ed entra a far parte della Commissione dei 75. Nel febbraio del 1947 è nominato ministro del Commercio estero nel terzo governo De Gasperi.
Inizia il decennio dell’azione governativa: Vanoni è ininterrottamente ministro delle Finanze per cinque anni, dal 1948 al 1953, e ministro del Bilancio dal 1953 al 1956 (dal 26 luglio 1951 al 2 febbraio 1952 è anche ministro del Tesoro ad interim). Nel corso di questo decennio concorre ad assumere una serie di rilevanti scelte politiche: la liberalizzazione degli scambi internazionali, la riforma tributaria, la fondazione dell’ENI, l’elaborazione di uno Schema decennale di sviluppo dell’economia italiana.
Vanoni muore in Senato il 16 febbraio 1956 (cfr. Ferrari Aggradi 1956; Vigna 1992; Forte 2009, pp. 161-216).
L’ECONOMISTA PUBBLICO
Nei primi anni Venti, quando Vanoni frequenta l’università, l’Italia è il Paese leader nella scienza delle finanze. Gli studiosi italiani sono divisi in due principali e rivali scuole di pensiero: ‘economica’ e ‘sociologica’. La disputa nasce intorno alla natura dell’attività finanziaria dello Stato moderno.
La scuola economica si richiama all’autorità di Maffeo Pantaleoni e annovera tra le proprie fila studiosi del calibro di Luigi Einaudi e Antonio De Viti de Marco. Per gli economisti-finanziari, lo Stato ha il compito di soddisfare in modo razionale i bisogni collettivi e lo fa quando rispetta la scala delle preferenze individuali: con il prelievo fiscale, sottrae ricchezza ai privati e, con la spesa pubblica, offre in cambio servizi. Opera in modo razionale, e cioè economico, se il sacrificio che impone non oltrepassa il beneficio che procura. L’imposta è, cioè, il prezzo di uno scambio volontario tra il cittadino e lo Stato.
Dunque, per la scuola economica, le decisioni collettive sono razionali se si basano sulle preferenze individuali e se recepiscono il principio dell’equimarginalità tra sacrificio e beneficio della spesa pubblica.
La rivale scuola sociologica si richiama all’autorità di Vilfredo Pareto e di Gaetano Mosca e anch’essa annovera tra le proprie fila illustri economisti come Gino Borgatta e Amilcare Puviani. Per gli economisti-sociologi lo Stato è, di fatto, una casta che mira a perpetuare il proprio potere. Il fine apparente dell’attività finanziaria è il soddisfacimento di bisogni collettivi. Il fine reale è la conquista e la conservazione del potere delle classi dominanti. Per la scuola sociologica, i cittadini dovrebbero concorrere alle spese dello Stato in base alla loro capacità contributiva dedotta da fattori reali come reddito e patrimonio.
Vanoni aderisce a una terza scuola, quella di Griziotti, che alcuni chiamano ‘politica’. Il pensiero finanziario di Vanoni è racchiuso nella monografia del 1932 e in due volumi di Scienza delle finanze e diritto finanziario pubblicati nel 1937.
Per Vanoni lo Stato è un ente pubblico, dotato di personalità giuridica, delegato ad appagare bisogni collettivi che solo in parte possono essere dedotti dalle preferenze individuali. Vanoni è parzialmente critico verso entrambe le scuole italiane. Lo Stato non può essere considerato alla stregua di una casta che persegue il proprio egoistico interesse. La storia mostra che non è così. Vi sono state classi dirigenti illuminate che hanno saputo perseguire il bene dell’intera collettività, ma non sempre i bisogni collettivi possono essere ordinati sulla base delle preferenze individuali. Gli individui potrebbero non avvertire l’importanza di una maggiore giustizia sociale o di una pace più sicura, che le classi dirigenti devono ugualmente perseguire. Lo Stato ricerca il bene dell’intera collettività. Vanoni, negli anni Trenta, lo chiama bene della nazione e più tardi bene comune. Il bene comune non è la sommatoria dei beni o delle preferenze individuali: è un ordine sociale che promuove e tutela i diritti fondamentali della persona singola e associata.
L’attività finanziaria, per Vanoni, non può essere regolata né secondo un principio di pura supremazia statuale né in forza di un paritetico scambio di equivalenti. Nel primo caso, lo Stato perderebbe autorità e legittimità. Nel secondo, sarebbe impossibile commisurare il beneficio di servizi pubblici indivisibili con il sacrificio imposto a singoli contribuenti.
Vanoni elabora quello che si potrebbe definire un principio di reciprocità intra- e intergenerazionale.
Utilizza lo schema di classificazione delle entrate pubbliche elaborato da Griziotti. Vi sono entrate che provengono da generazioni passate (i proventi del patrimonio pubblico), da generazioni presenti (i tributi) e da generazioni future (indebitamento pubblico).
Il 10 giugno 1940 Benito Mussolini annuncia che la dichiarazione di guerra è stata già consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e Francia. L’Italia si prepara a una guerra che spera breve. Si pensa anche a una riforma del sistema tributario. Il ministro delle Finanze Thaon di Revel affida a un comitato tecnico, composto dai maggiori esperti di finanza pubblica, il compito di dibattere il tema e di predisporre un progetto di riforma. Del comitato fa parte anche Vanoni.
All’inizio degli anni Quaranta, e quindi dopo vent’anni di regime fascista, il sistema tributario italiano si caratterizzava per una netta prevalenza delle imposte reali rispetto a quelle personali, al punto che l’imposizione personale veniva considerata ‘complementare’ rispetto a quella reale.
Nel comitato tecnico voluto dal ministro Thaon di Revel, Vanoni presentò un progetto di riforma che prefigurava il passaggio a un sistema tributario prevalentemente personale, con tassazione dei redditi da capitale, riduzioni per carichi di famiglia e aliquote progressive. Il progetto suscitò interesse e apprezzamenti ma non fu accolto. Prevalse la tesi, sostenuta da Cesare Cosciani, secondo cui l’imposta personale doveva restare complementare all’imposizione reale (cfr. Magliulo 1991, pp. 33-41).
IL RIFORMATORE SOCIALE
Il 25 luglio 1943 implode il regime fascista e inizia la tragica ed esaltante stagione della liberazione dalla dittatura. Due giorni prima, a Camaldoli, una cinquantina di studiosi cattolici, al termine di una settimana di lavori, aveva approvato settantasei ‘enunciati’ di un nuovo codice sociale.
Nella clandestinità, i cattolici preparano la nuova democrazia. A Roma si ritrovano tre giovani di Morbegno: Vanoni, Saraceno e Paronetto. Hanno il compito di sviluppare gli enunciati di Camaldoli che trattano le questioni economiche. Dal settembre 1943 al maggio 1944 si incontrano più volte e insieme preparano le bozze degli articoli economici. Poi, Saraceno e Vanoni si recano a casa di Giuseppe Capograssi, insigne giurista, per discutere gli aspetti più controversi del rapporto tra Stato e società.
Il Codice viene pubblicato nel 1945 con il titolo Per la comunità cristiana. Principi dell’ordinamento sociale a cura di un gruppo di studiosi amici di Camaldoli. Si tratta di un lavoro comune, in cui è difficile distinguere l’apporto dei singoli autori. La mano di Vanoni è evidente soprattutto nella stesura del capitolo VI su L’attività economica pubblica.
Negli stessi mesi, e sotto le stesse bombe che colpiscono Roma, uomini della tradizione liberale e marxista preparano i loro programmi di riforma sociale. In tutte le forze politiche emerge il desiderio di costruire uno Stato nuovo che riconosca, accanto agli antichi diritti civili e politici, i moderni diritti sociali, a partire dal lavoro. La sfida più impegnativa riguarda i mezzi: come garantire i diritti riconosciuti?
Liberali e social-comunisti, da opposti versanti, pensano a interventi pubblici esterni al mercato. Lo Stato dovrebbe nazionalizzare i monopoli naturali e attuare politiche redistributive. Ovviamente, i liberali auspicano uno Stato minimo e le sinistre uno Stato massimo. Ma il criterio direttivo è simile. Lo Stato non deve mai interferire sul funzionamento interno del mercato. Einaudi si richiama alla teoria degli interventi conformi elaborata da Wilhelm Röpke e auspica una legislazione sociale a favore di poveri e meritevoli.
I cattolici pensano invece a interventi pubblici interni al mercato. L’obiettivo è proprio quello di interferire sul funzionamento del mercato per modificare, mentre si svolge, il processo produttivo. I cattolici avevano tradizionalmente indicato due principali istituti: la partecipazione degli operai agli utili dell’impresa capitalistica e l’impresa cooperativa. Entrambi avrebbero consentito di modificare, dall’interno, il processo produttivo. Il Codice di Camaldoli ribadisce l’importanza della cooperazione ma sembra ridimensionare il ruolo dell’azionariato operaio, soprattutto nella grande industria, dove è essenziale la funzione direttiva dell’imprenditore.
Nel 1947 Vanoni pubblica un saggio intitolato La nostra via in cui riassume e sistematizza la riflessione svolta negli anni della liberazione. Il compito del governo è orientare l’economia verso fini di giustizia sociale (o bene comune) e cioè, concretamente, garantire uno sviluppo equilibrato del Paese che contempli la massima occupazione e la migliore distribuzione delle risorse. Gli interventi auspicati sono ancora interni al mercato, volti a modificare l’allocazione delle risorse. Tra gli strumenti nuovi figura l’impresa a partecipazione statale. Vanoni spiega che l’impresa pubblica a partecipazione statale, l’IRI (Istituto per la Ricostruzione Industriale), operando nel mercato, in diretta concorrenza con le imprese private, può conseguire il duplice risultato di ridurre gli extraprofitti dei privati e di preservare l’efficienza delle aziende pubbliche portando investimenti e sviluppo in settori e aree geografiche che ne sarebbero altrimenti esclusi (Barucci, in E. Vanoni, La politica economica degli anni degasperiani. Scritti e discorsi politici ed economici, 1977, pp. XIX-XXVI; Vigna 1992, pp. 62-91).
Nel giugno 1946 Vanoni è eletto all’Assemblea costituente e siede nella Commissione dei 75. Tra i suoi contributi alla stesura della carta repubblicana vi è la formulazione all’art. 81 della Costituzione che impone di indicare la copertura finanziaria per ogni legge che comporti nuove o maggiori spese (cfr. Tramontana 1987). Per Vanoni, si tratta di una norma di giustizia intergenerazionale.
L’UOMO DI GOVERNO
Il 23 maggio 1948 De Gasperi forma il suo quinto governo: inizia la stagione del centrismo degasperiano. Vanoni è nominato ministro delle Finanze: un incarico che manterrà per l’intera legislatura.
Nel 1950 il Parlamento italiano approva, su proposta di Vanoni, una riforma doganale che abbatte le barriere non tariffarie (quote e contingenti) riservando al governo il potere di alzare (entro limiti definiti) i dazi a protezione di industrie considerate strategiche. Il provvedimento proietta l’economia italiana nel vasto ed emergente mercato mondiale.
Nel 1951 è la volta di una riforma fiscale che rafforza l’imposizione diretta e personale reintroducendo l’obbligo della dichiarazione annuale dei redditi. Il provvedimento rappresenta, fino alla riforma del 1971, la più importante misura di giustizia fiscale.
Nel 1953 il Parlamento approva, ancora su proposta di Vanoni, la legge che istituisce l’Ente nazionale idrocarburi (ENI), riservando allo Stato il monopolio per la produzione e distribuzione di metano nella Valle Padana e lasciando ai privati la libertà di ricercare e sfruttare nuovi giacimenti nella restante parte del territorio nazionale. L’ENI svolgerà un ruolo fondamentale nella politica di approvvigionamento energetico e di sviluppo equilibrato del Paese.
Nel successivo primo governo Fanfani, il 18 gennaio 1954 Vanoni è nominato ministro del Bilancio, assumendo anche formalmente il ruolo di coordinatore della politica economica italiana. L’azione di Vanoni, come ministro del Bilancio, ruota intorno allo Schema decennale di sviluppo che porta il suo nome.
Il 29 dicembre 1954 il Consiglio dei ministri, presieduto da Mario Scelba, approva un documento di oltre cento pagine intitolato Schema di sviluppo dell’occupazione e del reddito in Italia nel decennio 1955-64. Dopo aver completato la ricostruzione del Paese, il governo intende risolvere, in un decennio, i due maggiori problemi strutturali dell’economia italiana: la disoccupazione e l’arretratezza del Sud.
Il modello macroeconomico sottostante allo Schema Vanoni può essere così riassunto:
• per raggiungere il duplice obiettivo di una crescita equilibrata e di piena occupazione (conseguendo anche l’equilibrio della bilancia dei pagamenti) è necessario creare 3,2 milioni di nuovi posti di lavoro localizzati soprattutto nel Mezzogiorno;
• per creare 3,2 milioni di nuovi posti di lavoro è necessario che il reddito nazionale continui a crescere, come negli ultimi anni, a un tasso medio annuo del 5%;
• per incrementare il reddito nazionale a un tasso medio annuo del 5% è necessario che il tasso di occupazione aumenti del 2% e la produttività del lavoro del 3%;
• per incrementare il tasso di occupazione e la produttività del lavoro è necessario che la quota degli investimenti rispetto al reddito nazionale aumenti dal 21% (del 1955) al 25% (nel 1964);
• infine, per incrementare la quota degli investimenti sul reddito nazionale è necessario che aumenti, nella stessa proporzione, la quota del risparmio sul reddito.
In sostanza: servono più risparmi per finanziare maggiori investimenti. Senza il risparmio necessario a finanziare i maggiori investimenti, vi sarebbe un rallentamento nella crescita economica e un prevedibile aumento della disoccupazione e del divario Nord-Sud.
Lo Schema delinea una strategia di politica economica. Il governo dovrebbe, innanzitutto, procurarsi mediante prestiti esteri il risparmio indispensabile per attivare il processo di sviluppo; dovrebbe poi, insieme con le imprese pubbliche, localizzare una parte degli investimenti nel Sud; dovrebbe infine, attraverso la politica dei redditi e la politica fiscale, favorire un graduale innalzamento della propensione al risparmio dal 21% al 25%. I consumi aumenterebbero in termini assoluti ma dovrebbero ridursi in rapporto al reddito.
Lo Schema suscitò un grande dibattito, in Parlamento e nel Paese. A Vanoni furono mosse tre principali critiche: aver impostato una manovra genericamente keynesiana inadatta per un Paese, come l’Italia, afflitto da disoccupazione strutturale; non aver contemplato un’azione antimonopolistica contro i grandi gruppi industriali che avrebbero beneficiato degli incrementi di spesa pubblica; avere, al contrario, previsto un’inaccettabile contrazione dei consumi privati.
Nel confronto parlamentare e nel dibattito pubblico Vanoni respinse, con efficacia, tutte le accuse. Gli investimenti pubblici avevano la funzione, non di colmare inesistenti vuoti di domanda aggregata, ma di accrescere la dotazione di capitale e quindi la capacità produttiva in specifici settori e aree geografiche. Le grandi imprese italiane erano state esposte, con i provvedimenti del 1950, alla più potente azione antimonopolistica immaginabile: la concorrenza internazionale. Infine, lo Schema prevedeva un aumento assoluto, e non una contrazione, dei consumi, riservando una quota crescente di un reddito crescente al finanziamento dei maggiori investimenti richiesti per ridurre la disoccupazione e il divario tra Nord e Sud (cfr. Magliulo 2007).
Lo Schema fu attuato solo parzialmente ma esercitò una grande influenza sulla cultura economica italiana; esso rappresenta la sintesi finale del pensiero economico e dell’azione politica di Vanoni: un insieme coordinato di interventi pubblici interni al mercato per orientare l’economia verso fini di giustizia sociale e benessere comune.(fonte)
[8] Antonio Segni. Giurista e uomo politico (Sassari 1891 – Roma 1972). Consigliere nazionale del Partito popolare, interruppe l’attività politica durante il fascismo. Tra gli organizzatori della DC in Sardegna dal 1943, nel 1946 fu eletto alla Costituente. Deputato (1948-62), fu più volte ministro e due volte presidente del Consiglio (1955-57; 1959-60). Eletto nel maggio 1962 presidente della Repubblica, fu costretto a dimettersi nel 1964 a causa delle sue condizioni di salute.
VITA E ATTIVITÀ
Laureatosi nel 1918, insegnò diritto processuale civile nelle univ. di Perugia (1920-25), di Cagliari (1925-30) e di Pavia (1931-32); prof. di diritto commerciale a Sassari dal 1933, nel 1954 conseguì la cattedra di diritto processuale civile presso l’univ. di Roma. Nelle file delle organizzazioni cattoliche sin da giovane, nel 1919 si iscrisse al Partito popolare e nel 1923 ne divenne consigliere nazionale, ritirandosi però dalla vita politica negli anni del regime fascista. Tra gli organizzatori della Democrazia cristiana in Sardegna dal 1943, membro della prima Consulta regionale sarda, nel 1946 fu eletto all’Assemblea costituente. Deputato (1948-62), dal 1946 al 1951 fu ministro dell’Agricoltura, e in tale veste elaborò un piano di riforma agraria di cui fu tradotto in legge un ampio stralcio. Dopo aver ricoperto la carica di ministro della Pubblica Istruzione (1951-54), S. fu alla guida di un governo formato da DC, PSDI e PLI (1955-57). Ministro della Difesa (1958-59), ancora presidente del Consiglio a capo di un monocolore democristiano (1959-60), fu poi ministro degli Esteri (1960-62). Eletto nel maggio 1962 presidente della Repubblica, fu colpito da un ictus cerebrale nel 1964 e dette le dimissioni nel dicembre dello stesso anno, dopo che già nell’agosto le funzioni di capo dello Stato erano state provvisoriamente assunte dal presidente del Senato C. Merzagora. Socio nazionale dei Lincei dal 1958, nel 1964 gli fu conferito il premio Carlo Magno per la sua attività in favore dell’unità europea.(fonte)
[9] Carlo Delcroix. Nacque a Firenze il 22 ag. 1886 da Giuseppe e da Ida Corbi.
I nonni paterni erano l’uno belga e l’altra lorenese. Il nonno Nicola, dopo aver partecipato ai moti del 1848 in Belgio e in Francia, si era trasferito in Italia, lavorando come appaltatore dapprima in Calabria, poi in Puglia, Basilicata, Sicilia, e stabilendosi infine a Firenze. La madre era di Castelluzzo, figlia di un artigiano.
Studiò a Livorno – dove si era trasferita in un primo tempo la famiglia -, quindi al collegio dei salesiani di Firenze, e infine al liceo “Michelangelo”. Nel 1914 si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza, e frequentò la scuola allievi ufficiali di Modena. Dopo aver partecipato alle manifestazioni interventiste, partì volontario alla fine del 1915 nel 3° reggimento bersaglieri. Nel grado di aspirante ufficiale partecipò alla conquista del Col di Lana (aprile 1916), e come sottotenente a quella del monte Sief (maggio); tra l’agosto e il settembre comandò una sezione di lanciatorpedini presso il forte La Corte; nel gennaio 1917 diresse i lavori di sgombero delle valanghe, e successivamente comandò una sezione pistole mitragliatrici a monte Mesola. Promosso tenente nel febbraio 1917, fu istruttore dei reparti di arditi per il lancio delle bombe a mano, e a Malga Ciapela, durante un periodo di esercitazioni, avvenne l’incidente che gli costò la perdita delle mani e della vista e per il quale gli fu conferita la medaglia d’argento al valor militare (fu decorato successivamente anche dell’Ordine civile dei Savoia, del gran cordone della Corona d’Italia, dell’Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro e della Legion d’onore francese).
La sera del 12 marzo 1917, “informato che un bersagliere, avventuratosi nel poligono di tiro era saltato in aria urtando in una bomba inesplosa, mentre gli stessi portaferiti esitavano ad arrischiarsi nella zona pericolosa, egli accorreva da solo nella speranza di salvare il bersagliere e, constatatane la morte, provvedeva, con i soldati e con gli ufficiali sopravvenuti, a trasportarne il cadavere. Poi dovendosi procedere allo sgombero del poligono dalle granate inesplose, il tenente C. Delcroix dispensò la squadra di servizio per non esporla al rischio grave e, fatti allontanare tutti i presenti, rimase solo a provvedere alla bisogna: una bomba, nascosta sotto la neve, esplodendo gli troncò le braccia spengendogli gli occhi per sempre”. Così lo stesso D. raccontò l’episodio (in La Nazione, 24 ag. 1921) quando fu accusato dal consiglio direttivo della sezione fiorentina dell’Associazione nazionale dei mutilati e invalidi di guerra (ANMIG) – a seguito di alcune polemiche sorte con il comitato centrale della medesima, del quale faceva parte il D. – di non essere un autentico mutilato di guerra. Nelle polemiche tra i mutilati fiorentini venne anche ventilata l’ipotesi – come scrive R. Cantagalli – che l’incidente fosse avvenuto durante una pesca in un borro a colpi di bomba. Il D. fu espulso dalla sezione fiorentina dell’associazione e la medaglia d’argento tramutata in bronzo, ma in seguito all’intervento del segretario generale dell’ANMIG, R. Romano, e del segretario amministrativo, A. Mammalella, che pose fine ai contrasti interni alla sezione, il consiglio direttivo che aveva lanciato le accuse venne espulso e il D. reintegrato e decorato nuovamente della medaglia d’argento. Uscito dopo un lungo periodo di cure dall’ospedale, il D. si dedicò attivamente alla propaganda bellica tra i soldati e i feriti, pronunciando numerosi discorsi in ospedali e scuole fiorentine: tornò – come egli stesso scrisse nella serie di articoli autobiografici, apparsi su Il Tempo nel 1946, intitolati Il dramma di una generazione – “con la parola all’azione”. Nel frattempo, all’ospedale “Villa Pisa” a San Domenico di Fiesole, aveva conosciuto Cesara Rosso, “colei che in me vive la passione dell’opera e mi presta le mani per compirla” – così la dedica di Sette santi senza candele (Firenze 1925) -, con la quale si sarebbe sposato nel gennaio 1921.
Alla fine della guerra si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza di Siena, avendo deciso di tornare agli studi poiché – scriveva – “mi era sembrato di non avere altro da dire”: ma “mi si cercava da ogni parte… non mi ritrassi”. Proseguì quindi nella sua attività di oratore e propagandista entrando nell’ANMIG della quale sarebbe divenuto presidente nel luglio 1924.
L’ANMIG era stata fondata a Milano il 29 apr. 1917, con lo scopo – come avvertiva lo statuto approvato al I congresso di Roma, nel marzo 1918 – di “mantenere fra gli invalidi della guerra il sentimento di fratellanza, ed in omaggio della patria il ricordo e la tradizione della guerra antitedesca”, di “venire in aiuto morale e materiale” ai propri membri, di “intervenire presso i pubblici poteri e le amministrazioni pubbliche a sostegno dei diritti e degli interessi dei propri aderenti”, di “adoperarsi per procacciare” loro lavoro, di “servire da intermediaria gratuita nelle relazioni fra principali e operai, fra impiegati e aziende”. Dopo una prima fase in cui l’associazione si impegnò soprattutto nella propaganda per la vittoria, tra il 1920 e il 1921 diede vita a numerose agitazioni in varie province per l’ottenimento delle pensioni di guerra.
Caratteristica dell’associazione, ribadita anche al II congresso di Palermo nell’aprile 1919 (dove veniva confermato il gruppo dirigente composto da D. Dall’Ara, G. Mira, E. Sanguineti, P. Brunazzi), fu la “apoliticità” e l’impossibilità di tramutarsi in partito; pur se il congresso si augurava, nella mozione finale, la costituzione di un “movimento politico purificatore, estraneo alle diverse vecchie divisioni e concezioni”. Già il 4 nov. 1918, d’altronde, l’ANMIG aveva lanciato un manifesto dove esprimeva l’esigenza di un rinnovamento della “vita politica della Nazione” e di un mutamento del “costume politico”, dato che “tutti i vecchi partiti sono morti” e lo “Stato quale lo concepivano i nostri padri è trapassato”.
Al III congresso di Firenze, nel giugno 1920, sorsero vivaci contrasti all’interno del gruppo dirigente: Dall’Ara e Mira furono accusati dal D., I. Simoni e G. Neri (che sarebbe divenuto presidente al posto di Dall’Ara) per la loro gestione e per aver tenuto rapporti troppo stretti con il governo. Pur se veniva ancora mantenuto il criterio dell’apoliticità (ribadito anche al IV congresso di Zara del maggio 1922), la nuova direzione, della quale faceva parte lo stesso D., assieme, tra gli altri, a R. Romano, A. Mammalella, T. Madia, operò uno spostamento a destra e mirò a tenere buoni rapporti con il fascismo.
Come membro dell’associazione il D. fu impegnato largamente nell’attività oratoria e propagandistica: tra il 1917 e il 1929 pronunciò complessivamente, in Italia e all’estero, 253 discorsi, i primi dei quali furono pubblicati nei volumi I dialoghi con la folla (Firenze 1922) e Il sacrificio della parola (ibid. 1924). Tra il marzo e il giugno 1921 fu impegnato in un giro di conferenze in Brasile, Bolivia, Argentina, Uruguay.
Questa attività, e il successo che gli procurava, attirò su di lui l’attenzione riguardosa dei fascisti: egli stesso riconobbe a posteriori, pur senza “ritrattare una delle parole allora pronunziate”, che “certamente le mie invettive contro i sobillatori del popolo, che richiamavo alla pietà per i vivi e per i morti, avranno giovato al fascismo”.
Da parte sua il D. riteneva che Mussolini fosse colui che “meglio di ogni altro” interpretava “la volontà” e rispondeva “al bisogno dei combattenti”: “Io ero – scriveva ne Il dramma di una generazione – fraquei giovani che si sentivano l’anima del giustiziere, che dopo aver vinto si proponevano di vendicare, presi da un impeto di ribellione, da un’ansia di rinnovamento, come se veramente un’altra vita dovesse cominciare dalla distruzione e dalla morte”. Come scrisse G. Volpe presentando il volume Quando c’era il re (Milano 1959), nel fascismo il D. vide “quasi un ringiovanimento della Nazione, un apporto ad essa di nuove energie e di qualche spunto dottrinario nuovo, oltre che volontà di avvaloramento della guerra vittoriosa” (p. 7).
Nell’ottobre 1919 partecipò, “da spettatore”, come scrisse, alla I adunata nazionale dei Fasci di combattimento a Firenze; pur sollecitato da Mussolini, non si recò, tuttavia, alla II adunata di Milano, adducendo motivi di salute, e rifiutò altri inviti di fascisti di partecipare a loro manifestazioni.
La sua posizione nei confronti del fascismo non era del tutto chiara. Nel 1922, infatti, fu coinvolto – chiamato da A. Rossini, come ha scritto il D. stesso – nel progetto della manifestazione che D’Annunzio avrebbe dovuto tenere assieme ai mutilati a Roma in occasione del 4 novembre. Per trattare l’iniziativa, si recò con R. Romano a Gardone, quando tuttavia D’Annunzio aveva già rinunciato a parteciparvi: “trovammo la porta del Vittoriale inesorabilmente chiusa e fu vano ogni tentativo di avvicinare il poeta. Avemmo la spiegazione l’indomani quando si apprese che l’insurrezione [la marcia su Roma] era cominciata”. Anzi – come egli scrisse ne Il dramma di una generazione – “alla notizia… Mussolini, interrompendo bruscamente il congresso dei fasci a Napoli, anticipò il colpo di Stato, previsto ma non deciso, allo scopo di precedere il poeta a Roma”. Sempre in questo periodo, inoltre, sembra che il D. – secondo quanto scrisse M. Soleri nelle sue Memorie (Torino 1949, p. 151) – si fosse recato, come altri mutilati e combattenti, al ministero della Guerra chiedendo “l’onore di comandare i reparti dell’esercito che avrebbero dovuto fronteggiare i fascisti il 27 ottobre”.
Se la sua posizione nei confronti del fascismo sembrava ancora incerta, l’ANMIG invece, il 31 ott. 1922 lanciò un manifesto nel quale, dichiarandosi “al servizio della Patria”, sosteneva che i fatti stavano attuando “quello che è sempre stato un pensiero forte e chiaro della nostra associazione”: l'”ora forte” che batteva per l’Italia essa l’aveva o presentita e preparata” con il progetto della manifestazione di D’Annunzio (snaturato da “subdole manovre di Governo”). Invocava per questo “non un governo di vendetta; ma un governo di uomini nuovi, un governo di uomini forti che chiamino le sane energie nazionali a lavorare per il bene supremo della Patria”: “Dopo quattro anni dalla vittoria – vi si affermava – i mutilati vedono che il Governo d’Italia è finalmente nelle mani di chi ha fatto la guerra e si appresta oggi a compiere la nuova ardua prova”.
Mussolini era cosciente del seguito che personalmente aveva il D. e del peso politico e organizzativo dell’ANMIG che, a quella data, contava – come disse il D. in un’intervista al Popolo di Trieste del 6 dic. 1922 – circa mezzo milione di iscritti, divisi in 250 sezioni e 2.500 sottosezioni.
Quando infatti C. M. De Vecchi elaborò verso la fine del 1922, in qualità di sottosegretario per l’Assistenza militare e le pensioni di guerra, un progetto di legge che provocò forti polemiche dei mutilati – data la divisione che veniva compiuta fra feriti di fronte al nemico e infortunati di guerra -, Mussolini, dopo aver ricevuto il D. e R. Romano, gli scrisse facendo chiaramente presente come appunto “non sarebbe opportuno né conveniente ignorare politicamente” l’associazione e sottolineando la necessità di accoglierne le richieste. De Vecchi invece riteneva – come scriveva in risposta a Mussolini – che vi fossero “profonde ragioni per tenere in sospetto i capi dell’Associazione”, sia per il recente tentativo dannunziano, sia per il timore che “l’offensiva che essi scatenano ora contro di me è strettamente legata a quella generale in atto contro il governo fascista” (Roma, Arch. centr. d. Stato, Segreteria particolare del Duce. Carteggio riservato, fasc. 47R, sottof. 3). Mentre De Vecchi veniva nel marzo 1923 trasferito al sottosegretariato per le Finanze, la legge per le pensioni approvata il 12 luglio di quell’anno rispecchiava le richieste dei mutilati; e, d’altra parte, Mussolini stesso provocò un voto del Gran Consiglio – il 13 genn. 1923 – col quale veniva approvata l’erezione in enti morali dell’ANMIG e dell’Associazione nazionale combattenti (ANC; poi istituzionalizzata il 24 giugno 1923) e veniva suggerita al governo una maggiore utilizzazione dei loro soci nell’amministrazione statale. Nell’aprile dello stesso anno, infine, un’altra legge demandava all’associazione dei mutilati l’esclusiva rappresentanza della categoria.
Presentato nella lista nazionale per la Toscana alle elezioni dell’aprile 1924, il D. venne eletto deputato con più di 48.000 voti: sarebbe stato riconfermato per le due successive legislature e come consigliere della Camera dei fasci e delle corporazioni. Dopo un primo intervento alla Camera – il 6 giugno – di pieno appoggio al governo, il D., in seguito al delitto Matteotti, tornò nuovamente in una fase di incertezza e di critiche, manifestando in diverse occasioni il suo dissenso.
Al V congresso dell’ANMIG di Fiume, nel luglio 1924, dal quale – anche se in misura minore del congresso dell’ANC che si sarebbe tenuto ad Assisi poco dopo – pervenne l’esortazione a Mussolini a mettersi sulla via della legalità, lo stesso D. intervenne affermando che se il fascismo avesse seguito “la via della legge, tutti i mutilati, tutti gli italiani, saranno con voi”; altrimenti, “ricordatevi che l’Italia è un grande popolo capace di tutti gli ardimenti” e che “la Nazione troverà nella sua coscienza la forza di combattere ancora la sua ultima battaglia per vincere ancora la sua ultima guerra”. Più tardi – mentre l’ANMIG era divenuta oggetto di accuse da parte dei fascisti per non aver dato la propria adesione alle celebrazioni del 28 ottobre – intervenendo al comitato centrale dell’associazione il 17 ottobre espresse forti critiche al regime, tanto che venne immediatamente convocato da Mussolini: sul Popolo d’Italia apparve, dopo il colloquio, un comunicato in cui si negava l’autenticità del discorso (stenografato da un membro della federazione napoletana e pubblicato su La Nazione e Il Mattino), ma il D. non smentì mai in prima persona. Ai primi di novembre, il D. e l’associazione furono nuovamente polemici – pur se in forma minore dell’ANC – con il regime, a seguito delle violenze che erano state commesse dai fascisti contro i combattenti nelle manifestazioni per l’anniversario della vittoria. Il 12 dello stesso mese, inoltre, dopo un altro colloquio con Mussolini, il D. dichiarò a La Nazione di avergli chiesto di non essere incluso nel comitato di maggioranza anche se solo per “motivi di ordine personale”, “senza considerazioni politiche”.
In questi mesi, inoltre, il D. era stato al centro dell’attenzione pubblica in seguito alle proteste scaturite per un articolo sulla Rivoluzione liberale del 2 sett. 1924, in cui P. Gobetti aveva scritto come fosse un’illusione “liquidare il fascismo con giochetti parlamentari, con le combinazioni della maggioranza, con lo Stato maggiore, con la rivolta dei vari Delcroix e simili aborti morali”. La frase, interpretata pretestuosamente, provocò il pestaggio di Gobetti da parte di alcuni fascisti, e diede vita alle vertenze cavalleresche di Gobetti stesso con R. Nardi, vicedirettore della Gazzetta del popolo che pubblicò violenti attacchi contro di lui, con V. Cian, primo firmatario di un telegramma di solidarietà al D. da parte dei deputati fascisti torinesi, e con G. Baccarini, segretario dell’ANMIG, che gli aveva telegrafato di ritenersi schiaffeggiato. Al D. invece pervenne la solidarietà dei mutilati, di vari esponenti fascisti, del Popolo d’Italia e numerosi giornali, dello stesso Mussolini, e di democratici come Amendola.
Dal punto di vista più strettamente politico, e proprio per il suo atteggiamento incerto, fu oggetto di attenzione da parte dell’opposizione, tanto che si parlò di un suo inserimento in un governo, presieduto da Giolitti, che avrebbe dovuto succedere a Mussolini. Venne anche contattato – come scrisse egli stesso – da personaggi vicini al regime: A. Rossini lo invitò a “far saltare le ultime difese di una posizione destinata a cadere”; il ministro della guerra A. Di Giorgio gli fece presente come molte armi erano state precedentemente consegnate alla milizia e come fosse per questo necessario “evitare qualunque atto che avrebbe avuto per conseguenza di far soffocare l’opposizione nel sangue”.
A Firenze ebbe un colloquio con D. Perrone Compagni, che si premurò di far arrivare a Mussolini – tramite il suo segretario particolare – le proprie impressioni sul presidente dei mutilati dato il “grandissimo seguito” che aveva in Toscana e l’utilità che avrebbe avuto “un suo reciso atteggiamento in favore del fascismo”: in una lettera del 5 nov. 1924 ad A. Chiavolini, affermava infatti che il D. “può diventare, basta che il Presidente lo voglia e lo valorizzi, uno strumento nelle sue mani”; che egli “ha una grande ambizione più spirituale che materiale”; che “non è antifascista ma lo potrebbe diventare se il fascismo gli muovesse addebiti o colpe, che dice di non avere”; e che “è mal circondato e viene spinto a mettersi contro di noi mentre è adescato con ogni allettamento dall’Italia libera, dalla Lega Italica e personalmente da Amendola”, anche se aveva dichiarato allo stesso Perrone Compagni di “respingere ogni allettamento perché egli riconosce che il fascismo ha delle grandi benemerenze, sia acquisite sia altre ancora e che il Duce è insostituibile” (Roma, Arch. centr. d. Stato, Segreteria particolare del Duce, Carteggio riservato, b. 5, fasc. 94R, sottof. 1).
Il 16 nov. 1924, ponendo fine a ogni incertezza e lasciando stupefatta l’opposizione, il D. intervenne alla Camera, per motivare il proprio voto di “piena fiducia” dato al governo il giorno precedente, con un discorso di totale appoggio e consenso al regime.
Nei suoi articoli autobiografici, Il dramma di una generazione, a proposito di quello che venne definito un “voltafaccia”, il D. scrisse che “passando all’opposizione non avrei mutato il corso degli eventi e forse avrei provocato subito… l’atto di forza che si riprodusse più tardi”, sostenendo come “anche a me sarebbe stato facile e comodo assentarmi, se fossi stato solo, ma ero a capo dei mutilati dei quali dovevo tutelare gli interessi”. Probabilmente, come ha sostenuto L. Pivano, al tempo rappresentante dei combattenti di Alessandria, e secondo il quale ancora alla vigilia del discorso alla Camera il D. era “affiancato all’opposizione”, fu ventilata la minaccia di togliergli la presidenza dell’ANMIG e di essere sostituito con un “successore cieco di guerra autentico e fascista di sicura fedeltà”: ricatti che, secondo l’allora presidente dell’ANC, E. Viola, provenivano, “sempre più serrati”, da R. Farinacci. Nonostante che ai primi di gennaio del 1925, a causa della sua assenza dalla seduta della Camera del 3 e delle voci che correvano sulla formazione di un gruppo di deputati mutilati (che il D. smentì in una lettera ai giornali del 6 gennaio), la sua posizione politica fosse sembrata di nuovo poco chiara, da quel momento il suo consenso al regime fu costante, a cominciare, tra l’altro, con l’appoggio alla mozione Turati, presentata alla Camera il 9 nov. 1926, che dichiarava decaduto il mandato parlamentare dei deputati dell’Aventino.
Continuava tuttavia a rimanere in sospetto presso alcuni fascisti, venendo accusato – come si legge in uno stralcio contenuto nel fascicolo che lo riguarda della Segreteria particolare del duce – di “servirsi dell’Associazione per lo smercio di suoi volumi”, di “essere antifascista” soprattutto in relazione alle trattative con D’Annunzio del 1922, e di “aver venduto il suo appoggio al Governo”. Una informazione della polizia fiorentina del gennaio 1929 – probabilmente in relazione, dato che di poco successiva, alla lettera anonima di un “fascista ortodosso” che protestava contro un articolo elogiativo sul D. di G. Rispoli apparso nella rubrica “scrittori fascisti” di Bibliografia fascista (n. 10, ottobre 1928) – rassicurava invece la segreteria di Mussolini che del “Grande Mutilato, del valoroso combattente, dello scrittore, del patriota niente è da dirsi di men che corretto di men che deferente di men che devoto. È ammirato e stimato dalla generalità anche per l’azione svolta negli interessi del Fascismo e della Patria dopo il delitto Matteotti”.
Gli anni tra il 1925 e il 1935, a detta dello stesso D. (ne Il dramma di una generazione), furono quelli “del mio entusiasmo per Mussolini”: ne scrisse una biografia, Un uomo e un popolo (Firenze 1928), definita nell’introduzione, “un atto di fede” e “una prova di nobiltà” (p. VII). Il libro fu consegnato a Mussolini il 12 marzo 1928 dal D., e dai suoi editori, i fratelli Vallecchi, che nell’occasione chiesero al duce, dati i “propositi fascisti” della casa editrice e il proprio programma di “portare alla rivoluzione politica il contributo della rivoluzione intellettuale”, di “affidare a noi qualcosa tra le più importanti pubblicazioni d’indole statale”. Proprio allora gli venne conferita, per decreto di Mussolini, la nomina a caporale d’onore della milizia, per essere stato – motivava il Foglio d’ordini del 28 ott. 1928 – “attivo collaboratore dell’opera del Regime nella sua qualità di deputato e di presidente” dell’ANMIG: “con il vostro riconoscimento – scriveva il D. a Mussolini per ringraziarlo – sento di ricevere l’investitura formale di una milizia che fu sempre la mia divisa interiore”. Ancora in questo stesso anno, il D., assieme ai mutilati, entrava nel Partito nazionale fascista (PNF).
Molteplici le sue attività politiche e culturali durante il ventennio. Come presidente dell’ANMIG (era inoltre presidente onorario dell’Unione italiana ciechi, della Federazione interalleata, del Comitato internazionale dei combattenti, cariche che gli furono tolte all’indomani della Liberazione) si adoperò per il potenziamento dell’associazione, per il miglioramento della sua legislazione e per la costruzione di case del mutilato. Nel 1938 l’ANMIG passò alle dipendenze del direttorio del PNF e nel dicembre 1939 Mussolini dispose che ai mutilati ammessi al partito venisse riconosciuta l’anzianità a partire dal 16 nov. 1924, data del discorso del D. alla Camera.
Consigliere comunale a Firenze tra il 1920 e il 1928, fece parte dal 1923 del consiglio di amministrazione dell’Ente per le attività toscane; dal 1929 divenne presidente dell’Ente fascista di cultura fiorentino, organizzazione sorta per iniziativa della federazione del PNF e che riuniva varie istituzioni culturali della città; dal 1931 divenne presidente dell’Ente autonomo del Regio Politeama fiorentino Vittorio Emanuele II, nato nel 1929 come Stabile orchestrale fiorentina per iniziativa della federazione provinciale fascista, che nel 1933 (anno in cui fu sostituito da L. Ridolfi) diede vita al Maggio musicale fiorentino: dal 1931 fu nel comitato della Fiera nazionale dell’artigianato fiorentino che era presieduto da G. Bottai.
Fu inoltre membro del Consiglio nazionale delle Corporazioni e del direttorio della Federazione degli artisti e professionisti.
Collaboratore del Corriere della sera, della Nazione, dell’Illustrazione italiana, dell’Ente italiano audizioni radiofoniche (EIAR) – che dal 1926 trasmise vari suoi discorsi -, direttore dal 1939 de La Vittoria, organo ufficiale dell’ANMIG, il D. proseguì anche nella sua attività di poeta e scrittore, pubblicando, sempre presso Vallecchi, I miei canti (1932) e il volume La parola comeazione (1936), vincitore del premio Viareggio. Ricevette inoltre le lauree honoris causa dalla facoltà di giurisprudenza di Perugia e da quella di lettere dell’università di Bologna; e numerose cittadinanze onorarie sia italiane sia straniere.
A partire dalla fine degli anni Trenta, constatando – scrisse aposteriori – che “la forza diventava peso e si aggravava in proporzione del consenso, che il potere non era un mezzo ma un fine, che la disciplina si traduceva in costrizione e in remissività. Era il dispotismo”, passò tra i critici del regime, dando sfogo, dopo l’entrata in guerra a fianco della Germania nazista (anche se ancora nel 1938 definiva alla Camera la politica estera “il capolavoro di Mussolini”), al proprio “livore antigermanico” e parlando “liberamente anche del Duce”, poiché “da qualche anno in qua non ne azzecca più una” (così G. Ciano, il 22 ott. 1941, nel suo Diario, Milano-Roma 1946, p. 76). Si avvicinò ulteriormente a casa Savoia ed ebbe, soprattutto nel 1943, alcuni colloqui con il re. Al generale P. Puntoni, da cui si era recato nel giugno di quell’anno per chiedere udienza con Vittorio Emanuele III, dichiarò di essere “un tenace, spietato avversario di Mussolini” e di ritenere “indispensabile che la Corona si muova”: “Occorre – disse – che il Sovrano sia però tempestivo. Se dovesse arrivare tardi, il crollo del Regime finirebbe per trascinare nella propria rovina anche l’istituto monarchico” (P. Puntoni, Parla VittorioEmanuele III, Milano 1958, pp. 134 s.). Per questo suo atteggiamento fu anche inserito, in rappresentanza dei fascisti monarchici, nell’elenco di ministri redatto da D. Grandi per il re, per un “governo di unità nazionale”, composto da uomini di tutte le tendenze purché non compromessi personalmente con la dittatura.
Caduto il fascismo, lanciò il 26 luglio un messaggio ai mutilati nel quale elogiava la “missione” che il sovrano aveva adempiuto “assumendo le responsabilità delle decisioni supreme”: ma nonostante il tentativo di rifarsi una parvenza di antifascista, fu accusato di essere un “trombone guerrafondaio” e un “corifeo del regime”. Da Mussolini per il suo nuovo atteggiamento politico e come “traditore” fu fatto arrestare nell’ottobre 1943 e confinato dapprima in un albergo di Brunate e quindi in uno di Miralago di Cernobbio.
Dopo la Liberazione, il D. entrò nelle fila del partito monarchico, per il quale fu eletto deputato, alle elezioni del 1953, per la circoscrizione Bari-Foggia, raccogliendo più di 23.000 preferenze. Ripresentato alle successive elezioni, risultò il primo dei non eletti. Alle elezioni del 1963 si presentò per il gruppo Stella e corona senza successo, e si ritirò dalla vita politica. I suoi discorsi per il partito monarchico vennero raccolti nel volume del 1959 Quando c’era il re (Milano). Collaboratore de Il Tempo dal 1946, proseguì nella sua attività letteraria pubblicando la raccolta di poesie La strada (Firenze 1947). una loro riedizione nel 1968 intitolata Val di Cordevole (intr. di F. Perrina, Bologna) e i Sonetti fiorentini nel 1971 (Pisa). Morì a Roma il 26 ott. 1977.(fonte)
Verano, Roma