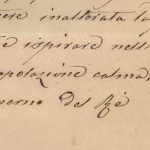Bol. 24 ott. 69
Caro …( Barbera[1])
Pei versi va bene tutto,
eccetto nella prefaz. che a me non garba.
Non garba, dico, che l’autore del libro di
poesia si metta a dissertare in principio
del suo metodo, del tecnicismo, dell’ispirazione,
della scuola ec. Veda: i poeti antichi e
anche dei moderni i migliori non han fatto
preposizioni. Specialmente poi in fronte
a un libro di poesie liriche la prefazione
prosaica del lirico stesso stona. Darò
delle cose inedite, riordinerò e raccoglierò
meglio e correggerò il tutto: ma per
la prefazione non me la sento: non
saprei cosa mi dire.
E badi: dell’
Aleardi[2] e del Zanella[3] le cose veramente
infelici e che indispongono un po’
il lettore sono a punto le prefazioni:
nel primo la vanità, nel secondo
una tal meschinità e quasi pedanteria
traspaiono a ogni linea. E forse
quelle due brave persone son tutt’altro
da qual che nelle prefazioni appariscono.
Ma in somma il proemiare a sé stessi,
il presentarsi da sé stessi al pubblico,
lo svelare i misteri di Cerere, ha nociuto
loro. Del resto, accetto tutte le condizioni
che Ella mi propone.
La ringrazio del compenso di lire
250 per i volumetti diamanti che
ri chiedono spogli, come gli Erotici e
i Lirici. Creda che è equo. Per i lirici
io ho scorso ben 38 fra volumi e volumetti,
senza contare i fascicoli; e avanti di
mettere insieme quell’indice, che poi
si fan le copie, ho quanto tempo ci è
voluto, e quanti mutamenti, e
quante cure, e quante gite alle
biblioteche.
Vorrei sapere se Ella è disposta
poi a pubblicare I compassionevoli
avvenimenti di Erasto. Ciò per mia
norma, che siamo presso a finire
i Lirici.
Di sì fatte scelte storiche
critiche vorrei poi farne qualchedun’altra
per il sec. XVIII per esempio:
Guidi[4], Zappi[5], e l’arcadia migliore
G. Manfredi[6], e la nuova bolognese fino
a Giov. Marchetti[7]
Novelle in versi
Satirici e moralisti
Giocosi.
Le poesie politiche della repubbl. cisalpina,
dell’italiana e del regno d’Italia,
dall’84 al 15.
Voglia passare al Serafini li
acchiusi foglietti: non posso levar via nulla
E gli dica che mi faccia avere i fogli
tirati dei Lirici, dei quali non ho avuto
ne pur uno: e ne ho bisogno per la
prefazione. Gli dica ancora che è successo
un imbroglio nel Petrarca: io mandai
per isbaglio le colonne che contenevano
i componimenti dal LIX in giù, che
non avevo riviste per la impaginazione;
così in tipografia le hanno impaginate:
ora ci vorrà un po’ di pazienza per
le correzioni. Creda che io mi adopero
Quanto è possibile per scemare
la difficoltà delle correzioni: e ho
semplificato di molto; e nella 3a
sezione semplificherò anche di più.
Ma il lavoro è grave, e poi per
maledizione funestarono anche li
sbagli.
Mi creda
Suo aff.
Giosuè Carducci[8]
Note
La lettera appare citata su:
Da «SU LA SOGLIA DELL’OPERA».
CARDUCCI PREFATORE DELLE PROPRIE RACCOLTE POETICHE
Chiara Tognarelli”
pp. 345-346
Il prologo in versi ai Levia Gravia non può essere riutilizzato. È a questo punto che inizia a profilarsi il problema di come introdurre il lettore alla raccolta. A metà ottobre Barbèra torna sulle Poesie ed espone a Carducci la propria idea di massima:
Ad onta che abbia veramente 20 volumi tra mano da stampare farò sempre per lei solo una eccezione. Quindi se Ella o nel febbraio o nel marzo (mese in cui arriva una nuova fondita di carattere, perché ora ne sono scarso) mi manda raccolte tutte le sue Poesie, e le intitola
Versi
di
Giosuè Carducci
nuovamente raccolti e ordinati
con una Prefazione ec. ec.
io ne assumo la stampa nel formato dello Zanella e dell’Aleardi. Ne faccio un’edizione a millecinquecento copie, e le do Lire cinquecento alla pubblicazione. Dico copie millecinquecento, da stamparsi in una volta o in due. E quando avrò esaurite queste 1500 copie, e che il libro sia sempre richiesto, rinnoverò la proposta; altrimenti Ella ritornerà libero delle sue Poesie. [Lettera del 15 ottobre 1869 (CC, cart. VIII, 10, 1890).]
Barbèra pensa a una prefazione in prosa: del resto – è lui stesso a suggerire il confronto –, è una soluzione simile a quella adottata per i Canti di Aleardo Aleardi e per i Versi di Giacomo Zanella, editi entrambi in anni recenti per la sua casa editrice. [Due pagine autobiografiche che possono servire di prefazione introducono la raccoltaALEARDO ALEARDI, Canti, edizione notabilmente accresciuta, e rivista dall’autore,Firenze, Barbèra, 1864, pp. VII-XXIII, mentre è una più canonica lettera dedicatoria
A Fedele Lampertico ad aprire GIACOMO ZANELLA, Versi, seconda edizione, Firenze, Barbèra, 1868, pp. V-XI.] La risposta di Carducci a Barbèra arriva con una lettera del 24 ottobre, e non è di accondiscendenza:
Caro signor Barbèra,
Pei versi va bene tutto, eccetto della prefazione che a me non garba. Non garba, dico, che l’autore del libro di poesia si metta a dissertare in principio del suo metodo, del tecnicismo, dell’ispirazione, della scuola ecc. Veda: i poeti antichi e anche dei moderni i migliori non han fatto prefazioni: specialmente poi in fronte a un libro di poesie liriche la prefazione prosaica del lirico stesso stona. Darò delle cose inedite, riordinerò e raccoglierò meglio e correggerò il tutto: ma per la prefazione non me la sento: non saprei cosa mi dire. E badi: dell’Aleardi e dello Zanella le cose veramente infelici e che indispongono un po’ il lettore sono appunto le prefazioni: nel primo la vanità, nel secondo una tal meschinità e quasi pedanteria traspariscono a ogni linea. E forse quelle due brave persone son tutt’altro da quel che nelle prefazioni appariscono. Ma in somma il proemiare a se stessi, il presentarsi da se stessi al pubblico, lo svelare i misteri di Cerere, ha nociuto loro. Del resto, accetto tutte le condizioni che Ella mi propone. [L VI, pp. 112-13.]
Questa lettera è il brogliaccio del primo paragrafo della prefazione Al lettore: le idee qui espresse sarebbero poi passate, in parte edulcorate e in parte censurate – scompaiono, ad esempio, i nomi di Aleardi e Zanella –, nella prefazione delle Poesie, secondo un processo trasfusionale tutt’altro che insolito per Carducci – sono ricorrenti, infatti, gli scambi fra la scrittura epistolare e le prose pubbliche, come se la lettera costituisse il laboratorio nel quale tentare e mettere a punto le componenti di ogni altro tipo di prosa, in particolare quelle polemiche e quelle d’invenzione.
pubblicato su: Quaderni di Gargnano 3
XVII Convegno internazionale di Letteratura italiana
“Gennaro Barbarisi”
GIOSUÈ CARDUCCI PROSATORE
(Gargnano del Garda, 29 settembre – 1° ottobre 2016) (fonte)
[1] Gasparo Barbera
Nacque a Torino il 12 genn. 1818 da Pietro e Rosa Guerra; i genitori, originari di Biella e mercanti di stoffe, erano di modeste condizioni, ma ebbero cura che il figlio avesse una discreta istruzione. A quindici anni entrò in un negozio di stoffe. In quegli anni l’amore alla lettura gli dette familiarità coi libri; letterati preferiti: S. Pellico, C. Marenco, A. Brofferio, D. Bertolotti, F. Romani, F. Sclopis, C. Balbo e L. Cibrario. Per essersi procurato da Parigi una copia dell’opera Dell’Italia libri cinque di N. Tommaseo, corse il rischio di essere arrestato. Più tardi, desiderando vivere sotto un governo liberale, si trasferì a Magadino, nel Canton Ticino, dove fece il commesso presso uno spedizioniere. Tornato a Torino, dapprima entrò nella rinomata casa dei fabbricanti di stoffe Giovanni e Gregorio Sella, poi ottenne un posto presso il libraio Fiore e più tardi, nel novembre 1840, per interessamento di G. Pomba, presso l’editore milanese P. Fumagalli, che si era stabilito da una diecina di anni a Firenze. Quì prese a frequentare il gabinetto Vieusseux, dove conobbe G. Libri, E. Rubieri e altri. Il B. rimase col Fumagalli solo pochi mesi, e passò quindi a lavorare col bibliofilo M. Malagoli-Vecchi; nell’autunno del 1841 fu assunto da F. Le Monnier. Con questo rimase per quattordici anni, con piena fiducia dell’editore, del quale condivideva gli intenti e di cui fu consigliere ed efficace cooperatore nella pubblicazione di quella “Biblioteca Nazionale” che tanto giovò a ravvivare e allargare l’amore degli studi in Italia.
Di quel periodo il B. ricorda lo studio e la lettura per migliorare la propria cultura, e i rapporti che strinse con molti letterati del tempo, fra i quali erano P. Giordani, G. B. Niccolini, F. D. Guerrazzi e G. Giusti.
Nel 1854 si separò in buon accordo dal Le Monnier e, dopo una esperienza negativa presso la stamperia granducale, riuscì a realizzare il vecchio desiderio di aprire una stamperia per proprio conto. Aiutato finanziariamente dal marchese Filippo A. Gualterio, entrò in società nella tipografia dei fratelli Beniamino e Celestino Bianchi, sull’orlo del fallimento e, con l’operosità e la prudente amministrazione, riuscì a riassestarla. L’impresa ebbe il nome di “Tipografia Barbera, Bianchi e C.” e si aprì al pubblico nell’ottobre 1854- Il B. acquistò ben presto buona fama di editore e stampatore.
Il Tommaseo da Torino gli fornì il primo manoscritto, dal titolo Il supplizio di un italiano a Corfù; l’edizione porta la data del 1855 e reca l’impresa della rosa con l’ape e il motto “Non bramo altr’esca”, suggerito da C. Guasti. Nel frattempo il B. aveva intrapreso la pubblicazione di un giornale letterario, Lo spettatore (diretto dal socio Celestino Bianchi e al quale collaborarono i più noti scrittori del tempo), ma che cessò dopo un anno le pubblicazioni. Nel 1855 apparvero le prime opere: il Vocabolario di Parole e modi errati di F. Ugolini, le Lezioni di mitologia di G. B. Niccolini e un volume di Pensieri e giudizi letterari di V. Gioberti, raccolti dall’Ugolini, che ebbero largo successo e varie ristampe. Nel 1856 iniziò anche la “Collezione Diamante”, notevole per la diffusione di opere di ogni letteratura, che gli fruttò molti elogi e molto successo commerciale.
Di tendenza liberale, assecondando il bisogno sentito in Italia di mettersi al corrente degli avvenimenti europei e di sprovincializzarsi, tra il ’58 e il ’60 diffuse varie pubblicazioni di carattere politico, che si diffusero a migliaia di copie. Questa attività gli procurò qualche fastidio: nel 1858, per la stampa della Storia del Concilio di Trento del Sarpi, su querela dell’arcivescovo G. Lamberti fu sottoposto a processo, ma fu assolto dal tribunale. Fra il 1858 e il ’59 accettò di stampare la “Biblioteca civile dell’Italiano” che, nel marzo ’59, per l’opuscolo Toscana e Austria, gli valse una perquisizione e un sequestro nella stamperia. Per il suo comportamento, oltre che per l’opera editoriale, il B. acquistò una grande popolarità, che gli giovò quando, mutate di Il a poco le condizioni politiche, si fondò (14 luglio 1859) il giornale La Nazione, che egli fu il primo a pubblicare e al quale cooperò come tipografo e come aniministratore sino al 1870. In quell’anno, passata La Nazione ad altra tipografia, il B. fondò il quotidiano Italia nuova, che durò poco più di un anno.
Frattanto, scioltasi nel ’59 la società coi fratelli Bianchi, la stamperia aveva assunto la ragione “Tipografia G. Barbera” e aveva progredito nella sua attività. Ebbero particolare fortuna due opuscoli di Marco Monnier sul brigantaggio e la camorra nel Napoletano, più volte ristampati, e nel 1868 i Miei ricordi di M. D’Azeglio, di cui il B. era stato amico in vita e che assisté amorosamente negli ultimi momenti; presso il B. pubblicarono N. Tommaseo, G. Capponi, I. Del Lungo, M. Tabarrini, A. Aleardi, G. Prati, G. Zanefia, M. Lessona, T. Mamiani, P. Mantegazza.
Fra i meriti del B. è anche quello di avere accolto con entusiasmo la proposta del giovane G. Carducci (cfr. G. Carducci a B., 3 ott. 1857, in Annali bibliografici e Catalogo ragtonato…, p.128) di pubblicare un’edizione di tutte le opere del Poliziano con l’aggiunta di una sua prefazione, oggi ricercatissima rarità bibliografica. Al Carducci affidò le sorti della collezione “Diamante”, facendogli curare parecchi volumi dell’Alfieri, del Tassoni, del Monti e di altri; pubblicò inoltre la sua prima raccolta di versi (Poesie di G. Carducci, Firenze 1871), e gli propose di scrivere articoli letterari per La Nazione.
Le principali collezioni ideate e attuate dal B. furono, oltre la ricordata “Diamante”, la “Collezione gialla”, iniziata nel 1855 con la pubblicazione delle opere del Tommaseo, e una “Collezione scolastica”, molto economica, iniziata nel 1867, che comprendeva vocabolari e traduzioni, libri di storia e geografia di autori come il Sommerville, lo Smith, il Bevan, ecc. Tra le ultime opere stampate dal B. fu il libro del generale A. La Marmora, Un po, di luce sugli eventi politici e militari dell’anno 1866, che destò molto scalpore e per il quale si interessò anche il parlamento italiano e il governo prussiano nella persona di Bismarck.
A lungo paralizzato, continuò ad occuparsi degli affari della stamperia, affidata alla direzione del figlio Piero, fino a che si spense a Firenze il 13 marzo 1880.
Postume furono pubblicate le sue Memorie di un editore, pregevoli anche per la forma letteraria, con una prefazione dei figli Piero e Luigi datata gennaio 1883, e, in appendice, una commossa “Nota”, un “Epistolario” e un catalogo per ordine cronologico delle edizioni.
Un elenco analitico di quanto il B. operò nel campo tipografico ed editoriale – contributo prezioso p ér la storia dell’editoria e insieme delle lettere – fu raccolto, per il cinquantenario della casa, nel volume Annali bibliografici e Catalogo ragionato delle edizioni di Barbèra, Bianchi e C., e di G. Barbèra; con elenco di libri, opuscoli e periodici stampati per commissione (1854–1880), Firenze ottobre 1904 (Addenda et corrigenda,ibid. 1918). I titoli sono disposti in ordine cronologico di stampa; di ciascun libro sono esposte le trattative preliminari con l’autore, le considerazioni economiche e morali che convinsero a stamparlo, la fortuna incontrata, e i più autorevoli giudizi espressi.(fonte)
[2] Aleardo Aleardi
Aleardi Gaetano Maria (assunse più tardi il nome con cui divenne famoso, Aleardo) nacque a Verona il 14 nov. 1812 dal conte Giorgio e da Maria Canali: dal padre accolse, forse, certo spirito aristocratico, che conservò nella vita e negli ideali, e dalla madre quella educazione del cuore che lo fece sensibile alle miserie degli infelici e schiettamente democratico in politica. Fanciullo malinconico, poco vivace nei primi anni di studio, si aperse poi ad entusiasmi improvvisi e diversi per la letteratura, la scienza, la vita sportiva. Frequentò di contraggenio i corsi di legge all’università di Padova, conducendo spensierata vita studentesca in compagnia di amici carissimi, tra i quali il Fusinato e il Prati: si accese ancor più d’amore alla poesia e d’amore di patria; e la donna, la natura, la patria, la poesia, furono le costanti passioni della sua esistenza. Dopo la laurea tornò a Verona, dedicandosi a quella vita di libero studioso e di artista, che gli fu sempre dolorosa per le ristrettezze finanziarie e per la solitudine cui lo costrinse, ma che corrispondeva alla sua nativa vocazione; per questo non volle mai formarsi una famiglia, alla quale l’avrebbe indotto la nativa affettuosità del carattere. Negli studi, incominciò a interessarsi di cose dantesche e di critica d’arte, intraprese qualche viaggio d’istruzione; per la poesia, concepi in questo tempo i primi lavori dati alle stampe e i primi disegni di altre opere, che verranno alla luce nella redazione definitiva una decina d’anni più tardi.
Nei suoi primi componimenti risentiamo con facilità l’influsso del Manzoni e del Foscolo. Ne Il matrimonio (1842) canta il diffondersi del vincolo coniugale nelle varie civiltà, nell’Arnalda di Roca (1844) l’eroismo di una fanciulla che sacrifica la vita all’onore e all’amore: un lungo poemetto storico, in cui non mancano scorci di taglio drammatico, pennellate di colore, note d’affetto, ma in cui sono anche enfasi ed ingenuità giovanili, con quella tendenza allo scenografico, che sarà poi caratteristica nella fantasia del poeta. In questo periodo egli compone un poemetto storico, Il Bragadino, che fu poi distrutto per motivi politici, concepisce un altro poema, Il Mosé, a esaltazione di Pio IX, e quei Canti della campagna romana che rielaborerà poi ne Il monte Circello. Ma ottiene il primo successo con le Lettere a Maria (1846): due lettere in versi sciolti, in cui il poeta propone un platonico amore, in nome delle comuni sofferenze, a una cara amicizia, e parla, del destino umano, dell’immortalità dell’anima, dei motivi per cui crede in essa. Le Lettere a Maria ebbero fortuna perché corrispondevano a quella affettuosità del sentimento tanto celebrata in altri poeti, come ad esempio in Lamartine, e a quell’ansia di certezza, d’infinito, di religiosità che costituiva uno dei motivi fondamentali della temperie romantica. Ma più di un tono qui non convince. Non che l’A. non fosse sincero, perché fu onesto e galantuomo quant’altri mai: ma la sua stessa debolezza di carattere, l’indole affettuosamente mite e ingenua lo inducevano a un manierismo sentimentale, che era della sua natura ancor prima che della sua poesia. Questa indefinitezza sentimentale fu anche, in lui, incertezza di pensiero e incertezza di gusto: fedele alla teoria romantica delle due arti, l’arte olimpica e l’arte sentimentale, e avverso per evidenti motivi contenutistici all’Arcadia, al Seicento, alla mitologia, proprio attraverso questo contenutismo volle nell’arte non solo un forte impegno politico, ma anche interessi di cultura di scienza e di fiòosofia: e pure non mancò di avvertire altre volte che la forma è connaturata al pensiero e che l’arte dovrebbe avere in se stessa il proprio fine. Così pure, a volte, affermò che l’arte è pazienza e sapienza, e mai seppe soffermarsi sui suoi versi, con lavoro di lima: non appena scritti, gli venivano in uggia. Anche la sua posizione verso il realismo è assai dubbia, perché egli afferma che oggetto dell’arte è la verità, ma una verità “cinta di stelle”: così che nella sua opera la tendenza al reale si affaccia con improvvise disarmonie tra i sentimenti e gli affetti più astratti e ideali.
Il poeta stesso fu sempre consapevole di questa sua incertezza teorica, di questa sua debolezza nativa, che lo portava alla dispersione o all’artificio che cela la dispersione: volle scusarsene, attribuendo alla censura la colpa di certe oscurità, ai tempi in cui visse la mancata ispirazione di lunghi periodi, ma non mancò poi, nei rapporti privati con gli amici, e tra essi il Manzoni e il Martini, di confessare i li-miti della sua opera, che con scorato pessimismo credeva tutta destinata all’oblio in breve volger di tempo: e riconosceva solo al Carducci il merito di aver scelto la via giusta.
Invero, si osservano nella vita dell’A. strani periodi di assoluta incapacità creativa, che d’altra parte dimostrano come egli componesse soltanto quando se ne sentiva l’ispirazione. Periodo infecondo è, ad esempio, quello successivo trascorso a Parigi, inviato in missione speciale da Manin per sostenere la causa di Venezia, nel 1848: ma la delusione politica fu talmente forte che il poeta meditò persino di emigrare in America, e ne fu dissuaso soltanto dal pensiero della sorella e della patria che avrebbe dovuto lasciare forse per sempre. Dopo l’esperienza politica, ritorna a Verona, ove conduce vita triste e solitaria, languendovi “come una panetana in ombra malsana”, sorvegliato dalla polizia che, nel 1852, in occasione dei processi di Mantova, lo arresta e lo rinchiude nella fortezza di quella città. Liberato dopo dura prigionia, ritorna a Verona, ove affronta altre dolorose esperienze: delusioni amorose, malattie, l’impressione di aver fallito nella propria vita e nella propria arte. Tra le poche liriche di questo periodo ricordiamo una novella in versi, Francesca da Rimini, e poesie composte per il tradimento di una donna, i suoi “fiori del male”, come fu detto: ma si tratta di ben povera cosa. Per non trattare temi politici, per i quali era sempre in sospetto della polizia austriaca, compose anche un idillio, Raffaello e la Fornarina (1855), in cui affermava simbolicamente il diritto dell’artista all’amore in nome delle sue creazioni di bellezza: un componimento, insomma, che nella sua concezione nasconde venature di poetica predecadente, ma su cui grava un falso realismo biografico di cattivo gusto, con episodi e battute leziose, mentre il poeta sembra farsi paraninfo tra il pittore e la sua ispiratrice. La vena poetica riprende, invece, improvvisamente vigore poco dopo, intorno al 1856: e sono questi gli anni in cui l’A. compone le sue cose più belle. Riprende e rielabora alcuni canti già composti, e pubblica così Il Monte Circello, in cui immagina di scorrere dall’alto la campagna delle paludi pontine, e ne trae occasione per quadri dolorosi (i mietitori condannati alla malaria) o per delicate e insieme colorite rievocazioni storiche (Corradino e il castelo d’Astura): due liriche tra le più belle, brani realmente degni, come comunemente avviene, di una raccolta antologica esemplare. Ristampa integralmente anche le Prime storie (1857; aveva incominciato a lavorarvi dopo il 1846) in cui, rifacendosi alle prime vicende dell’umanità e quindi alle varie fortune della nostra terra, ne trae auspicio per i migliori destini. É una raccolta di quadri staccati, in cui mancano assolutamente il senso e la prospettiva storica, ma in cui sono forti visioni di vicelide bibliche, quadri ispirati di nature vergini ed esotiche: una nuova esperienza, e forse la più sostenuta, della poesia aleardiana. Compone anche Le antiche città italiane marinare e commercianti (1856), in cui il quadro storico si fa assai più concreto e fedele, con grande vantaggio dell’unità compositiva: e anche qui non mancano versi caldi e ispirati come, a esempio, quelli dedicati a Pisa.
Fiorisce in questo tempo qualche tentativo di satira, e la sua più impegnata poesia politica, che vedrà la luce, tuttavia, più tardi, dopo una nuova dolorosa esperienza. Compone alcune notissime liriche, Le tre fanciulle, I tre fiumi, Triste dramma, che verranno raccolte alcuni anni dopo sotto il titolo di Canti patrii: questi canti, infatti, non vennero pubblicati allora perché, nel giugno del 1859, nell’improvviso aggravarsi della situazione militare, egli fu nuovamente arrestato e inviato a Josephstadt, in Boemia, ove ebbe molto a soffrire, ma ove rimase fortunatamente non a lungo, per la rapida conclusione della guerra. E si tratta di un periodo sterile per la poesia, fatta eccezione per qualche breve componimento non privo di grazia (Sehensucht). Ritornato in Italia, si stabilisce a Brescia, ove dimora per quattro anni: e ritorna alla poesia politica, con I sette soldati (1861), racconto delle vicende di sette militari austriaci morti in battaglia e nativi di lontane regioni, e con il Canto politico (1862), in cui, anticipando certa poesia carducciana, condanna con insolita veemenza quanti si oppongono a che Roma divenga capitale d’halia. Riceve intanto anche i primi riconoscimenti ufficiali: gli si offre la cattedra di letteratura italiana all’Accademia di Brera, già tenuta dal Panni, viene eletto deputato e presidente dell’ateneo bresciano. Ma uno strano timore a parlare in pubblico e uno stanco sentimento di scoratezza, di sfiducia, lo assale ora: rinuncia alla cattedra. Con gli ultimi canti politici (I fuochi sull’Appennino, 1864) si spegne ormai anche la sua vena. Non gli rimane che raccogliere in una edizione unica tutta la sua produzione, alla quale fa precedere due pagine autobiografiche sulla natura della sua vocazione alla poesia: una confessione affettuosa e dimessa, anche manierata, non una dichiarazione squillante.
Il poeta, nel 1864, si trasferisce a Firenze, ove accetta la cattedra di estetica all’Istituto di Belle Arti: e qui rimane per il resto della sua vita, preparando con cura e non senza fatica i corsi ai quali accorre un pubblico sempre più numeroso e sempre entusiasta. In questo l’ultimo periodo della vita dell’Aleardi. Egli ha onori e fama, viene eletto senatore nel 1873, tiene conferenze e discorsi che gli offrono plausi e consensi, crea ora di sé quel mito di poeta salottiero, che non dispiace a certa ingenua civetteria della sua anima semplice, ma che susciterà poi aspre reazioni: e tra i consensi incominciano proprio ora anche gli attacchi più aspri. E, sopra tutto, la sua esile vena poetica ormai tace: neppure la terza guerra d’indipendenza gli ispira il canto desiderato. Ha il solo conforto di qualche amicizia gentile; ormai sopravvissuto a se stesso, e consapevole di questo, muore improvvisamente a Verona il 17 luglio 1878.
Chi si trovi, a distanza di tempo, a voler giudicare con serenità l’opera dell’A., non può nascondere certo senso di disagio, che nasce dalla prima lettura. Egli, in un primo istante, può stancare il lettore, o persino muoverlo al sorriso; ma, quando si superi tale impressione e si voglia guardare un poco più addentro nelle strutture della sua poesia, si ha la gradita sorpresa di ritrovare più di una pura vena di canto.
In passato, gli si è mossa l’accusa di essere un imitatore: ma è l’accusa meno consistente. È vero che molti dei suoi versi ci ricordano Dante, Foscolo, Leopardi, Manzoni, o Byron, Lamartine, Hugo, ileine; è vero che, non a caso, sono stati fatti altri nomi, Musset, Uhland, Goethe, Shakespeare, Freiligrath, Ruckert, Platen, Virgilio, Properzio, Catullo, e persino il Fracastoro (aggiungeremmo una singolare affinità con certa poesia del Poerio). Pure, basta il confronto puntuale per dimostrare che quei versi rientrano nella sua opera come il materiale antico in una costruzione nuova. Si tratta di vari sedimenti di una cultura non ricca e dispersa e pur non superficiale, che affiorano alla memoria del poeta, ma non fanno storia: e la sua stessa dichiarazione in proposito, di non aver imitato mai, deve essere accolta con fiducia. Altre accuse, invece, hanno ancor oggi il loro pieno significato: quella, a esempio, di aver creato una poesia molte volte priva di nerbo, o molte volte segnata da ingenuità improvvise. L’A. tende al narrativo, manca di sintesi, si svia dietro ai particolari, come se fossero le sue sirene incantatrici. Così il motivo umano perde forza, e tutto si ammorbidisce in lui: l’epiteto trionfa sul sostantivo e sul verbo, l’astratto sul concreto, l’elemento fonico finisce per dominare e snaturare l’elemento visivo. Inoltre, frequentissimi sono i trapassi irrazionali e pesanti, i paragoni ora leziosi ora grotteschi, le ingenuità sentimentali. Queste disavventure della poesia aleardiana si potrebbero controllare m uno studio specifico anche attraverso le disarmonie dello stile, come in parte fece il De Lollis: i diminutivi e ancor piu i vezzeggiativi sono frequenti, e frequentissimi poi i vocaboli scientifici o tecnici, i quali male si armonizzano con i termini del classicismo più aulico o con le nuove formazioni verbali: così che la sua poesia, narrativa per l’ampiezza dello svolgimento e del ritmo, passa con scosse troppo forti dallo stile familiare a quello improvvisamente sciatto o a quello sostenuto ed eloquente. Disarmonie tutte che derivano dalla situazione umana e culturale insieme, per cui bene l’A. si inserisce nel secondo romanticismo. La forte passionalità dei romantici, irrazionale, istintiva come una forza prima della vita, si è fatta ora costume, ha perduto di intensità ed ha acquistato continuità di atteggiamenti: il sentimento tende al sentimentalismo, il dolore si fa malinconia, la disperazione scoramento, l’ideale speranza, l’amore infatuazione. E il reale sembra avere il sopravvento sull’ideale. Di qui la necessità, caratteristica in molti tra questi poeti, di vivere almeno nella vita il loro sogno di poesia, di esprimere con l’azione stessa quel mondo che essi non riescono a esprimere con la parola. Anche per questo la tendenza all’autobiografia costituisce ora un peso assai greve. L’ispirazione è discontinua e faticosa, deve muovere da stimoli esterni: l’A. trascorse anni, come vedemmo, senza scrivere un verso, e per scriverne doveva essere commosso o da un dolce sguardo femminile, o da una intima necessità di pianto. Lo stesso classicismo della sua poesia sembra assunto in funzione di una nobiltà e di una forza che il poeta non ha di per sé, e cerca quindi di attingere alla tradizione. Per questi motivi l’A. appartiene alla seconda stagione romantica. Ma non tutta la sua poesia rientra in questa caratterizzazione. A volte c’è in lui una delicata e gentile notazione di sentimento, a volte la forza di un’immagine (specie nella poesia patriottica) di insolito vigore drammatico, la concretezza di un particolare, che ha un suo realismo tutto vivo. Altre volte, e ancor più frequentemente, la sua poesia ci presenta scene di una serena, compiuta armonia, specie nelle descrizioni di terre vergini, di paesaggi affascinanti: per questa armonia di composizione, più che per la ricchezza dei particolari o per l’intensità e la felicità dei colori, è bene accettare la definizione che l’A. dava di se stesso, di poeta pittore. Certi quadri di Ingres o di Hayez o certe illustrazioni dell’Atala di Chateaubriand potrebbero venir felicemente accostati a questo gusto pittorico della poesia aleardiana. Quasi sempre poi, ed è forse il dono più nativo e fecondo, avvertiamo nel verso ampio – che risolve felicemente anche il più artificioso espediente fonico, o l’accordo piano o la snella movenza – una risonanza musicale che ha suggerito a qualche critico il paragone con le melodie belliniane: e in questa musicalità il poeta sfuma i suoi quadri migliori, quelli in cui si sottrae alla tentazione della suggestione autobiografica, con immagini di serena o malinconica bellezza.
Dell’A. è necessario, tuttavia, prendere in considerazione anche un altro aspetto, sino ad oggi non sempre debitamente riconosciuto: la sua grande importanza culturale, non tanto per quel suo rifarsi al decoro della forma classica, di cui abbiamo avvertito l’origine e ilimiti, o per quel suo gusto realistico che affiora saldo tra le nebbie fluttuanti del sentimento: non tanto e non solo per questo. Neppure gli attribuiremmo importanza per il fatto che le tendenze più disparate del romanticismo, che ormai volge al decadentismo, si avvertono già tutte nella sua lirica, che è fenomeno proprio anche di altri poeti; piuttosto, per il magistero anche formale che egli seppe esercitare su quanti vennero dopo di lui, sui poeti stranieri, e sui poeti italiani, sopiattutto. Alcune tra le più note immagini carducciane derivano dall’A., come anche alcuni singolari componimenti del Pascoli, che grandemente lo ammirava; certe audacie stilistiche del Tommaseo, in prosa e in verso, che egli accolse come fonte, le trasmise alla letteratura che seguì; certo scetticismo ingenuo dello Stecchetti, certe libertà metriche del D’Annunzio, certe inquietudini anche stilistiche del Fogazzaro, certe cadenze fra compiaciute e abbandonate dei crepuscolari, derivano dall’esperienza della poesia aleardiana. L’Aleardi, con assai migliore efficacia di altri, segna quel momento del romanticismo che si apre ormai su prospettive nuove.
Non di grande rilievo l’opera del critico, che si esercitò soprattutto nel periodo fiorentino e quasi unicamente nella critica d’arte: non mancano fini e belle osservazioni, che, tuttavia, acquistavano valore più nei toni suadenti e affettuosi della sua voce che nella ricchezza dell'”humus” culturale: l’opera di un conferenziere felice.
La fortuna critica dell’A, èvaria, ricca di chiaroscuri e di forti contrasti. I primi giudizi notevoli risalgono ai suoi contemporanei, al Romani, che mise in luce certa sua istintiva naturalezza non sempre utile all’arte, al Tenca, che lodò il dono di certa musicale indefinitezza della sua forma, al Cattaneo, che scopri in lui la forte vena realistica. Quasi sempre favorevole il giudizio del pur difficile Tommaseo, ed entusiastico il giudizio dei patrioti e degli uomini del Risorgimento, come, ad esempio, quello del Troya. Il periodo di più alta fortuna della poesia aleardiana corrisponde all’incirca all’epoca di composizione de I sette soldati: e per le molte edizioni uscite alla macchia il poeta si decise alla stampa di tutti i suoi canti. Ma già nel 1865, in un articolo dello Zoncada, si avanzavano dubbi sulla sostanziale solidità di fondo del suo mondo poetico: il Rapisardi e il Capuana lo attaccarono come poeta troppo idealista, il Rovani accolse il paragone, poi tante volte richiamato, col Prati, definendolo meno puro e meno vero di lui: ma l’episodio più clamoroso della mutata tendenza si ebbe con la ben nota stroncatura dell’Imbriani. Lo stesso Trezza, che gli fu amico e che subito dopo la morte curò la pubblicazione di parte dell’epistolario, dopo un’analisi abbastanza attenta, anche se limitata e troppo soggetta all’influsso della personale amicizia, concludeva con giudizi assai cauti (“Musa gentile, onesta e magnanima”; e una delle figure più simpatiche del nostro Risorgimento”). Verso la fine dell’Ottocento la fama dell’A. era in completo declino: non mancò chi, con poca generosità, disse che la sua musa era imbellettata, e chi lo defini anche poeta delle signore.
La fortuna dell’A, riprende, sia pure con qualche contrasto, con il nuovo secolo: tra i primi a promuovere questa rivalutazione è il Croce, il quale ravvisò in lui un sincero poeta, un poeta di bontà e di malinconia sotto l’orpello di certe forme, e lo indicò come un precursore del Pascoli. Il De Lollis non risparmiò qualche battuta ironica, che non poteva mancare alla sua natura di critico davanti ad un autore che tanto si presta all’ironia, ma, sostanzialmente, ne riconobbe l’importanza storica, indicando in lui il poeta di transizione in cui si avverte il conflitto tra romanticismo e parnassianesimo, tra poesia contenutistica e poesia pura, tra il passato e l’avvenire della vicenda romantica; ascrisse anche a suo merito la tentata conciliazione tra gusto realistico e tradizione classica. La posizione del De Lollis è ripresa e definita in alcuni particolari dal Bosco e dal Marcazzan: il Bosco, in quanto gli riconosce l’esigenza di definire lo sfocato del sentimento attraverso la vena realistica, il Marcazzan, in quanto vede nella sua incertezza sentimentale la sottile aspirazione romantica, quel fantastique du réel, e tanto più agevole a definire criticamente quanto più arduo a conseguire come immagine e come forma.. Rimangono sostanzialmente in una posizione di condanna il Pompeati (“una crisalide di poeta”), il Momigliano (“nella sua poesia c’è quasi sempre l’aleardismo, quasi mai l’Aleardi”) e il Vicinelli, il quale, rinnovando il ben noto parallelo, lo definisce “una attenuazione del Prati”. Tutto a favore dell’A., invece, anche nei confronti del Prati stesso, è il giudizio del Flora, che, nella sua Storia della letteratura italiana, si sofferma a lungo sull’analisi di alcune sue liriche, indicando come in esse i temi poetici sorgano ispirati da rapporti figurativi di analogie paesistiche e cosmiche, in uno stato di comunicatività cordiale e cantabile, e affermando che la voce, pur affrettata e precoce, dell’A., è di genuina qualità poetica: per questa voce anche i temi più dispersi si raccolgono per il lettore in un’unica “memoria di poesia”. Anche il Sapegno conferma che, meglio del Prati, l’A. ebbe qualità genuine di poeta e di artista, e riconosce la bontà della sua disciplina letteraria, pur accusando la sua “scarsa capacità di reagire al cattivo gusto dell’epoca”.(fonte)
[3] Giacomo Zanèlla
Poeta (Chiampo 1820 – Monticello Conte Otto, Vicenza, 1888). Sacerdote dal 1843, insegnò lettere nel seminario di Vicenza, ma nel 1848 fu sospeso dall’insegnamento per i suoi sentimenti d’italianità; nel 1857 riottenne la cattedra; dopo l’annessione del Veneto, e sino al 1876, fu prof. di letteratura italiana nell’univ. di Padova. Assai più che alla sua opera critica (Paralleli letterari, 1885; Storia della letteratura italiana dalla metà del ‘700 ai giorni nostri, 1880, ecc.), Z. deve la sua fama all’opera poetica (Poesie, varie raccolte dal 1868; Astichello, 1884, 1887 e postume), nella quale, tentata dapprima una conciliazione poetico-filosofica tra scienza e fede (celebre l’ode Sopra una conchiglia fossile nel mio studio), finisce poi per ripiegarsi su sé stesso ad ascoltare le voci della natura, chiudendo questo suo vagheggiamento in limpidi versi, talora di classica purezza. Nel 1989 ha preso avvio l’ed. completa delle sue Opere, prevista in 7 voll., a cura dell’Accademia Olimpica di Vicenza.(fonte)
[4] Alessandro Guidi
Poeta, nato a Pavia il 14 giugno 1650, morto a Frascati il 13 giugno 1712. Iniziò la sua carriera poetica alla corte del duca Ranuccio Farnese a Parma, alla quale fu ammesso sedicenne. Nel 1681 pubblicò una raccolta dei versi scritti nel primo periodo della sua permanenza a Parma, e nello stesso anno diede alle stampe il melodramma Amalasunta in Italia. In questa produzione giovanile, ch’egli più tardi ripudiò, fu marinista, pur manifestando disposizioni a una lirica di sensi più virili. Si recò a Roma nel 1683, ed entrato nelle grazie di Cristina di Svezia, fu ammesso alla sua corte e iscritto all’Accademia reale fondata da lei nel 1656. Divenne così il celebratore di Cristina, che certo gl’ispirò l’Endimione, dramma mitologico, se pur questo, come afferma il Crescimbeni, non fu scritto in collaborazione con lei. Ciò rivela un’intimità spirituale che spiega come per il G. Cristina divenisse quell’essere soprannaturale ch’egli esaltò con modi sproporzionati alla realtà storica. Fu ammesso nell’Arcadia nel 1691. Voltosi a imitare il Chiabrera, lo seguì nel desiderio di novità e di riforme metriche, e si diede a comporre con armonia varia e irregolare, quelle canzoni che furono dette libere. Nel 1709, tornato per breve tempo a Parma, riuscì a ottenere da Eugenio di Savoia, governatore dello stato di Milano, certi sgravî finanziarî a beneficio del comune di Pavia, onde fu dai concittadini ammesso nell’ordine dei nobili. Di ritorno a Roma, attese alla composizione di sei Omelie e fu dal papa iscritto tra i suoi servitori.
Il poeta, fiacco di fantasia e incapace di creare quel grande fantasma che la realtà empirica non gli offriva, e pur vago di gonfiezze e di enfasi, dovette appoggiarsi alla rettorica. Ciò non toglie che nella produzione lirica del G. si trovino note di vera poesia, alle quali forse si deve la fortuna di cui egli godette presso i migliori lirici del Settecento e del primo Ottocento: il Varano, il Parini, il Monti, il Foscolo e il Leopardi.(fonte)
[5] Giovan Battista Felice Zappi
Poeta (Imola 1667 – Roma 1719). Esercitò con fortuna l’avvocatura a Roma. Nel 1690 fu uno dei fondatori dell’Arcadia (Tirsi Leucasio), da alcuni riconosciuto come l’unico vero poeta di quel primo gruppo. Non scrisse molto (55 sonetti e altri pochi componimenti); non ancora del tutto libero dal gusto secentistico, mescolò il languido al concettistico. Marito di F. Maratti (v. Zappi Maratti, Faustina).(fonte)
[6] Girolamo Manfredi
Nacque a Bologna il 25 marzo 1681 da Alfonso e Anna Maria Fiorini.
Il padre, originario di Lugo, era un notaio provvisto di buona cultura e scelse per i figli i migliori precettori privati. Il primogenito Eustachio studiò diritto e successivamente materie scientifiche; i più giovani, fra cui il M. ed Eraclito, furono avviati alla medicina, mentre Emilio divenne gesuita e apprezzato predicatore. Le due figlie, Maddalena e Teresa, ebbero elevata cultura e collaborarono con i fratelli; Teresa scrisse anche versi in dialetto bolognese.
Il M. e il fratello Eustachio dimostrarono un ingegno precoce e una marcata predilezione per gli studi scientifici. Il M., tuttavia, abbandonati gli studi medici perché le lezioni di anatomia umana lo spaventavano, si rivolse alla storia, lingue, poesia e geografia, disciplina nella quale eccelleva, anche per una non comune memoria. I due fratelli ebbero la fortuna di incontrare, prima che nel 1699 lasciasse l’Università di Bologna per quella di Padova, D. Guglielmini, corrispondente di G.W. Leibniz, che indirizzò loro e Vittorio Francesco Stancari al calcolo differenziale. Essendosi però Eustachio volto soprattutto all’astronomia, il M. dovette presto procedere da solo. Lesse gli articoli di Leibniz e di Johann e Jacob Bernoulli negli Acta eruditorum, ma apprese il calcolo soprattutto dall’Analyse des infiniment petits (Parigi 1696) di G.-Fr.-A. de L’Hôpital, che metteva a frutto lezioni private ricevute da Jo. Bernoulli. Nel 1694 Eustachio aveva fondato a Bologna l’Accademia degli Inquieti, cui parteciparono anche il M., Stancari e G. Verzaglia, un giovane cesenate studente a Bologna. Essa divenne poi l’Accademia delle scienze dell’Istituto, trovando ospitalità nell’istituzione fondata da Luigi Ferdinando Marsili nel 1711.
Alla fine del 1702 il M. si recò a Roma alla ricerca d’un impiego, raccomandato dal fratello a Francesco Bianchini, bibliotecario del cardinale Pietro Ottoboni nonché storico, antiquario e astronomo, che stava allora costruendo una meridiana in S. Maria degli Angeli sul modello di quella creata da G.D. Cassini a Bologna in S. Petronio. All’impresa collaborò il M., che a Roma dal 1703 al 1706 frequentò studiosi di vaglia come il cardinale E. Noris, prefetto della Biblioteca Vaticana (morto nel 1704), il medico G. Baglivi, il gesuita A. Baldigiani e l’abate D. Quarteroni, professore di matematica alla Sapienza dal 1696 al 1734.
A Roma un’apposita congregazione, della quale era segretario Bianchini, studiava una riforma del calendario gregoriano. Durante i lavori il M. ebbe occasione di conoscere G.F. Maraldi, nipote di Cassini e suo collaboratore all’Observatoire di Parigi, che lo mise in contatto con P. Varignon, impegnato in Francia nello studio del calcolo differenziale e integrale. Dal 1701, inoltre, il M. aveva cominciato a corrispondere con il camaldolese G. Grandi, formatosi scientificamente a Firenze, dove aveva conosciuto V. Viviani e studiato le opere matematiche di J. Wallis, del quale aveva impiegato i metodi analitici nelle sue prime opere, relative alla “finestra del Viviani” e alla curva logaritmica. Grandi, trasferitosi a Pisa e già matematico famoso, desiderava sapere di più dei metodi del calcolo differenziale, già utilizzati con competenza dal Manfredi. Questo suo desiderio e quello del M. di avere un interlocutore autorevole, fuori dalla cerchia degli amici, alimentarono una corrispondenza scientifica che è il primo documento sulla diffusione del calcolo differenziale in Italia. Essa proseguì abbastanza fitta nel 1702 e nel 1703, quando comparve a Pisa la Quadratura circuli et hyperbolae di Grandi, prima opera a stampa di un italiano che facesse uso del calcolo differenziale. Nella primavera del 1706 il M. tornò a Bologna, dove attese alla pubblicazione della sua opera più celebre, De constructione aequationum differentialium primi gradus (Bologna 1707), prima monografia nel mondo dedicata allo studio delle equazioni differenziali.
L’opera, in sei sezioni, raccoglieva e presentava in modo ordinato i risultati relativi alle equazioni differenziali del primo ordine sparsi nella letteratura matematica, fungendo da seguito dell’Analyse dell’Hôpital. Studiava dapprima le equazioni con soluzioni algebriche, poi quelle che portano a curve trascendenti, passando quindi alle equazioni che si risolvono mediante sostituzioni di variabili. L’ultima sezione era una miscellanea di problemi, alcuni solo proposti, come l’integrazione di un’equazione omogenea. Il libro, scritto per concorrere a una cattedra universitaria a Bologna, data invece a Ercole Corazzi, fu inviato a Leibniz, che lo apprezzò, e fu recensito favorevolmente negli Acta eruditorum (1708) e nel Giornale de’ letterati d’Italia (1710).
Nel 1708 il M. entrò come collaboratore nella Cancelleria del Senato bolognese, dove giunse al grado di primo cancelliere e rimase fino al pensionamento nel 1752. Dal 1720, inoltre, insegnò nello Studio bolognese e, dal 1742, fu anche soprintendente delle Acque in sostituzione di Eustachio. Pur allontanato dagli studi a causa delle cariche ricoperte, il M. diede ancora per alcuni anni risultati significativi nel campo delle equazioni differenziali e della teoria dell’integrazione.
Il metodo di integrazione delle equazioni differenziali omogenee legato al suo nome apparve nel Breve schediasma geometrico per la costruzione di una gran parte delle equazioni di primo grado, in Giornale de’ letterati d’Italia, XVIII (1714), pp. 309-315. Un altro importante lavoro, sull’integrazione di una formula differenziale proposta da Brook Taylor ai matematici continentali, apparve in un Supplemento allo stesso Giornale (Soluzione di un problema appartenente al calcolo integrale, in Giornale de’ letterati d’Italia, Supplemento II, 1722, pp. 241-269). L’attività del M. nell’analisi matematica proseguì con una quindicina di dissertazioni, soprattutto sull’integrazione delle equazioni differenziali ordinarie, lette all’Accademia delle scienze dell’Istituto di Bologna dal 1727 fino al 20 giugno 1761, poco prima della morte, apparse in parte nei Commentarii dell’Accademia (De formulis quibusdam integrandis, in De Bononiensi scientiarum et artium Instituto atque Academia Commentarii, 1731, vol. 1, pp. 573-588; De eliminandis ab aequatione arcubus circularibus, et alia, ibid., 1747, vol. 2, Pars tertia, pp. 520-551; De inveniendis datarum formularum irrationalium reciprocis, ibid., 1755, vol. 3, pp. 432-453).
Dopo il 1715, tuttavia, il M. fornì i contributi più importanti come docente e tecnico impegnato nello studio delle acque correnti, che in Italia aveva già avuto cultori illustri come B. Castelli, G.D. Cassini e Guglielmini.
Agli inizi del Seicento il Reno, che si riversava nel Po di Primaro nei pressi di Ferrara e che, con il trasporto di materiali nelle piene, stava impedendo la navigazione tra Ferrara e il mare, fu disalveato e diretto verso le terre basse e paludose di San Martino, tra Ferrara e Bologna, con l’idea che avrebbe colmato le valli e trovato una strada verso il mare. In realtà non trovava sbocco e nelle piene inondava i territori bolognesi, danneggiando proprietà di potenti famiglie come gli Aldrovandi e i Lambertini. Nel 1625, appoggiata da B. Castelli, Bologna aveva proposto di collegare con un canale il Reno al Po, mandando così le acque, che scolavano già con difficoltà nel grande fiume, in territorio ferrarese e venendo a minacciare i territori di Modena e Mantova. Ne nacque una disputa tra Bologna e altre città (in primo luogo Ferrara), alimentata anche da considerazioni teoriche sul moto delle acque.
I Bolognesi sostenevano che la velocità delle acque sarebbe aumentata notevolmente con l’altezza: prima linearmente (legge di Castelli), poi in ragione della radice quadrata dell’altezza (legge di Guglielmini). In tal modo non vi sarebbero stati pericoli in caso di piene del Po o del Reno. Tali leggi empiriche, rivelatesi poi false, poggiavano sul calcolo dell’efflusso dell’acqua da un foro in condizioni statiche (foronomia). Dal 1705 era soprintendente delle acque del Bolognese il fratello del M., Eustachio; nel 1716 per riesaminare la questione fu decisa un’ispezione guidata da mons. D. Riviera, cui parteciparono Grandi come matematico pontificio, C. Galiani, il M. (diventato segretario dell’Assunteria delle acque) e suo fratello Eustachio. Contro il progetto dei Bolognesi di immettere il Reno in Po nei pressi di Bondeno intervenne anche la Repubblica di Venezia, che temeva danni ai suoi territori e fece difendere i propri interessi da uno dei maggiori idraulici del Settecento, B. Zendrini. L’affare del Reno, divenuto così anche problema politico, impegnò le energie e le competenze del M. fino al termine dei suoi giorni. Di fronte alla forte opposizione all’immissione del Reno in Po egli provò a seguire un’altra strada, quella di un canale che dalle valli di San Martino lo facesse defluire verso il mare. Il canale, scavato nel 1742 durante il pontificato di Benedetto XIV, fu chiamato Cavo Benedettino. Il proposito, inizialmente nascosto, del M. e dei Bolognesi era quello di collegare poi il Benedettino al Reno a Sant’Agostino (Rotta Panfilia) con un altro canale, facendo quindi ritornare questo fiume nel Primaro, a Traghetto. Il progetto fu effettivamente realizzato nel 1773 sotto la guida di A. Lecchi, ma non risolse allora i problemi delle valli tra Argenta, Ferrara e Bologna. Il Reno occluse gradualmente il Po di Primaro, che fu privato di sbocchi, creando nuovi problemi anche ai fiumi appenninici (Sillaro, Savena, Santerno, Senio, Idice) che si immettevano nel Primaro. Tuttavia, con raddrizzamenti e con la costruzione di alti argini, botti, impianti di sollevamento, il corso del Reno è rimasto sostanzialmente quello disegnato dal M., che ottenne l’approvazione anche da P. Frisi. Sulla questione del Reno il M. pubblicò opuscoli polemici, in particolare contro il tecnico ferrarese R. Bertaglia, che si era presentato sotto il nome di Alberto Valdimagro (Alla sacra Congregazione delle acque per la città e per gl’interessi bolognesi contro la città di Ferrara. Considerazioni, Roma 1739; Voto sopra il parere de’ due periti di Bologna e di Ravenna circa l’arginare il Po di Primaro, Bologna 1759; Risposta al compendio delle pretese ragioni de’ Ferraresi, Roma 1760).
A fine Seicento la scuola galileiana era ancora ben impiantata nelle Università italiane. Stefano degli Angeli, allievo di B. Cavalieri, e Michelangelo Fardella, allievo di G.A. Borelli, insegnavano a Padova. Un altro allievo di Borelli, A. Marchetti, insegnava a Pisa, dove pure aveva studiato G. Ceva (con Donato Rossetti, anch’egli allievo di Borelli). La scuola, legata ai metodi della geometria greca, privilegiava l’interesse per le applicazioni della geometria alla meccanica, sebbene i nuovi metodi analitici, con l’affermazione del calcolo differenziale e della geometria cartesiana, sua premessa necessaria, richiedessero una revisione dei corsi di studi. Non senza difficoltà furono introdotti nell’Università di Bologna da Eustachio Manfredi e Stancari, a Pisa da Grandi e soprattutto a Padova, dove dal 1707 al 1713 insegnò matematica Jacob Hermann, allievo di Jacob Bernoulli, chiamato su interessamento diretto di Leibniz. Hermann ebbe allievi di eccezione, come G. Poleni, J. Riccati, B. Zendrini, A. Conti e A. Zeno.
A Bologna il M., nell’insegnamento universitario e in quelli tenuti presso l’Istituto delle scienze, fu per quasi mezzo secolo punto di riferimento per i cultori locali di matematica e per chi si recava a Bologna attratto dalla fama dell’antica Università e dell’Istituto o per formarsi in collegi della città, in primo luogo quello dei gesuiti, dove studiarono i figli di Jacopo Riccati: Vincenzo, Giordano e Francesco. Proprio in occasione dell’avvio agli studi di Vincenzo, nel 1717, Riccati incontrò a Bologna il M., iniziando con lui un’interessante corrispondenza scientifica nella quale per la prima volta la comunità matematica italiana, assimilati i metodi del calcolo differenziale, mostrò di saper tenere testa alle più vivaci comunità scientifiche europee. I più noti allievi bolognesi del M. furono F.M. Zanotti, S. Canterzani e A. Bonfioli Malvezzi, mentre tra gli esterni che fecero riferimento a lui ricordiamo V. Riccati, G.F. Malfatti, F. Algarotti.
Il M. morì a Bologna il 5 ott. 1761. Fu sepolto nella chiesa di S. Maria Maddalena, oggi in via Zamboni, nella tomba di famiglia. Aveva sposato Teresa Del Sole, della famiglia del pittore Giovan Giuseppe, dalla quale ebbe tre figli.(fonte)
[7] Giovanni Marchetti
Poeta e dantista, nato a Senigallia il 26 agosto 1790, morto a Bologna il 2 marzo 1852. Ebbe dal 1811 al 1814 onorevole ufficio a Parigi presso l’Aldini, ministro di stato per il regno d’Italia. Stabilitosi definitivamente a Bologna nell’agosto del 1814, partecipò moderatamente ai moti del 1831. Fu deputato per Senigallia al parlamento romano, e ministro di Pio IX per gli Affari esterni nel ministero del maggio 1848.
Aiutò Paolo Costa nel Commento della Commedia, pubblicato anonimo nel 1819, a cui premise il Discorso su la prima e principale allegoria del poema di Dante. Notevole anche il Cenno intorno allo stato presente della letteratura in Italia (1824). Maggior fama gli venne da buone liriche, da buone traduzioni, e soprattutto dalla vigorosa cantica Una notte di Dante (1838), che tiene il primo luogo dopo quelle dantesche del Monti. Vi è cantato Dante ospite, la notte del 2 maggio 1318, secondo una leggenda da molti creduta storia, nel monastero di Fonte Avellana sul Catria.(fonte)
[8] Giosuè Carducci
Nacque a Valdicastello, frazione di Pietrasanta nella Versilia lucchese, primogenito del dottor Michele e di Ildegonda Celli, il 27 luglio 1835 alle undici di sera. Gli furono imposti i nomi di Giosuè (che avrebbe poi preferito nella forma Giosue), Alessandro, Giuseppe: il primo perché il padre vi scorgeva un simbolo augurale, gli altri due in onore rispettivamente dell’avo materno e di quello paterno.
Nel 1836 il padre si trasferì con la famiglia da Valdicastello a Seravezza, poi al Fornetto presso il ponte di Stazzema, donde nel 1838 passò a Bolgheri nella Maremma pisana, avendovi ottenuto la condotta, e dove rimase fino al ’48.
Lasciava così questo ramo dei Carducci la Versilia, residenza della famiglia da oltre due secoli: la loro origine era fiorentina e fra gli antenati vantavano quel Francesco, penultimo gonfaloniere della Repubblica, “a cui i Medici fecero tagliar la testa su lo scalone del palazzo del Bargello, perché era il capo degli arrabbiati” (Ep., X, pp. 65 s.). La terra natia, per la tenera età in cui ne venne allontanato, lasciò solo qualche frammentaria immagine nella memoria del C., che in un capitolo dell’Intermezzo di rime la salutò come terra del non corrisposto amore, dalle cui donne (versiliese era la nonna paterna, Lucia Galleni, nonna Lucia di Davanti San Guido) aveva appreso la “maschia dolcezza” del suo “tosco accento”. Al contrario, quel tratto della Maremma degradante da Castagneto e Bolgheri al Tirreno fu non solo, per un decennio, l’ambiente congeniale alla sua fanciullezza impetuosa e ribelle, ma anche un costante mito sentimentale e fantastico dell’uomo e del poeta. L’immagine di quegli anni, attediati dal carattere dispotico e iroso del padre, ricchi di letture e di sogni più che di esperienze concrete, è affidata a molte pagine autobiografiche, dalla famosa apertura del saggio del 1873 A proposito di alcuni giudizi su A. Manzoni, alla lettera del 14 genn. 1877 ad A. De Gubernatis, cui vanno aggiunti i tanti squarci di confessioni e di ricordi che si incontrano nelle prose, perfino in quelle di carattere critico ed erudito, e più nell’epistolario.
La prima istruzione non fu né sistematica né regolare: studiò sotto la guida del padre e, per un breve periodo, di un prete, don Giuseppe Millanta, cui avrebbe alluso senza simpatia nelle Rimembranze di scuola. Pure da questo insegnamento gli derivò la buona conoscenza del latino: a dieci anni traduceva ad apertura di libro le Metamorfosi e sapeva scandirne i versi. Più che con le sue lezioni, il padre gli giovò con la “librerietta” che aveva adunato, “più che passabile per un medico di maremma”, ove accanto ai principali classici figuravano opere storiche (Rollin, Thiers, Sismondi) e si venivano aggiungendo i contemporanei Niccolini, Giusti, Guerrazzi. Il posto d’onore era del Manzoni.
Se i Doveri degli uomini del Pellico, la Morale cattolica e una Vita di s. Giuseppe Calasanzio rappresentarono la disciplina con cui il romantico padre tentava di smorzare i classici ardori e le monellerie del figlio, il C. ricercò i poemi e le storie con inesausta curiosità e vi si immerse con vero rapimento. Qualche incontro prematuro fu un episodio che non turbò quella foga: si getta sull’Inferno dantesco e non ne intende nulla; il Canzoniere del Petrarca gli sembra essere “un libretto d’aritmetica”. Il fervore gli trabocca in desiderio di partecipare ad altri le sue scoperte: nel 1845-46 a Castagneto (dove era stato inviato per curarsi le febbri maremmane) va in giro per le botteghe, leggendo agli artigiani le poesie del Giusti. Presto egli stesso tenta la poesia: “nel ’47, coi bagliori della primavera del risorgimento, cominciai a far versi anch’io”. Delle composizioni di quell’anno ci restano i titoli: In morte d’una civetta,La presa del castello di Bolgheri, Bruto che uccide Cesare,Il 10 agosto; metri adoperati: l’ottava, la terzina e, per uno di questi poemetti, tutti i versi che fino allora era riuscito a padroneggiare. Lo studio e l’incipiente passione letteraria assorbivano solo una parte della sua giornata: molto tempo trascorreva nella vita libera dei campi coi fratelli, coi compagni, coi butteri (amava condurre sull’alba all’abbeveratoio i cavalli) e più in solitudine.
La primavera del 1848 segnò bruscamente la fine di questa più o meno spensierata fanciullezza. Il 21 e il 23 maggio, nel cuore della notte, la casa dove i Carducci vivevano a Bolgheri fu fatta bersaglio di fucilate: un avvertimento al dottor Michele che sobillava i contadini con le sue idee rivoluzionarie. Da Bolgheri la famiglia dovette passare a Castagneto; da qui, restaurato il governo granducale nell’aprile del ’49, a Laiatico, nel Volterrano, e poco dopo a Firenze. Così il C. dalla libertà maremmana (negli ultimi tempi aveva partecipato ai tumulti rivoluzionari, dando mano con altri ragazzi ad innalzare l’albero della libertà e ad abbattere lo stemma dei signori del luogo, i della Gherardesca) passava alla disciplina degli scolopi, entrando il 15 maggio nelle scuole di S. Giovannino.
Ammesso, dato il buon livello della sua preparazione, ad “umanità”, fu alunno modello. A “retorica” ebbe come insegnante il padre G. Barsottini, manzoniano romantico pratiano, ma anche buon intenditore dei classici latini. Da lui mutuò l’amore per Orazio e per Fantoni, un poeta quest’ultimo che non poca parte avrebbe avuto nel suo noviziato artistico. Con alcuni compagni – Nencioni, Gargani, Lanzillotti – fondò l’Accademia dei Filomusi, di cui fu presidente e alla cui attività contribuì con due discorsi, Su lo stato attuale della letteratura italiana e Dell’Italia, letti rispettivamente in un giorno del maggio e del settembre 1852.Già in queste prime acerbe prese di posizione di fronte alle tendenze della cultura e del costume contemporanei si delineano motivi e spiriti di successive analisi e polemiche, e insieme si rivelano la forza e il limite del suo ingegno, il significato e il carattere della sua presenza storica.
Negli anni di S. Giovannino passa soltanto qualche vacanza presso i familiari, che si erano trasferiti a Celle, ai piedi del monte Amiata, avendovi il padre ottenuta la condotta nell’aprile del ’51. Ma anche a Celle ormai non tralascia più gli studi: con Ercole Scaramucci. un colto gentiluomo che morirà giovane di lì a poco, legge e rilegge Alfieri, Niccolini, Pellico, Monti, Metastasio.
Incoraggiato dal Barsottini e dallo stesso rettore, il canonico Ranieri Sbragia, il C. concorre alla Scuola normale superiore di Pisa. Vi entra nel novembre del ’53 e dopo tre anni ne esce laureato in filosofia e in filologia con inoltre il diploma di magistero.
Al Chiarini e al Donati raccontò in tono tra divertito e canzonatorio gli esami finali (Ep., I, pp. 173-175 e ss.): al di sotto dello scanzonato spirito goliardico si avverte una sostanziale dissonanza dal mondo e dagli ideali dei suoi maestri, altra volta giudicati severamente senza mezzi termini. Non si trattava solo della reazione di una mentalità volteriana al cattolicesimo formalistico e bigotto imperante nella Normale, ma anche della insoddisfazione di fronte all’angustia della cultura toscana contemporanea che si rifletteva nelle aule universitarie. La sua attività negli anni pisani è fervida ma non sempre obbedisce a libere scelte, perché fin dalla giovinezza egli fu condizionato dalle necessità economiche. Gliene derivò il senso di ulteriore importanza del lavoro e una serietà ignota a molti scrittori, ma anche la mancanza della gioiosa disinvoltura di chi attende a un’opera, fedele soltanto allo stimolo di intime occasioni. Lo aiutò liberalmente agli esordi Pietro Thouar, che seppe intravederne, sotto la scorza rude, la forza del carattere. Tradusse in prosa e commentò alcune odi oraziane, lavorò ad un’Antologia latina, compilò l’Arpa del popolo ossia Scelta di poesie religiose, morali e patriottiche cavate dai nostri autori e accomodate all’intelligenza del popolo, venendo a collaborare in tal modo, sotto il profilo letterario, al programma pedagogico del Thouar e del Lambruschini. Ininterrotta è la produzione poetica, che sembra piuttosto la testimonianza di un lungo tirocinio alla ricerca dello stile, che l’espressione, sia pure approssimativa ed incerta, di un temperamento lirica, già configurato. Con senso di consapevolezza critica il C. relegò alla sfera privata buona parte dei suoi primi versi, nei quali, dacché sono stati accolti nel primo volume dell’edizione nazionale, si è cercato il documento di una vigilia poetica e, alla luce dei successivi sviluppi, vi si sono individuati motivi e forme destinati a non esaurirsi appunto nel giro della loro stagione.
Nel 1856, col Chiarini, il Gargani, il Targioni-Tozzetti, il C. si unì a costituire un’avanguardia letteraria, che nel nome – “Amici pedanti” – e nel programma procedette baldanzosamente à rebours, proponendosi la lotta a favore del classicismo e della disciplina contro ogni arcadia sentimentale e ogni faciloneria formale gabbate per modernità e per arte.
Il primo intervento polemico del gruppo contro il romanticismo e la moda straniera, ritenuti causa di corruzione e di decadenza, trovò pretesto nella comparsa di un innocuo libretto di versi, Fiori e spine, del livornese Braccio Bracci. Estensore del pamphlet intitolato Diceria su i poeti odiernissimi (ribattezzato dagli avversari, con facile calembour, “su-diceria”) fu G. T. Gargani, intransigente classicista strocchiano, condiscepolo del C. fin dai banchi delle Scuole Pie. Alle molte e sgarbate reazioni dei giornalucoli letterari di Firenze legati alla consorteria di P. Fanfani (ma va pure ricordato che su alcuni particolari ebbero a muovere critiche e a mostrare risentimento A. D’Ancona e F. Martini), gli “Amici” risposero con una Giunta alla derrata, ove intervenne fra gli altri il C., assalendo i poeti moderni in quattro sonettesse e provando loro “storicamente e con l’autorità di Botta, Rosmini, Gioberti, Giordani, Goethe, Byron” che erano “prima immorali, poi anti-italiani, in ultimo meschinissimi”. Guardata a distanza tutta questa polemica appare chiusa in un cerchio angusto, non certo per l’ambiente ristretto in cui si svolse ma per la mancanza di profondi e originali motivi. Se mai, essa può essere significativa come documento di un gusto poetico in formazione, che si viene determinando proprio nell’opporsi e distinguersi da una moda corrente, di una personalità morale istintivamente avversa all’arbitrio dell’individuale e del soggettivo, che giunge a fare sue posizioni del Gioberti e del Rosmini non perché abbia un suo realismo gnoseologico o una sua ontologia da difendere contro l’idealismo germanico, ma perché crede di avere individuato in quella scuola – ed è segno di un forte limite – la causa lontana del capriccio e dell’arbitrio letterario, riflesso di una degenerazione più profonda.
Per l’anno scolastico 1856-57, con altri due colleghi della Normale, P. Luperini e F. Cristiani, il C. ottenne una cattedra nel ginnasio di San Miniato al Tedesco.
“Io insegnavo retorica (quarta e quinta), cioè facevo tradurre e spiegare a due ragazzi più Virgilio e Orazio, più Tacito e Dante che potessero; e buttavo fuor di finestra gli Inni Sacri del Manzoni”: così egli stesso in un passo dello scritto del 1883, Le “Risorse” di San Miniato al Tedesco e la prima edizione delle mie Rime, che di quell’annata dei cari inganni offre l’evocazione commossa e ridente. Per certe parole e certi atteggiamenti che apparvero blasfemi ai timorati e pericolosi in un educatore, per quella leggenda – come egli ebbe a scrivere – di “feroce misocristismo”, che le sue smargiasserie antimanzoniane gli avevano creato intorno, gli fu intentato un processo, che sarebbe potuto riuscirgli pericoloso: “Per fortuna – osservava anni dopo – che nel ’57 anche c’era in Toscana, pur all’ombra della cappamagna di Santo Stefano, del buon senso parecchio e della onestà”. Ma nella cattedra non fu confermato, né riuscì a ottenere l’insegnamento del greco ad Arezzo per l’anno scolastico ’57-’58.
Il 23 luglio 1857 per i tipi del Ristori d’Arezzo usciva il volumetto delle Rime di San Miniato, che recava la dedica alla memoria di G. Leopardi e di P. Giordani. Tali nomi posti in fronte ai suoi versi non erano segno di immodestia, ma di spirito polemico: volevano significare la fedeltà a un severo ideale d’arte e reagire a certi giudizi di ispirazione spiritualistica e romantica, contro i quali aveva già più volte reagito, proclamando, per esempio, il Giordani grandissimo come uomo, scrittore e filosofo.
Nella prefazione, che non fu pubblicata, fra molte cose ovvie in stile goffamente pretenzioso, veniva affermato – ed è il motivo più interessante che vi si poteva cogliere – il carattere di protesta di questa poesia, che, sdegnosa di allinearsi alle altre voci della poesia contemporanea, si chiudeva nel culto delle memorie e della gloriosa tradizione italiana. L’indomani dell’uscita del libro, il poeta, scrivendo all’amico Chiarini, proclamava la sua ferma fede negli ideali classici, il suo odio per il secoletto cristianeggiante, l’indifferenza a ogni plauso che celasse l’invito a convertirsi alla buona filosofia.
Le Rime non passarono sotto silenzio. Lodate, pur fra riserve, dal Guerrazzi, dal Tommaseo, dal Mamiani, furono annunziate e recensite da molte riviste toscane e anche da qualcuna non toscana. A Firenze, il cui giornalismo letterario anche in questo caso dette prova di spirito provinciale, si scatenò una polemica, nella quale si lasciò trascinare lo stesso C., il cui intervento, anzi che chiudere, accese di nuova vivacità il battibecco. Ma non negli interventi pubblici, dominati dalla reazione alle ironie e ai sarcasmi di cui era fatto oggetto, bensì in qualche lettera privata il poeta parla del suo lavoro con distacco critico, mostrandosi consapevole dei difetti del suo stile e disposto ad accogliere ogni suggerimento che non nascesse da prevenzione immotivata.
A richiamarlo bruscamente dalla letteratura alla vita è la morte del fratello Dante, che lascerà nel suo animo, col rimpianto, forse l’ombra di un dubbio. Si uccise con un ferro chirurgico del padre, o fu involontariamente ucciso dal padre al culmine di un alterco, la disgraziata sera del 4 novembre 1857 a Santa Maria a Monte? Il ricordo del fratello sarebbe diventato una delle presenze continue nel tema funerario che corre la sua poesia.
Alla morte del padre, nel 1858, il C. prese con sé il fratello minore e la madre, dalla quale non si sarebbe separato neppure sposandosi. Del resto la giovane Elvira Menicucci (Firenze 1835-Bologna 1915), alla quale era promesso e che fece sua moglie il 7 marzo dell’anno successivo, era figlia di primo letto di un sarto fiorentino, che in seconde nozze aveva sposato una sorella di Ildegonda Celli, la madre del C.: si trattava quindi di persone non estranee tra di loro.
Comincia così, anche sotto lo stimolo delle cresciute necessità economiche ma più per il progressivo determinarsi dei suoi interessi di artista e di studioso, un periodo di più intenso lavoro, che a poco a poco finisce per assorbire tutta la vita del C., la cui storia si viene identificando con la storia della sua opera e non perché quest’opera trascenda del tutto la biografia dell’uomo, ma perché questa biografia si assomma e si esalta in essa. Nell’autunno del ’57 entra in rapporto con l’editore Barbera, per il quale allestirà un’intera sezione della “Diamante”, l’elegante collezione di classici in piccolo formato: in soli tre anni, dal ’58 al ’60, usciranno da lui curati nel testo e corredati di ampie e dotte introduzioni storico-critiche i volumi dedicati alle Poesie liriche del Monti, La secchia rapita del Tassoni, le Satire e poesie minori dell’Alfieri, le Poesie del Giusti, Del principe e delle lettere e altre prose dell’Alfieri, le Poesie di Lorenzo de’ Medici, le Satire odi e lettere di Salvator Rosa, cui negli anni successivi si sarebbero aggiunti quelli delle Rime di Messer Cino da Pistoia e d’altri del secolo XIV (1862), il Lucrezio volgarizzato dal Marchetti (1864), le Versioni poetiche del Monti (1869), le Poesie di Gabriele Rossetti (1879).
L’esperienza erudita e filologica, che si veniva accumulando in questo lavoro come nelle più ampie e impegnative ricerche sui codici del Rinascimento e dell’antica lirica volgare, gli affinava anche il senso storico della lingua e gli chiariva, di contro a certi indirizzi formalistici e retorici, :il significato e la funzione della filologia. Il pregio maggiore del Tommaseo, individuava lucidamente nel 1857, è di essere stato “uno di quei rarissimi in Italia i quali riportarono la filologia e la critica da questione vilissima di rettorica a questione di morale di storia di filosofia” (Ep., I, p. 266). Inoltre nei testi antichi bisognerà distinguere quanto è “tesoro o magazzino o serbatoio di lingua” da ciò che è arte (Ep., II, p. 197): gli stupendi trecentisti sono venuti a uggia proprio per la mancanza di questa distinzione e perché su di essi si è esercitato il virtuosismo dei linguaioli e non l’utile esegesi dello storico. La fecondità di questa impostazione, che richiamava la filologia al suo ufficio di scienza storica, si potrà vedere dai risultati probi e concreti delle sue esegesi e delle sue analisi, ermeneutiche e non retoriche le une, stilistiche e non formalistiche le altre. Ma già agli esordi è chiaramente formulata questa impostazione, che non è solo il tracciato su cui condurre le sue ricerche, ma anche il fondamento delle sue polemiche contro certi indirizzi della cultura contemporanea.
Nel programma de Il Poliziano, annunziando che nella rivista si sarebbe discorso di filologia, e non solo greco-latina ma anche italiana, aggiungeva: “quella filologia intendiamo ch’è una cosa sola colla critica, e nello studio delle parole studia altra cosa dalle parole soltanto” (Opere, V, p. 262). Questo programma è del settembre 1858; il primo numero della rivista – complessivamente ne uscirono solo sei numeri – reca la data del gennaio successivo.
Nello scritto Diun migliore avviamento delle lettere italiane moderne al proprio fine, pubblicato nei fascicoli 1 e 2, il C. esponeva, fondandosi su un’articolata analisi storica, i propositi della nuova rivista, inquadrando la posizione sua e del gruppo di cui si faceva interprete fra le correnti della letteratura italiana dell’Ottocento, e presentandola come correttivo e armonica sintesi della unilateralità di ciascuna tendenza. Si delineava chiaramente in queste pagine, fra spunti e suggestioni di altri critici contemporanei, il programma culturale cui si sarebbe attenuto nella sua attività di studioso e di maestro, e che più tardi avrebbe compendiato nell’invito “innoviamo rinnovando”.
Ma nel 1859 il suo pensiero non era, e non poteva essere, assorbito soltanto in questioni letterarie. Gli avvenimenti politici e militari accendono la sua fantasia e la sua passione: li celebra in una serie di poesie – In Santa Croce, Gli Austriaci in Piemonte, A Giuseppe Garibaldi, Montebello, Palestro, Magenta, Modena e Bologna, Per le stragi di Perugia -che più tardi, nella disposizione definitiva della opera poetica, saranno riunite nel VI libro degli Juvenilia. Ma, nonostante la schiettezza del sentire, egli non riuscì a legare, come alla loro naturale espressione poetica, nessuno di quegli avvenimenti e di quei personaggi ai suoi versi, in cui stride, senza comporsi in armonia, il contrasto fra letterarietà e realismo espressivo, tessere culturali e grido del sentimento non trasceso. Il 27 aprile, giorno in cui la Toscana si dichiarò annessa al Piemonte, per le vie di Firenze fu distribuita la sua canzone A Vittorio Emanuele:si trattava di una stampa abusiva, anonima e con la falsa data di Torino. Qualche mese dopo, su invito di V. Salvagnoli, ministro dei Culti in Toscana, avrebbe celebrato questa importante tappa del processo di unificazione nazionale nelle agili strofette del Plebiscito (il cui titolo primitivo fu L’Annessione); e nel canto Alla croce di Savoia avrebbe versificato – a suo stesso dire – la storia dei due principi, popolano e monarchico, “congiunti nel fine di unire la patria” e “rappresentato il primo nella Toscana gloriosa a buon diritto della civiltà dei Comuni, il secondo nel Piemonte che ha ogni sua forza nella monarchia” (Ep., II, p. 21). Le giornate di Goito e di San Martino gli apparivano “prosecuzione delle battaglie di Legnano e di Gavinana” (ibid.). La fine improvvisa della guerra, sancita a Villafranca, spegne in lui ogni entusiasmo; e la delusione gli detta giudizi ingiusti: la rivoluzione del ’59 non è che uno “scatto politico operato dalla Francia” e la campagna bellica, cominciata e sostenuta dai Francesi discesi all’affranchissement d’Italie, “non è poi cosa che faccia molto onore al paese” (Ep., II, p. 37). L’arbitrio e il sopruso di certi funzionari piemontesi a Firenze gli suscitano il timore che queste forme di spicciolo malgoverno possano ridestare il municipalismo in animi semplici, portati a giudicare più dalla concretezza dei fatti che dalla generalità delle idee. La sua fede monarchica, infatti, non era espressione di una scelta in armonia con una particolare concezione dello Stato, meno che mai simpatia per il legittimismo della Restaurazione, che aveva ispirato la letteratura degli anni trenta: nasceva essa dalla lotta contro lo spirito municipale e dal convincimento che il progresso vero del popolo fosse nella direzione unitaria, verso cui si muoveva con possibilità di successo solo la monarchia piemontese. Ma ogni attesa di condizioni favorevoli al successo, ogni adattamento realistico alle circostanze gli sarebbero apparsi un tradimento. A inasprirlo ancor più è la condanna a non potere, legato dai doveri familiari, partecipare di persona alla guerra.
L’anno scolastico 1859-60 lo vede professore prima di greco e poi d’italiano e latino nel liceo Forteguerri di Pistoia, cittadina che gli rimarrà cara per le persone conosciutevi, fra cui la poetessa, inglese di nascita, Louisa Grace Bartolini, al cui volume di versi pubblicato postumo avrebbe premesso un suo scritto. Nell’estate del ’60, mentre cerca di ottenere il trasferimento a Firenze, onde continuare le ricerche sul Poliziano e sugli antichi poeti volgari che conduceva sui codici della Riccardiana, il ministro T. Mamiani con atto di felice lungimiranza offre a lui appena venticinquenne, e quasi del tutto sconosciuto fuori di Toscana la cattedra di eloquenza nell’università di Bologna, dopo che Giovanni Prati ne aveva declinato l’invito.
L’incarico era molto onorifico, ma non comportava, almeno per allora, una pesante responsabilità didattica, dato che la facoltà filologica bolognese non contava in quel momento nessun iscritto: i primi corsi del C. furono frequentati soltanto da qualche uditore. Ma molto serio fu fin dall’inizio l’impegno da lui posto nell’insegnamento, che non considerò mai un’attività secondaria rispetto agli studi e alle ricerche e da essi separabile. Il 22 novembre lesse, di fronte alle autorità e a una folla di curiosi, che, stando al suo resoconto semiserio, si sbracciò ad applaudire pur senza intendere molto, la sua prolusione: un rimpasto di cose già dette nell’articolo apparso nei primi due fascicoli del Poliziano. Vi esaminava lo svolgimento della nostra letteratura in relazione ai progressi delle istituzioni civili, secondo un metodo tipico della storiografia romantica, e in relazione ad alcuni fattori dal cui incontro sarebbe derivata la sua particolare configurazione, secondo uno schema meccanicistico che gli derivava dal Taine e che avrebbe reso famoso applicandolo più tardi nei Discorsi sullo svolgimento della letteratura nazionale elaborati fra il ’68 e il ’71.La città di Bologna lo impressiona favorevolmente fin dal primo incontro, perché “seria e senza lusso, perciò gentile veramente”; lamenta soltanto una certa indifferenza alla vita letteraria e la mancanza di un centro di incontri e di informazioni culturali che somigli, sia pure su scala ridotta, al gabinetto Vieusseux di Firenze; inoltre l’università gli appare inferma, spopolata com’è dalle piccole università dei vecchi ducati e delle Marche.
Un motivo di più profondo disagio traspare dalle lettere dei primi anni bolognesi: il fastidio per la sua condizione di “letterato con la recognizione superiore”, di venditore di “scampoli” e d'”oro falso”, di sottomesso a un giogo che gli vieta di levare il capo libero verso il sole.
Quando la critica riterrà di avere scoperto nella formula “poeta-professore” la chiave per l’intelligenza della poesia carducciana nelle sue opacità e nei suoi limiti, non avrà che irrigidito in un giudizio schematico un motivo psicologico ed esistenziale che è antefatto di quella poesia. Ma non solo la condizione di professore, con gli obblighi culturali che implicava, è sentita dal C. come un ostacolo alla poesia. Su di lui agivano anche suggestioni mazziniane, che lo portavano a considerare gli anni in cui si trovava a vivere come di transizione fra l’arte individualistica ormai defunta e l’arte sociale, che non riusciva ancora a profilarsi nella vecchia e pusillanime società europea: “Dopo gli ultimi grandi poeti, prefiche della vecchia filosofia, della vecchia aristocrazia, del vecchio individualismo, Goethe, Byron, Leopardi, non più poesia fino all’età nuova, di fede, di popolo, di libertà sociale”. A queste convinzioni altre se ne aggiungeranno più tardi di ascendenza vichiana e idealistica (ma attinte per via indiretta) convergenti nell’idea della morte dell’arte, che A. C. De Meis, suo collega nell’università di Bologna, bandiva come conclusione implicita nella dialettica hegeliana. In questi pensieri, come nella constatazione di una necessità storica, sembrava giustificarsi e placarsi la coscienza tormentosa di un personale limite, che nei momenti neri diveniva senso di fallimento.
In realtà la vita dei primi anni bolognesi, raccolta nella lettura e nello studio, gli permette di ampliare e raffinare la sua cultura, sia attraverso lo scavo sistematico dei più antichi secoli della letteratura italiana, sia attraverso l’attenzione alle letterature straniere, in primo luogo a quella francese, che avrebbe improntato e non lievemente la sua opera di poeta e di critico. Accanto a letture quasi impostegli dalla specializzazione – Ozanam, Fauriel, Villemain, Sainte-Beuve, Taine – si colloca il vivo interesse per ideologi, storici, politici – Voltaire, Michelet, Thierry, Guizot, Renan, Proudhon -; fra i poeti lo affascinano Heine e Hugo, cui pagherà ampio tributo di ammirazione e di imitazione.
Guardando più tardi al quinquennio ’61-’65, nello squarcio autobiografico Raccoglimenti premesso alle Rime del ’71, il “bagno freddo di filologia” e il “lenzuolo funerario dell’erudizione” gli appariranno la via attraverso cui era sfuggito al pericolo di impersonare “in Toscana il poeta laureato della opinione pubblica divenuta poi unitaria”, proseguendo in una rimeria politica astratta e convenzionale. Le letture, le ricerche, le riflessioni di questo periodo continuano ad essere dominate da due interessi distinti, la letteratura antica e il mondo contemporaneo: pertanto gli studi sul Medioevo e sul Rinascimento, su cui si concentrò a lungo quasi esclusivamente, gli apparivano ora un’incombenza faticosa, ora un rifugio da più inquietanti problemi, come un’evasione dal vivo del tempi e di se stesso, cui reagiva tuffandosi di nuovo nella poesia politica e nelle polemiche letterarie, cercandovi un contatto più rude e più sanguigno con la vita. Ma lo stacco fra i due interessi si andò colmando a mano a mano che il pensiero di un valore e di un significato che trascendessero i momenti del passato si venne affermando sul pensiero che quei momenti esaurissero in sé ogni valore e ogni significato, restando estranei alle esigenze e agli impegni della sua cultura militante. Allora Medioevo e Rinascimento gli apparvero non più e non solo due campi di ricerca erudita, ma due momenti di una dialettica ancora viva: i diritti sanciti dalla Rivoluzione francese, conquista fondamentale a suo avviso della storia moderna, gli svelavano i loro incunabuli nella civiltà umanistica, che segnava la fine del Medioevo feudale e teocratico con tutti gli abusi civili e le aberrazioni religiose. La cultura della Restaurazione, rinnegando i principi dell’Ottantanove, implicitamente respingeva quel processo di affrancamento iniziato alcuni secoli prima da quei dotti italiani che ai loro contemporanei erano apparsi chiusi in una innocente mania. Le idee di un certo Ottocento antiromantico e laicista investivano e ravvivavano le indagini erudite del C., trasformandole in visione storica, se non profonda e ricca di articolazione, piena di suggestione artistica e di pathos morale.
La linea del molto lavoro condotto nel decennio ’60-’70 va dalla ricostruzione erudita al quadro storico, sia pure senza la progressione decisa di un pensiero che apra nuove prospettive sul passato perché ha conquistato nuove verità teoriche: dalla memoria sul Savonarola e s. Caterina de’ Ricci (1861), all’edizione del Poliziano volgare, il frutto maggiore del suo impegno filologico, giovanile (1863), alla raccolta dei canti carnascialeschi (1864), alle indagini su s. Francesco, Brunetto Latini, Guido Cavalcanti, Matteo Frescobaldi, ai due ampi e fondamentali studi sulle rime e sulla fortuna di Dante, fino ai discorsi Dello svolgimento della letteratura nazionale (1868-71), che proprio nel maggiore impegno di interpretazione – quasi in alternativa alla prospettiva desanctisiana, ma pure su quella, come mostrò il Croce, in non pochi tratti modellata – rivelano più chiaramente le caratteristiche e i limiti del critico.
Intanto, sotto suggestioni culturali ma più sotto lo stimolo degli avvenimenti politici contemporanei e del dissidio di fronte alla condotta governativa, a suo avviso rinunciataria nei confronti delle questioni ancora sospese del Risorgimento (ed Aspromonte ne fu per lui un vergognoso segno), il C. abbandonò la sua giovanile adesione al programma di unità nazionale e di progresso democratico che aveva identificato tout–court con la monarchia piemontese, orientandosi verso forme sempre più radicali di giacobinismo e di populismo, manifestando, quasi a sfida e a rivalsa di una delusione, simpatie repubblicane. Questa svolta ebbe il suo riflesso nell’attività poetica, che dal 1862 si venne aprendo con maggiore insistenza alla tematica sociale e politica.
La prima, in effetti, non trovò esiti convincenti di poesia e fu destinata ad esaurirsi senza articolato sviluppo: Per raccolta in morte di ricca e bella signora, Il Carnevale, La plebe (incompiuta) mostrano come la denunzia delle disuguaglianze e delle ingiustizie, la contrapposizione di lusso e miseria, il ritratto della vita disumana del proletariato restino su un piano di trita convenzionalità letteraria, di cui è spia il linguaggio che procede tra magniloquenza vittorughiana e calchi manzoniani fino all’involontaria caricatura. Il C. non fu un poeta socialista: non sentì la lotta di classe come momento dialettico della storia, né fece suo il principio della fratellanza di tutti gli uomini nell’amore. Il tema politico, invece, rappresentò una delle costanti della sua poesia: varie furono le sue matrici passionali e culturali, le sue articolazioni, le sue finalità polemiche, come varia fu la sua realizzazione sul piano estetico. Il suo culmine sarebbe dato dalla poesia giambica, che avrebbe il suo incipit e il suo explicit nel ’67 e nel ’79: ma in realtà non si tratta di una fase della poesia carducciana che nasca e si esaurisca in un determinato arco di tempo, perché i prodromi risalgono al noviziato letterario e testimonianze se ne possono cogliere fin nell’estrema attività del poeta. Del resto il diagramma che collocava, dopo un periodo di iniziale sperimentalismo aperto in varie direzioni tematiche e stilistiche, la poesia impegnata nella polemica politica e di costume, alla quale sarebbe succeduta la stagione del classicismo ellenizzante con la serenità dei suoi miti, non rispecchiava la cronologia dei singoli componimenti ma quella artificiosa delle raccolte definitive. Su tale equivoco si basava lo schema di sviluppo dell’arte carducciana, che, nella sua fase matura, sarebbe partita da una poesia di impegno sociale, polemicamente simboleggiata nelle Grazie petroliere, per approdare a una poesia lavorata come una tazza – greca: in realtà si tratta soltanto del prevalere in un certo periodo dell’una o dell’altra tendenza, che si scontrano, si fondono, si avvicendano – talora nell’interno di uno stesso componimento – in una dialettica umana ed artistica che accompagna quasi tutta l’attività del poeta ed in sostanza è priva di vera storia.
La più aspra e lunga polemica politica del C. riguarda Roma capitale. Prima ancora dell’episodio di Aspromonte comincia il suo risentimento contro moderati e neoguelfi, di cui è testimonianza il giudizio sdegnoso contro le tesi che il d’Azeglio, “il marchesino romanziere”, aveva sostenuto nel suo libro del ’59 La politique et le droit chrétien au point de vue de la question italienne.E di fronte alle dimostrazioni toscane dei primi del ’62, sobillate dal Ricasoli, allo spettacolo della “sozza e laida e brutta plebaglia” scesa in piazza al grido di “viva il Papa!” pensa alla enormità di questo grido “dopo Alfieri, Giordani e Leopardi” e si convince che a Roma non ci si andrà se non con la rivoluzione, “la quale rompa colla scure del boia la falsa cattedra di San Pietro” (Ep., III, p. 34).
La passionalità certamente gli impediva di comprendere la cautela dei politici e i disegni a lungo termine: le sue prese di posizione, i suoi sarcasmi, le sue scomuniche interpreteranno il pensiero e lo stato d’animo della Sinistra garibaldina e repubblicana, ma la loro genesi, se trova consonanza e stimolo nell’atteggiamento di un partito, in realtà affonda le radici nel laicismo anticristiano e di questa ideologia si alimenta. Non si tratta, dunque, di un pensiero scelto a giustificare la presa di posizione ostile nei confronti del dominio temporale, bensì di convinzioni preesistenti all’occasionalità della polemica e in essa confluite ad allargare a contrasto ideale, a scontro di opposte concezioni della vita, quel contingente conflitto di potere.
La convenzione di settembre, anche se procrastinava sine die il compimento dell’unità italiana con Roma capitale, apparve al C. positiva almeno perché immergeva il governo nella più stimolante “atmosfera democratica” di Firenze: ma egli non risparmiò il sarcasmo alla turba delle tante eccellenze, piovute a profanare con la loro nullità una città sacra per gloriose memorie (e non fu la sua unica frecciata contro i rappresentanti del regime parlamentare). A rinfocolare il suo spirito anticlericale e accendere il più violento estro giambico venne il 1867 con Villa Glori e Mentana. L’arioso e festivo saluto Agli amici della Valle tiberina (nell’agosto del ’67 era stato ospite dei Corazzini a Pieve Santo Stefano) era corso come dal presagio dell’imminente crollo del potere temporale; ma quel piglio esultante, che si manifestava anche nella fantasia beffarda della chiusa, si sarebbe presto mutato nell’amarezza e nell’ira, che costituiscono il registro dei tre famosi epodi antipapali Per Eduardo Corazzini, Per Giuseppe Monti e Gaetano Tognetti, In morte di Giovanni Cairoli.
Pio IX vi era bollato “Polifemo cristiano”, “chierico sanguinoso e imbelle re”, “pontefice fosco del mistero”, cui il poeta contrapponeva se stesso, investito di una nuova missione sacerdotale, quella in favore della verità e del progresso civile, riproponendo così in chiave vittorughiana il mito della sacralità della poesia, caro al Foscolo e al Mazzini. La violenza verbale non nasconde più lo sfogo impotente, perché le parole non sono più sentite come espressione di un risentimento individuale ma come veicolo di una coralità di pensieri e propositi: “Savi, guerrier, poeti ed operai / Tutti ci diam la mano”; e al senso triste della prevaricazione e della violenza, che offende la dignità e la libertà dei popoli, si viene opponendo la fede in un’inesorabile giustizia storica: “Nemesi al suo ferreo registro / Guarda con muto orrore”.
La fine del dominio temporale non avrebbe spento “il dispetto e l’ira e il sogghigno” del poeta contro il governo italiano, che, ottenuta Roma più con un abile machiavellismo che con una ferma lotta a viso aperto, vi si trasferiva quasi alla chetichella, timoroso di provocare oltre la suscettibilità clericale (Canto dell’Italia che va in Campidoglio), e insediatovisi si intricava in giochi di combinazioni parlamentari e in una politica accomodante e meschina. Anche qui il poeta si faceva interprete della intransigenza radicale, che avrebbe voluto un più deciso ghibellinismo, e laicismo, ignorando l’opportunità, avvertita da certi settori liberali, di non approfondire fratture ideologiche nella nazione recentemente costituita.
La polemica contro Pio IX e i vari governi – Rattazzi, Ricasoli, Menabrea, Lanza – sotto cui fu affrontata e risolta la complessa questione romana svela più compiutamente il suo sottofondo ideologico se vista in controluce all’atteggiamento che il C. ebbe nel confronti della politica e della cultura francesi. Egli avversò Napoleone III, garante del potere temporale, e tutta la pubblicistica legittimista e reazionaria, avvertendo un profondo stacco tra la Francia del Secondo Impero e quella dell’Illuminismo e della Rivoluzione. La cultura francese che sentiva congeniale era quella di contestazione e di opposizione. I giambi Per il LXXVIII anniversario della proclamazione della repubblica francese (1870) e Versaglia (1871) hanno la loro genesi negli avvenimenti della guerra franco-prussiana e nel timore che l’incipiente Terza Repubblica, lacerata dallo scontro tra Comune e Assemblea nazionale, non sapesse liberarsi da nostalgie reazionarie e borboniche. Il Secondo Impero, nato da un colpo di Stato, era finito con la vergognosa giornata di Sedan; la Prima Repubblica, proclamata all’indomani della vittoria di Valmy, aveva il suo fondamento sul sangue fraterno sparso per il trionfo di principi più giusti. A questo tributo richiesto dalla dura necessità della storia contrapponeva il poeta l’assolutismo regio con le sue vergogne e le sue nefandezze, l’ipocrita unione di trono ed altare, cui avevano posto fine Kant e Robespierre, decapitando l’uno Iddio l’altro il re. Di un simile modo d’intendere il frutto del terrore e del criticismo (quanto è detto di Kant è un calco dalla Germania di Heine) si è discussa piuttosto la forzatura che la centralità nella visione storica del C., fondamento e insieme proiezione del suo laicismo.
Il laicismo non fu o non fu soltanto un carattere del mondo etico del C. e del suo impegno civile, o un motivo di occasionale riflessione, ma una costante della sua attività letteraria, un elemento di coesione del suo mondo artistico ed umano. Per questa ragione l’inno A Satana, composto di getto in una notte del settembre 1863 e recitato giorni dopo in un simposio di amici, potrà pure ritenersi di scarso o nessun valore sul piano estetico e su quello concettuale, ma dovrà collocarsi in un posto significativo nella storia dei primordi e, sia pure, dei precedenti della poesia carducciana, come il primo e in un certo senso fondamentale manifesto della sua formazione ideologica, la summa confusa e approssimativa di principî, approfonditi e meglio coordinati in seguito, ma non mai respinti.
L’esame comparativo delle fonti (Heine, Elementargeister zur Geschichte der Religion und Philosophie;Quinet, Ahasvérus e Le christianisme et la Rétolution française; Proudhon, De la justice dans la Révolution et dans l’Eglise; e, più importante per puntuali vicinanze, La Sorcière di Michelet, ove tra l’altro è detto che il tempio di Satana poggia su tre pilastri eterni: la Ragione, il Diritto, la Natura) potrebbe indurre a restringere di molto o a negare l’originalità concettuale dell’inno, che d’altra parte non è certo un modello di compattezza logica o di organica dialettica. Né la validità potrebbe rivendicarsi sul piano dei valori espressivi: la facilità ovvia del linguaggio, la monotonia della linea melodica nella sua esteriore cantabilità sono difetti sostanziali, di cui si rese conto lo stesso poeta e non solo a distanza di tempo. Ma nella storia della poesia carducciana questa pagina non era un episodio destinato ad esaurirsi in se stesso, perché dava al poeta, insieme al fastidio di una certa trivialità non evitata e di una popolarità basata su un fondamentale equivoco, la consapevolezza che l’arte potesse farsi strumento delle sue convinzioni di uomo e di studioso, saldando in un organico impegno i suoi vari interessi e le sue varie tendenze: di qui quel tono sicuro, quella giovanile spavalderia nello sciorinare gli articoli del credo appena conquistato, e non importa se attraverso uno scavo originale o investendo della propria esperienza e della propria passione pensieri altrui. Ed era naturale che volgendo lo sguardo sul cammino fin allora percorso gli si svelasse una coerenza inalterata negli spiriti e negli intenti della sua opera, e potesse contrapporre il verso degli esordi “il secoletto vil che cristianeggia” alla censura di oscillazioni, e mutamenti rispetto alle. posizioni di una volta. L’assommare nella figura dell’angelo ribelle “tutto ciò che di nobile e bello e grande hanno scomunicato i preti con la formula Vade retro Satana” (Ep., III, p. 378) non rappresentava una ripresa fuori stagione del vecchio titanismo romantico, che si sarebbe poi reincarnato in forme e spiriti decadenti: era il proporre in un emblema dall’indubbio significato provocatorio una concezione della storia moderna come processo di recupero del naturalismo ellenico e di rifiuto del cristianesimo come religione di mortificazione e di rinunzia, e come instrumentum regni della Chiesa di Roma. Accompagnando con una lettera l’invio dei versi al Atchelet, il C. li presentava come segno che anche nella vecchia Italia vi fossero spiriti giovani, aborrenti “dalla tetra schiavitù del cattolicismo” (Ep., IV, pp. 274-275); e nelle Polemiche sataniche, difendendo l’inno dagli attacchi che gli erano stati mossi, sottolineava la pars construens sottesa e affiancata al momento eversivo: “A me pareva, e pare, di aver inneggiato da principio la natura nel senso cosmico; mi pareva, e mi pare, di aver proseguito inneggiando la incarnazione più bella ed estetica della natura nell’umanesimo divino della Grecia; mi pareva, e mi pare, di aver finalmente cantato la natura sempre e l’umanità ribelli necessariamente nei tempi cristiani all’oppressura del principio di autorità dogmatico congiunto al feudale e dinastico”.
L’editio princeps è del 1865: recava sul frontespizio lo pseudonimo di Enotrio Romano, adoperato qui dal poeta per la prima volta; fu ripubblicato (oltre varie stampe abusive) nel 1869 da Il Popolo di Bologna in occasione dell’apertura del concilio vaticano, riaccendendo le non mai sopite polemiche, che non furono solo di cattolici e clericali. Significativo il giudizio negativo di Q. Filopanti, mazziniano e deista, che vi scorgeva “un’orgia intellettuale” antidemocratica nella forma, che per la sua dotta tessitura non sarebbe mai stata intesa dal popolo, e più nella sostanza, “poiché si tradisce, non si giova il popolo divinizzando il principio del male”. Questo contrasto, al di là della incidenza delle censure e della ragionevolezza delle risposte, rivela la frattura fra un laicismo che ha la sua base in un più o meno aperto e consapevole materialismo, e un laicismo spiritualista, permeato di un senso ancora trascendente dell’assoluto. Da quest’ultimo il C. fu sostanzialmente lontano. Lo mostra anche la polemica che nel 1866 condusse nell’interno della massoneria contro la corrente di rito scozzese, ove a suo avviso i canoni teocratici prevalevano sullo spirito di libertà, eguaglianza, fratellanza: la lotta lo vide soccombente, perché il gran maestro L. Frapolli lo estromise dalla loggia Felsinea assieme ai fratelli G. Ceneri, F. Magni, C. De Meis, F. Fiorentino e altri.
Le prese di posizione pubbliche, i legami che venne stringendo con uomini e circoli radicali e democratici, le idee estremiste e rivoluzionarie che in certi periodi si compiacque di ostentare, lo portarono nei rapporti con le autorità governative a momenti di tensione e di scontro, da cui uscì quasi sempre indenne. Nel 1864, per avere preso parte a un comizio guerrazziano, è accusato di essere repubblicano e di avere parlato violentemente contro il re: il ministero dell’Istruzione raccoglie l’insinuazione di alcuni giornali e minaccia di destituirlo dall’insegnamento, finché a suo favore non interviene lo stesso ministro, M. Amari, che del suo ingegno faceva gran conto. Più burrascosa la vicenda dell’autunno ’67, i mesi caldi dell’arresto di Garibaldi e degli sfortunati tentativi di Villa Glori e Mentana, quando l’Italia di Menabrea più sembrava agli occhi del poeta tradire gli ideali della generazione del ’48 ed egli, acceso di spiriti giacobini, cercava più concreto impegno di lotta politica. La sua poesia giambica, la collaborazione alla attività dell’Unione democratica del cui direttivo era membro, la lotta contro la candidatura del Minghetti gli valsero il trasferimento, chiara rivalsa e punizione, dalla cattedra di italiano di Bologna a quella di latino nell’università di Napoli. Del provvedimento del ministro Broglio egli contestò la legittimità e la serietà: non si poteva spostare un docente da una disciplina ad un’altra, né un dispositivo burocratico avrebbe avuto la virtù taumaturgica di creare in un tratto una specializzazione scientifica. Tale reazione ebbe come conseguenza l’abrogazione del provvedimento anche se il C. fu costretto a dimettersi dall’Unione democratica.
Dopo pochi mesi ebbe un nuovo scontro col ministero, che questa volta nominò una commissione d’inchiesta formata dagli onorevoli Spaventa, Brioschi e Messedaglia: risultato, la sospensione dall’insegnamento e dallo stipendio per due mesi e mezzo, inflitta a lui e ai suoi colleghi G. Ceneri e P. Piazza. Motivo della indagine e della punizione era stato il discorso commemorativo della Repubblica romana, pronunziato il 9 febbr. 1868 in una riunione conviviale, e l’indirizzo al Mazzini da lui e dagli amici sottoscritto in quella circostanza e pubblicato due giorni dopo dal bolognese Amico del popolo. Che il discorso e l’indirizzo volessero esprimere l’aspirazione a un ritorno di quella Repubblica egli negò, ma dichiarando allo stesso tempo di non essere pentito del gesto, perché la Repubblica romana del ’49 voleva dire “decadenza del potere temporale legalmente deliberata e proclamata dai rappresentanti legali del popolo” e inoltre “resistenza magnanima, onorata, solenne, alla prepotenza straniera”. L’impegno politico di questi anni si concluse con la sua candidatura alle elezioni amministrative dell’estate del ’69: eletto il 25 luglio nella lista del Comitato “Galvani”, nel Consiglio comunale condusse alcune battaglie a favore dell’istruzione laicista, come quella per l’abolizione dell’insegnamento di storia sacra.
La vita familiare nel primo decennio bolognese trascorse per lo più serena, senza scosse. Alla prima figlia Beatrice, nata a Firenze sul finire del ’59, era seguita nel 1863 Laura, cui si sarebbe aggiunta nel ’72 Libertà, la Tittì di Davanti San Guido.Le figlie si formarono ognuna una sua famiglia; Beatrice sposando nel 1880 Carlo Bevilacqua, professore di matematica nei licei; Laura nel 1887 Giulio Gnaccarini, impiegato nelle ferrovie (aiutò il suocero a riordinare le carte e la biblioteca, e a sbrigare la corrispondenza); Libertà nel 1889 Francesco Masi, professore di meccanica alla scuola di applicazione degli ingegneri. Triste il destino dei maschi: il primo, Francesco, vide la luce il 21 marzo del ’75 e morì immediatamente dopo, senza aprire profonde lacerazioni nell’animo del padre (o almeno di esse non è traccia nei suoi scritti); il secondo, Dante, visse poco più di tre anni (21 giugno 1867-9 nov. 1870), lasciando nella casa un vuoto pari alla gioia portatavi con la sua vitalità erompente. Questa memoria dolorosa sarebbe stata accolta nella malinconica serenità della poesia, sia fissandosi in un contrasto emblematico luce-oscurità, gelo-calore, sui moduli di un elegiaco greco (Pianto antico), sia congiungendosi ad un altro ricordo di morte (Funere mersit acerbo), sia placandosi in una visione onirica di bellezza e di sole (Sogno d’estate). Agli inizi del 1870 era morta la madre: due lutti chiudevano così un periodo di vita raccolto nell’insegnamento e negli studi, la cui storia è principalmente storia di una formazione intellettuale e si identifica con l’opera che si veniva realizzando.
Nel 1868 uscivano a Pistoia, stampati dalla tipografia Nicolai e Quarteroni, i Levia Gravia di Enotrio Romano (il volume era diviso in quattro libri e comprendeva settantasei componimenti, dei quali nell’ordinamento definitivo di tutte le poesie solo sedici sarebbero stati assegnati all’omonima sezione, mentre tre sarebbero passati alle Rime Nuove e i rimanenti, cioè la maggior parte, agli Juvenilia).Nel ’71 dall’editore Barbera di Firenze furono pubblicate, questa volta non più sotto pseudonimo, le Poesie, divise in tre parti – Decennalia, Levia Gravia, Juvenilia: la prima, in due libri, comprendeva liriche di ispirazione politica composte fra il ’60 e il ’70 (in seguito il libro primo sarebbe confluito quasi tutto in Levia Gravia, il secondo nei Giambi ed Epodi); la seconda, in quattro libri, corrispondeva solo parzialmente alla raccolta del ’68; la terza, in tre libri, di questa precedente raccolta era una sezione con in più qualche altra poesia già apparsa nelle Rime di San Miniato.
Questo continuo spostamento nell’ordine interno di ciascuna silloge poetica da edizione a edizione e il trasferimento di poesie dall’una all’altra silloge rivelano una ricerca puntigliosa e inquieta di organicità strutturale, stimolata sia dalla consapevolezza che la propria attività creativa si muoveva su alcune linee fondamentali, sia dall’ossequio a un canone di armonia e di equilibrio: l’aggruppamento cronologico sarebbe stato in fondo il più corrivo all’elemento spontaneo e occasionale dell’arte, che era bandito dal suo codice estetico. A tale vicenda si aggiungeva la continua e varia revisione dei testi, specie di quelli giovanili, sicché una storia della sua poesia che voglia scandirne il processo stilistico dovrà individuare le direttrici e i momenti delle successive elaborazioni.
Il maggior successo incontrato dal volume delle Poesie rispetto ai Levia Gravia, il fervore di attività poetica, che si articola nel ’71 alternativamente nei momenti della più concitata vena giambica (Per Vincenzo Caldesi, Feste ed oblii, Io triumphe, A certi censori, ecc.) e nei momenti in cui nell’eleganza del verso si compone il dolore individuale, il rimpianto di quel che il tempo rapisce di fronte all’immobile volto della natura (Maggiolata, Pianto antico, Rimembranze di scuola e inoltre certe traduzioni da Heine e Platen), non gli cancellano dall’animo il senso tormentoso di una sconfitta in rapporto all’ideale alto e severo che ha dell’arte: “io non sono altro che un povero sciagurato, mi arrampico su per il monte dietro certi bagliori che probabilmente son meteore e fuochi fatui; mi sento rotolare dietro gli anni della gioventù; m’insanguino le mani negli spini; e il mio verso ha del gemito e del sospiro affannato di chi affatica e forte dispera” (Ep., VII, p. 23). Non si tratta della rêverie di un’ora sghemba, ma di un motivo che affiora spesso nelle confessioni del poeta ed è il segno di quella scissione romantica fra reale e ideale, di quella ricerca di armonia e di unità spirituale avvertite perdute dall’uomo moderno e proiettate nel naturalismo della civiltà precristiana di Grecia e di Roma. è questa un’altra fonte di oscillazioni e di dissidio tra l’esigenza di una poesia impegnata nelle lotte politiche e civili e quella di una poesia pura obbediente soltanto alle leggi della bellezza. Intorno al ’70 egli venne traducendo la scelta a favore della disciplina stilistica, che era stata per lui fin dai primordi uno dei punti di frizione nei confronti della scuola romantica, in poetica della forma, polemicamente volta contro l’immagine da lui stesso accreditata del poeta barricadiero: “Enotrio Romano non è che artista; non vate, non precursore, non bardo e per nessuna cosa al mondo poeta civile” (Ep., VI, p. 58). E proclamava suo ideale artistico la lirica greco-latina, che già avevano tentato di condurre ai modi italici i poeti del Seicento e del Settecento e che egli avrebbe reso meglio di un Fantoni o di un Cerretti, avendo temprato il suo stile alla lezione di Dante e del Petrarca.
Ma l’accentuazione polemica della scoperta di una nuova zona di poesia realizzante le attese radicate nel suo spirito fin dalla giovinezza, che ora gli apparivano deviate da circostanze in definitiva esterne verso la diatriba contro certi modi d’essere della società contemporanea, non può assumersi a segno di contrapposizione di due irrelati mondi artistici ed umani. L’obliarsi nella visione serena dell’Ellade non rappresentava lo stacco dalla poesia giambica, non solo per l’alternarsi già notato dei due momenti in uno stesso arco cronologico, ma anche per la carica polemica implicita in quella particolare celebrazione dell’antichità, che s’innalzava sulla coscienza di una frattura aperta dal cristianesimo nell’anima moderna e di una decadenza fatale del senso eroico della vita. Il mito neoclassico di una Grecia apollinea, la cui fisionomia spirituale si sarebbe esaltata nella statuaria fidiaca e prassitelica, veniva ripreso, ma non in un semplice gioco letterario, perché nuovi pensieri e nuove condizioni storiche caratterizzavano questo revival culturale e poetico. Al senso di una infelicità propria della coscienza moderna (ma privo di quelle risonanze interiori che aveva avuto in spiriti tormentati dal demone metafisico) si aggiungeva quello del peso di frustrazioni stratificate nel corso di una secolare schiavitù religiosa e politica, quindi l’immaginaria Ellade serena si presentava ancora e più come rifugio ideale, mito particolare nel più vasto mito romantico dell’evasione. Ma non solo. La vitalità, che poteva irridere e flagellare il mondo ma non rifiutarlo, la fede in un progresso che fosse anche recupero delle fondamentali conquiste del passato, portavano il C. a credere realizzabile un ritorno, nello spirito laico della cultura contemporanea e nello slancio scientifico di cui gli appariva frutto la civiltà industriale, al naturalismo antico, a una religiosità tutta terrestre dell’uomo e delle sue opere.
Questo messaggio caratterizzava il fondo del suo classicismo, che però non sempre era penetrato da un simile impegno ideologico: non di rado, infatti, la sua poesia puntava al gioco d’intarsio, al cammeo lavorato con eleganza preziosa. Ma anche in questo caso l’esclusione voluta del momento sentimentale non significava certo la conquista di un superiore distacco dell’artefice di fronte all’opera: ed è proprio il desiderio sofferto di serenità e armonia che diversifica la sua poesia sia da un classicismo di tipo goethiano sia dalla distaccata freddezza parnassiana e la rende qualcosa di altro che un artificioso fiore di serra. Del resto egli non possedeva l’alto dono di immergere nella luce ferma del mito la realtà presente, di essere istintivamente classico, cioè moderno e antico allo stesso tempo senza coscienza di divario; né sullo sfondo dei suoi fantasmi di bellezza serena si profila l’aristocratico scenario che aveva avvolto la poesia tra la fine del Settecento e gli inizi del nuovo secolo, quando tutte le arti, e fin gli arredamenti e le acconciature, in quel clima di fasto imperiale, erano improntati a un unico gusto. Ora nel mondo borghese del secondo Ottocento certe evocazioni antiche avrebbero avuto un sapore di archeologia letteraria, ove non fossero state percorse da una nostalgia che il sogno avvertiva come sogno, sicché potevano coesistere, senza stridenti disarmonie, plastiche raffigurazioni di ninfe e nervose figure di donna, come quella della chiesa lombarda che sembra uscire da un quadro di Boldini (Era un giorno di festa).
Quasi a stabilire corrispondenze fra la vita e l’arte si suol porre la nuova e più felice stagione della poesia carducciana sotto il segno dell’amore per Lina o Lidia, come fu chiamata nei versi e nelle lettere del poeta la signora Carolina Cristofori Piva. Mantovana di nascita e milanese di educazione, ma costretta a trasferirsi da una città all’altra per seguire il marito che era colonnello dell’esercito, ella aveva già tre figli e contava ventisei anni nel 1871, quando per civetteria e vanità, coperte dalla scaltra intelligenza e dalla buona cultura, entrò nella vita del Carducci. Ne nacque una passione tormentosa ed esaltante, nelle cui maglie anche la donna fu presa, benché a tratti e non al punto di sacrificarvi altri amori. Di qui i contrasti e le recriminazioni, che occupano non poco spazio nelle lettere del poeta (le sole che ci siano giunte), a cui la gelosia spesso dettava pagine crudeli, a volta veri urli di belva ferita, a volte stillanti sarcasmo contro la donna per le sue indifferenze e i suoi tradimenti, o contro chi gli apparisse reo di goderne i favori, Bonghi, Panzacchi, Verga per esempio. Certe ore ostili esasperavano l’acre gusto di distruggere quanto di bello e di nobile pur v’era in questo amore, finché l’ira cedeva alla malinconia, lo scatto aggressivo al bisogno di comprensione e di tenerezza.
Ma non solo perché specchio e documento della vicenda biografica questa sezione dell’epistolario carducciano ha un suo interesse e un suo fascino: che anzi proprio nei momenti più legati all’urgenza della passione rivela le sue opacità e i suoi scadimenti. Lina sapeva esaltare e magari esasperare i sensi e i pensieri dell’uomo, ma anche stimolarne il desiderio, represso in una lunga solitudine, di più sereni abbandoni, di confessioni, di colloqui, che lo aiutassero a vedere più chiaro nella propria anima e nella propria vita. La storia di questo rapporto era già in nuce nelle convergenze e nelle divergenze di carattere dei due protagonisti, che nella loro apparente sicurezza dissimulavano una fragilità interiore: da un lato un uomo rude, schietto, incapace delle disinvolture e dei sofismi che si affinano nella consuetudine col mondo, in fondo scontento di sé e della parte che si vedeva costretto a rappresentare, reso più solo da lutti recenti e dalla incomprensione di persone vicine, estranee ai suoi crucci segreti; dall’altro una donna dalla sensibilità e sensualità esasperate forse dalla malattia latente che l’avrebbe condotta ancor giovane alla tomba (morì a Bologna nel 1881), con un gusto aristocratico dell’arte e non senza ambizioni o velleità letterarie, che reagiva a una mediocre esistenza borghese, trascinata nel tedio di cittadine di provincia tra le angustie familiari e il peso di molte maternità, cercando più intense esperienze e finendo per collezionare amanti celebri.
Lina scrisse per la prima volta al C. nel luglio del ’71; i due si incontrarono poi nell’aprile successivo. La seconda delle Primavere elleniche, la dorica, fu la raffinata e artificiosa dichiarazione d’amore; la terza, la alessandrina, fu ispirata dalla visita che di lì a poco il poeta fece con l’amante all’antico cimitero milanese di San Gregorio fuori Porta Orientale, presso l’antico lazzaretto. Gli incontri con Lina, a Milano a Modena a Rovigo a Civitavecchia, le gite con lei nel parco di Monza, sull’Adda, alle grotte di Catullo, al castello di Miramare interrompevano le lunghe separazioni che acuivano il desiderio fino allo spasimo. A questi giorni con il loro cumulo di sensazioni e il loro groviglio di sentimenti, che la lontananza poi decantava, alle cose viste, ai luoghi scoperti e, d’altro canto, all’attenzione nuova rivolta alla propria vita intima e al cerchio delle esperienze quotidiane si lega la genesi occasionale di alcune fra le più suggestive “barbare” – Su l’Adda, In una chiesa gotica, Fantasia, Ruit hora, Alla stazione in una mattina d’autunno, Sirmione – e di alcuni squarci epistolari che ad esse vanno affiancati, o per l’autonomo fascino che realizzano, o perché di quelle liriche sono il preannunzio e dei loro motivi un’altra diversa formulazione. In Lina al C. pareva di scorgere la incarnazione del suo ideale ellenico e pagano della vita, di quell’armonia che il mondo presente avrebbe potuto riconquistare solo superando, nella riscoperta unità della natura, il dualismo fra spirito e materia, radicato nella coscienza dai lunghi secoli del predominio cristiano. Il quale, inoltre, avrebbe distrutto il senso plastico della bellezza per un’arte di astrazioni e di simboli, sostituendo alle divinità elleniche, che la statuaria aveva fissato nella loro naturalità splendente, il concetto di un assoluto infinito e quindi, secondo un punto di vista proprio degli antichi, indeterminato e imperfetto. Così disposando le istanze del gusto neoclassico, secondo cui anche la fantasia del poeta non può creare che dando vita a valori plastici (era il senso più vero dell’ostracismo foscoliano al verso che “suona” e “non crea”), egli conduceva questo articolo del suo credo estetico al centro ideologico che animava la sua attività e non solo di poeta. Ne derivava non un’apertura di nuove prospettive, un modo più sottile di intendere il rapporto fra determinate forme d’arte e le loro matrici ideologiche, ma la riduzione astratta e schematica della molteplicità di legami e condizionamenti fra ordini diversi di fenomeni a scontro di opposte concezioni religiose, con la conseguenza di trascorrere dalla identificazione di diversi modi d’essere artistici e dei loro diversi fondamenti ideologici, che già si incontrava presso critici e filosofi romantici, alla condanna pregiudiziale di uno di essi, perché estraneo al canone neoclassico e al suo sottinteso naturalismo, mentre il senso di una duttile intelligenza storica si dissolveva in una spiegazione deterministica e perfino razzistica: “il cristianesimo è una religione semitica, cioè ebrea; e i semiti, gli ebrei, non intendono, anzi odiano il bello plastico. Ci mancava anche questo, che a noi, greco-latini, nobile razza ariana, dovesse esser infusa una religione semitica, a noi figli del sole, adoratori del sole e del cielo. Cotesto innesto contro natura ci ha guastati, ci ha fatti falsi, tristi, pusillanimi, indolenti” (Ep., IX, p. 108). La presenza in una poesia, che pure voleva conformarsi a una poetica ora diversa da quella giambica, di questo momento anticristiano, quanto aspramente polemico e oratorio altrettanto debole nella sua struttura concettuale, finiva per essere spia dell’insicuro, possesso della perseguita serenità antica.
Dal ’63 al ’76, anni intercorsi tra l’inno A Satana e l’ode Alle fonti del Clitumno, vi fu un affinamento stilistico ma non un effettivo svolgimento di pensiero nel Carducci. L’ode, infatti, ripropone, sia pure in diversa chiave psicologica e artistica, la stessa contrapposizione dell’inno fra paganesimo e cristianesimo, rivelando ancora una volta il carattere polemicamente emblematico di quel particolare mito del mondo classico, che nel ’76 era ormai culturalmente arretrato: già da quattro anni, infatti, era stata pubblicata La nascita della tragedia di F. Nietzsche, quando il C. salutava l’anima umana “serena de l’Ilisso in riva”, “intera e dritta ai lidi almi del Tebro”. Anche sul piano della vita interiore del poeta siamo di fronte al segno piuttosto di una lacerazione e di un dissidio che di un possesso: lo stato di grazia di un momento (“Sento l’ellenica vita / Tranquilla ne le vene fluirmi”) non significava la conquista di una splendida atarassia, non solo per l’affiorare di turbamenti profondi (“E sempre corsi e mai non giunsi il fine”) che potrebbero ritenersi legati alla breve scia di un sentimento occasionale, ma anche per la consapevolezza di una barriera che ci separa dalla felicità antica (“Ahi, da che tramontò la vostra etate / Vola il dolor su le terrene culle”). Ma nel complesso di ragioni che impedivano al C. di realizzarsi compiutamente come poeta del risorto naturalismo ellenico, o, per usare una celebre definizione, come ultimo omerida, emerge il suo modo di sentire la storia che avvolgeva certe istanze dell’Ottocento storicista e romantico in una risentita passione morale e in un ineliminabile velo di malinconia.
Non gli era estraneo il pensiero vichiano, anche se attinto indirettamente e non penetrato nella sua complessa e difficile articolazione; ma, al di là di questa ascendenza, al di là dell’esercizio continuo nelle ricerche storiche, affrontate e promosse con un senso quasi religioso delle antiche memorie patrie, egli fu poeta della storia perché avvertì la realtà tutta come un perenne fluire e perdersi di immagini, di affetti, di ideali, su cui si leva la poesia: “muor Giove e l’inno del poeta resta”. E se, facendo sua l’idea goethiana di “classico”, celebrò il perdurare nel cambiamento, l’immutabilità dell’anima umana nel rinnovarsi delle generazioni (“ciò che fu torna e tornerà nei secoli”), pure questo gioioso senso di un flusso perenne, in cui l’uomo muore come individuo per vivere come umanità, non rappresentò un approdo definitivo per il suo spirito. Anzi una simile visione, se in alcuni momenti sembrò placare le sue inquietudini, in altri le acuì tormentosamente. Nello scorrere del tempo (“Pone l’ardente Clio sul monte dei secoli il piede”), nello splendore della luce (“allor che il sole / Ne la serenità di maggio splende”) la terra gli appare un cimitero infinito (Ballata dolorosa, Presso l’urna di P. B. Shelley): la bellezza e la verità sono solo nel passato e nella morte.
Per l’illusione di ancorare a un avvenimento esterno le svolte fondamentali della vita, il poeta credette e amò credere che il suo rinnovamento artistico fosse legato all’incontro con Lina. In realtà questo incontro e la genesi di una poesia o aperta con più insistenza a motivi intimi o impegnata a realizzare un ideale di bellezza pura, che la parola considerava come pietra da incidere con paziente bulino, coincisero cronologicamente, e tra di essi, sul piano psicologico, esistette un legame non solo fortuito. Ma la vena di poesia che accoglieva le memorie e gli affetti dell’uomo e il suo amore per un’arte dal classico decoro non nasceva certo a partire dal 1872: la sua origine si confonde con i prodromi dell’itinerario poetico carducciano. È tuttavia vero che quei temi e quel gusto, in apparenza soffocati dal momento giambico, venissero ora ripresi e condotti a più maturi esiti, anche sotto lo stimolo di nuove suggestioni culturali (Platen, Hölderlin, Goethe, Gautier, Baudelaire, Leconte de Lisle), come la poesia giambica aveva operato rispetto a un’altra tendenza affiorante nella poesia giovanile fra il dipanarsi del vario sperimentalismo letterario, onde il suo valore di positivo acquisto, contro cui non significava molto la confessione di sfiducia del poeta allorché acquistava consapevolezza di procedere verso una rinnovata fase della sua arte. Dalle Primavere elleniche del ’72 prevalgono nella produzione lirica del C. una più vigile sensibilità per i valori espressivi, un più frequente ripiegarsi su motivi intimi, uno spegnere i toni alti per un discorso più ricco di sfumature e di vibrazioni, uno schivare le intemperanze oratorie, le sonorità esteriori, il realismo forzato. Tuttavia anche nella sua stagione più feconda questa poesia si realizza a momenti e bisogna sceverarla dalle molte scorie che l’accompagnano. E ciò non per la pretesa di raccogliere insieme frammenti di purezza lirica, infrangendo l’architettura e la dialettica di questa poesia, ma per indicarne il carattere composito, la mescolanza di richiami eterogenei, l’alternarsi più frequente che nell’opera di altri poeti di tratti di indiscutibile fascino e cedimenti, sordità, giri prosastici, soluzioni facilmente prevedibili. Ma più che una forzatura sarebbe un vero e proprio errore, accostando i risultati di questa poesia ad altre esperienze della contemporanea poesia europea o peggio filtrandoli attraverso esperienze successive, concludere che sul piano storico ci troviamo di fronte a un revirement culturale ed artistico, a una inintelligenza delle nuove forme verso cui muoveva la lirica del secondo Ottocento. Il che rinnoverebbe su un più complesso sfondo europeo e nella prospettiva di poetiche superiori l’accusa già mossa dal Thovez che nella scelta linguistica, metrica, tematica il C. avrebbe operato a ritroso rispetto al Leopardi, determinando un ristagno nel corso progressivo dell’arte (ove l’errore, come fu notato, era nell’idea stessa di progresso da un’esperienza poetica all’altra); e ancora condurrebbe a respingere nell’ambito di impostazioni puramente retoriche quella che era la struttura – narrativa, sentimentale, didascalica, oratoria – di una poesia diversa nel suo impianto da quelle esperienze d’avanguardia che negavano ogni struttura, ma, in realtà sostituendole con altre più sottili e ritenute meno eterogenee alla purezza lirica perseguita.
Nel 1873 per i tipi del Galeati di Imola videro luce le Nuove poesie di Enotrio Romano, che raccoglievano quarantasei componimenti, di cui nell’ordinamento definitivo di tutte le Poesie, uno sarebbe passato agli Juvenilia, uno ai Levia Gravia, dieci ai Giambi ed Epodi e trentadue alle Rime nuove.
Il volume, diversamente dalle raccolte definitive, dà l’immagine dell’attività poetica carducciana nel suo svolgersi su tre direttive non senza reciproci rapporti e talora compenetrazioni: da un lato essa è dominata ancora dall’impegno politico, che si traduce per lo più in invettive e sarcasmi (vi sono, ad esempio, compresi gli epodi dedicati alla Francia); dall’altro dalla scoperta del mondo ellenico come rifugio sereno per lo spirito umano e insieme mito polemico contro il romanticismo e il cristianesimo; infine dal motivo autobiografico, che o è semplice spunto lavorato con orpelli letterari e pago d’esaurirsi in eleganze più o meno manierate (caso limite la capziosa suggestione baudelairiana di Vendette della luna), o affonda le radici in un risentimento vitale, mette a nudo i contrasti e gli amori di un animo elementare, la sua terrestrità, la sua paura del pensiero che nega l’azione e dell’oscurità che nega il sole (e nascono allora gli spazi e i silenzi, in cui tra le reliquie di civiltà remote germoglia un fanciullesco ed esclusivo desiderio di gloria – Avanti! avanti! -; il freddo sgomento dell’improvvisa rivelazione della morte nel dilagare della luce di giugno – Rimembranze di scuola -;la muta solitudine dell’orto, ove la figura del melograno si staglia in uno splendore disperato – Pianto antico -;la nostalgia di una vita contadina rude e schietta, che si assomma nell’immagine della bionda Maria di Idillio maremmano, rilevata attraverso un lavorio stilistico, che rinverdiva classiche eleganze pariniane e foscoliane in un colorito tra di Signorini e di Fattori). Le Nuove poesie ebbero una seconda edizione per i tipi dello Zanichelli di Bologna: vi erano premessi i giudizi di tre critici tedeschi, lo Hillebrand, il Pichler e il von Thaler; mutamento di rilievo, rispetto alla stampa del ’73, era nella disposizione delle poesie non più cronologica ma per affinità tematica (nel primo libro quelle di ispirazione giambica, nei tre successivi quelle che sarebbero poi passate nelle Rime nuove, nel quinto le traduzioni da Goethe, Platen, Heine).
La più intensa attività poetica di questi anni non significò per il C. un allentamento del serrato lavoro di critico e di storico delle nostre lettere (più volte ebbe a dichiarare la priorità di questo impegno e, di contro a perduranti dubbi sulla sua poesia, la sicurezza che qui venisse imprimendo una traccia non superficiale); né gli orizzonti di un’arte serena come quella delle Grazie foscoliane, a cui veniva conformando il suo lavoro, e in cui cercava oblio, valevano ad allontanarlo dalle molte polemiche politiche e letterarie, talora angustamente personali, nelle quali amò cacciarsi, facendo spreco di virtuosismo dottrinario e stilistico, spesso sproporzionato alla statura degli avversari e ai motivi del contrasto. Importanti per il chiarimento dei presupposti e del significato della sua arte sono le polemiche contro i detrattori e i fraintenditori di essa, raccolte poi nelle Confessioni e battaglie.
Tra queste celebre quella contro il Guerzoni e lo Zendrini (Critica e arte, 1874), che certo nella parte contenziosa sente l’usura del tempo e svela stento nell’ironia e pose gladiatorie nell’invettiva, laddove vivace e incisiva riesce in quella tipologia di critici, attraverso la cui canzonatoria erosione viene delineando un’idea severa degli studi, ricca di suggestione poetica e di pathos civile: “Entrate nelle biblioteche e negli archivi di Italia, tanto frugati dagli stranieri; e sentirete alla prova come anche quella aria e quella solitudine, per chi gli frequenti co’l desiderio puro del conoscere, con l’amore del nome della patria, con la conscienza dell’immanente vita del genere umano, siano sane e piene di visioni da quanto l’aria e l’orror sacro delle vecchie foreste…”. L’amore per l’erudizione e lo spirito risorgimentale si fondevano in questo invito, che fu lo stimolo animatore della scuola del metodo storico.
Le lunghe ricerche documentarie non furono solo la base della sua critica, ma anche uno dei caposaldi del suo magistero, che seppe trascinare tante giovani energie a un lavoro mostrato non più arido e mortificante. Ma quando questo suo ideale si traduceva in canone di valutazione d’indirizzi e metodi disformi, allora si irrigidiva in pregiudizio e mostrava l’intima confusione di erudizione e storia: “Il De Sanctis è tutto metafisica e nulla storia: il Settembrini è pieno di lacune, di prevenzioni, di errori di fatto, e, come storico, meschinissimo” (Ep., VII, p. 54). Naturalmente non solo su questo punto era il suo divario dal De Sanctis e dalla scuola napoletana, da cui riluttava in primo luogo la sua stessa forma mentis preclusa alla sistematicità della filosofia se non proprio ad essa ostile, poi la sua maggiore attenzione al momento letterario, tecnico, e in conseguenza una più spregiudicata duttilità ideologica, infine il suo costante impegno di scrittore che anche la pagina critica pretendeva lavorata con intento d’arte.
Queste divergenze sono state variamente sottolineate per caratterizzare, attraverso il confronto, due opere diversamente significative: l’una critica e storica, l’altra erudita ed artistica; l’una fondata su una salda concezione dell’arte, l’altra priva della base filosofica indispensabile alla critica, quindi valida piuttosto per la ricchezza e varietà della dottrina e per la suggestione di non pochi tratti, meritevoli di figurare accanto alle più celebri liriche di tema storico delle Rime nuove e delle Odi barbare, da cui non differirebbero che per il metro. Una tale rigida contrapposizione, fissata dal Croce, si è venuta arricchendo di nuovi spunti, che l’hanno resa più articolata e meno categorica. L’importanza dell’attenzione carducciana ai valori stilistici e la preminenza nel De Sanctis dell’ispirazione etico-civile (distinzione messa in luce per la prima volta dal Petrini) non solo caratterizzavano due personalità e due tradizioni diverse, quella tosco-emiliana che il classicismo accoglieva come culto umanistico della bella forma, e quella meridionale, dalla fine del Seicento impegnata nella ricerca dei fondamenti della critica al di là o contro le tradizionali istituzioni retoriche, ma anche si offrivano come due esperienze non da contrapporre ma da integrare idealmente. La divergenza di fondo non impedì al C. di far suoi spunti e giudizi dell’avversato critico, come ad esempio nel discorso del ’75 Ai parentali di Giovanni Boccacci e più ancora nelle pagine dedicate al certaldese nei discorsi Dello svolgimento della letteratura nazionale;e forse anche la lettura della Storia del De Sanctis gli destò una maggiore attenzione, pur fra ironie e impazienze, per il concetto di forma: ma si trattava in questo caso di un rapporto di superficie, perché egli, sostanzialmente estraneo ai presupposti idealistici del pensiero desanctisiano, non colse, e non poteva, il significato vero di tale concetto e la sua novità rispetto alla secolare tradizione grammaticale e retorica.
Alla tradizione sembrò ritornare con più rigida disciplina, dopo una fase di impetuoso e generoso contenutismo che lo aveva spinto a sopravvalutare nella poesia il momento ideologico e passionale. Non si trattava ormai di una ripresa di formalismo umanistico, perché l’interesse per il fatto espressivo e le sue intrinseche leggi di eleganza e di decoro nasceva da una apertura a certe tendenze del gusto contemporaneo, in particolare a quelle poetiche che in Francia reagivano all’immediatezza e alla spontaneità romantiche attraverso il culto del lavoro artistico impassibile e distaccato. Anche questo mito, come il rinnovato sogno neoclassico di un’armonia ellenica, svelava al suo fondo una concezione naturalistica dell’uomo e del mondo, che era il significato ideologico sotteso pur nel professato disimpegno dell’attività artistica; così, nell’ambito dell’attività critica, l’attenzione per, la forma, se non assorbiva come implicito il discorso su ogni altro valore e significato, perché essa non era sintesi e totalità come la “forma” desanctisiana, certo non lo escludeva esaurendo nel suo giro ogni interesse. Quindi l’importanza data al momento tecnico non era il segno di una critica da rhétoricien condotta con finalità grammaticali e retoriche, perché le categorie grammaticali e retoriche erano assunte come mezzo di intelligenza storica. Del resto l’interesse del critico si appuntava con ostinata finezza al particolare, ma poi risaliva al quadro d’insieme, all’ambiente, ai tempi, alle condizioni di una data esperienza artistica. Nell’uno e nell’altro momento spesso obliava le sue scelte letterarie e morali, non per tiepidezza di eclettico ma per disponibilità ad ogni serio impegno artistico al di là dei motivi di consonanza o dissonanza col suo modo di sentire e di pensare (e in questo atteggiamento affine ancora al Giordani, non certo al De Sanctis), e non per indifferenza erudita ma per il gusto della pura evocazione storica, del grande affresco, per il desiderio di ricreare, quasi rivivendolo calato in esso, un momento del passato senza lo stimolo della denunzia implacabile delle sue interne aporie o del raffronto continuo con le proprie convinzioni (e qui, più che ad altri, affine al Sainte-Beuve, anche se non elegantemente scettico come il francese, né dotato delle sue capacità di scavo psicologico e del suo interesse sottile per la fenomenologia religiosa).
Da queste attitudini, affinate attraverso l’ininterrotto esercizio e animate da quello stesso soffio di poesia che dava vita a tutto un filone della sua lirica, da Poeti di parte bianca a Sui campi di Marengo, Faida di Comune, Il Comune rustico, Il Parlamento, nascevano i suoi saggi storico-critici più suggestivi, la cui importanza particolare andrà valutata nel contributo da essi recato alla storia dei singoli temi, ma il cui significato unitario si può riassumere nell’attenzione nuova rivolta alle forme della nostra tradizione letteraria e nel disegno di quadri vari e mossi di certi ambienti su cui si profila e si caratterizza l’individualità di un poeta. Tra i saggi che meglio danno il segno delle sue doti sono quelli giovanili Delle poesie toscane di messer Angelo Poliziano (1863) e Delle rime di Dante (1865);quello occasionato dalle celebrazioni centenarie del ’75 La gioventù di Ludovico Ariosto e la poesia latina in Ferrara;i due volumi Parinimaggiore e Parini minore, che abbracciano studi di oltre un ventennio a partire dal 1881, di cui il più importante è la Storia del Giorno del 1892, e che nell’insieme offrono il ritratto del poeta e della cultura lombarda nell’età dell’illuminismo, ricostruita nei suoi rappresentanti e nelle sue istituzioni, con un gusto e un metodo che hanno ricordato il Sainte-Beuve di Chateaubriand et son groupe littéraire.La personalità e l’opera del Parini sonopresentate non nello splendido isolamento di un’altezza morale e artistica non raggiunta dalla poesia del tempo, ma in una fitta trama di rapporti storico-culturali in primo luogo con l’Arcadia, rivalutata di contro alla condanna romantica per la sua lezione di classicismo e di eleganza letteraria; così IlGiorno è esaminato nella sua struttura tematica, linguistica, metrica, considerata in sé e nei suoi legami con la tradizione, attraverso una fine analisi delle forme nel loro svolgimento, di cui un bell’esempio sono le pagine sulla storia del verso sciolto. A questi saggi vanno affiancate le ricerche volte a illustrare l’evoluzione di un gusto, di un genere, di un metro, quali, per citare le più note, Musica e poesia nel mondo elegante italiano del secolo XIV (1870), La lirica classica nella seconda metà del secolo XVIII (prefazione al volumetto della “Diamante” pubblicato nel 1871, comprendente una raccolta di poeti settecenteschi), Dello svolgimento dell’ode in Italia (1902).
Questo lavoro di analisi e di ricostruzione storica non esauriva l’impegno del C., che non era solo quello di una spregiudicata e disinteressata intelligenza del passato. Del resto certe categorie storiche, quali egli le andava configurando, assommavano il carattere polemico di tutta la sua opera e non solo critica: si pensi alla sua idea del Rinascimento come netta contrapposizione al Medioevo e in rapporto di continuità con la storia moderna, che finiva per intrecciarsi con i motivi di rifiuto della scuola romantica, nella quale idea il suo laicismo trovava giustificazione e avallo nella misura in cui si faceva canone di interpretazione storica. Più inquieto e tormentoso, proprio per la vis polemica e per l’urgenza degli indirizzi che egli stesso perseguiva nella sua opera di poeta, il rapporto con la letteratura contemporanea o di cui avvertiva contemporanea l’influenza: le preclusioni, le oscillazioni, l’alternarsi del rifiuto preconcetto e della pacata disponibilità rivelano la loro ragione ove li si riporti a un itinerario non solo critico.
è il caso del suo antimanzonismo. che non può ridursi ad un unico movente e la cui storia si identifica con lo svolgimento – non certo ricco di interna dialettica – della sua cultura e della sua arte. Di questa sua avversione egli stesso raccontò scherzosamente la lontana genesi autobiografica in apertura del saggio del ’73 A proposito di alcuni giudizi su Alessandro Manzoni, serrata polemica col Ferrari e col Rovani, cioè con le esagerazioni e le forzature di un culto apologetico, in cui l’Italia intellettuale e morale si riconosceva. Nell’avversione giovanile era stata operante anche la volontà di rompere con l’angusto ambiente fiorentino, che si esaltava in quel culto, sia che nel nome del Manzoni vantasse il suo preteso primato linguistico, sia che in quel modello cercasse la giustificazione di una letteratura sciatta ed edificante. Il successivo radicalismo giacobino ispirò un più netto rifiuto dell’opera manzoniana, nei cui spiriti animatori gli sembrava che si fondessero cattolicesimo, romanticismo e restaurazione. Sul divario ideologico, che si rafforzava anche di una diffidenza umana (orgogliosissimo cristiano il Manzoni e falsa la sua ostentata umiltà, leggiamo in una lettera a Lidia), si innestava la polemica letteraria, che non nasceva solo da un gusto esclusivo nella sua forte individualità, ma anche dalla volontà di espansione di un indirizzo che si scopriva erede di quella tradizione indigena osteggiata e rifiutata dalla scuola manzoniana. Pertanto il linguaggio sliricizzato dei Promessi sposi non rappresentava una conquista né nella storia della letteratura italiana dell’Ottocento né in quella dell’arte del Manzoni, per chi dello stile riproponeva l’immagine nobile e dotta del classicismo (e letterario e consapevolmente provocatorio poteva dirsi anche nell’irto realismo linguistico della sua lirica giambica), né il romanzo appariva un genere di piena validità estetica a chi lo riteneva una forma decaduta della poesia epica e nella sua fortuna e sviluppo scorgeva i segni di un invilimento dei tempi, onde la naturale inferiorità del Manzoni rispetto a Dante e ad Ariosto. Ma non sempre il C. filtrava il suo giudizio critico attraverso le maglie della sua ideologia e della sua poetica: nascevano quindi anche pagine manzoniane ricche di considerazioni stilistiche e libere da preconcetti, come quelle Dell’inno la Risurrezione in A. Manzoni e in s. Paolino d’Aquileia (1884), su cui poteva fondarsi per rifiutare non a torto l’illazione che le parole, pronunziate nel 1891, scoprendosi a Lecco il monumento al Manzoni, rappresentassero una palinodia, anche se il dichiarare leggenda il suo antimanzonismo concedeva troppo alla circostanza celebrativa. Ancora in questo tardo intervento il pregiudizio nei confronti del genere “romanzo” frenava l’adesione ai Promessi sposi, cui pure si riconosceva il merito di avere compiuto una “gran vendetta su ‘l dispotismo straniero e su ‘l sacerdozio servile e ateo”, giustificando così la validità etico-politica dell’opera, i cui spiriti, prima decisamente avversati, venivano ora ricondotti non senza forzatura al laicismo dominante nello scorcio del secolo la cultura italiana.
Anche il Leopardi fu per il C. qualcosa di più e di diverso di un poeta su cui concentrare lo sforzo di una pacata intelligenza critica. Del resto il vero e proprio interessamento dello studioso fu stimolato dalla circostanza occasionale del centenario: prima di tale data, infatti, non si incontrano nei suoi scritti che sparsi cenni, per lo più polemici, dettati dalla stessa urgenza delle sue convinzioni morali e letterarie, che fatalmente venivano a scontrarsi non con l’opera leopardiana, avvertita ormai chiusa nella sua classica bellezza, ma con gli indirizzi perseguiti dai mediocri ripetitori degli spiriti e delle forme di quell’opera. Il serrato esame della debole tessitura del Consalvo (Jaufré Rudel, 1881)assommava questa reazione nei confronti del deteriore leopardismo che aveva fatto scuola. Associato al nome del Giordani, il nome del grande recanatese era apparso in fronte alle Rime di San Miniato come segno di una scelta ideologica, prima e più ancora che di una fedeltà artistica. Ma quando il tumultuoso mondo di pensieri e di affetti della giovinezza si venne componendo in quell’ideale ellenico, che nel mito letterario esprimeva una visione laicista e naturalista del mondo, proprio allora più che le affinità col messaggio leopardiano acquistarono risalto le differenze. Di fronte al vitalismo prorompente che finiva per farsi celebratore del progresso industriale e che sarebbe stato conquistato dall’idea di una politica di espansione e di dominio, la dura conquista di una verità senza illusioni e la ricerca di un nuovo fondamento, non più metafisico, alla convivenza umana non potevano apparire che una umbratile rinunzia. L’eredità del Leopardi veniva affiancata a quella del Manzoni: “E chi piagnucola o bestemmia rachiticamente e chi biascica paternostri vada a farsi benedire o maledire, come più gli piace. Via via il romanticismo così degl’inni sacri e di Adelchi, come di Nerina e di Silvia o della Ginestra”; “Oggi è il naturalismo che pervade tutto, oggi è l’umanesimo che deve trionfare, oggi è l’ellenismo che ha da risorgere” (Ep., IX, pp. 257-258).E a questi motivi si aggiungeva, sul piano formale, l’ostilità, all’innovazione metrica della stanza sciolta, che se nel Leopardi si giustificava per l’alta qualità del dettato lirico, finiva per essere segno di decadimento negli imitatori, come ogni rinunzia a più severa disciplina artistica: “Leopardus autem genuit Aleardum Aleardus autem universa pecora in conspectu domini” (Ep., XI, p. 28).
Nel 1898, a parte minori interventi d’occasione, il C. compose i due saggi Le tre canzoni patriottiche di Giacomo Leopardi e Deglispiriti e delle forme nella poesia di Giacomo Leopardi, che, pur importanti per più di un risultato (la distinzione dei “grandi idilli” e la felice caratterizzazione del loro tono poetico, l’ascendenza tassesca e guariniana della canzone libera, il valore capitale della Ginestra non solo per il linguaggio “più determinato e ardito” rispetto agli altri canti ma anche per il pensiero, in cui poteva scorgersi un accostamento al socialismo), non mostravano certo la centralità che l’opera del Leopardi aveva avuto per il De Sanctis, anche come affinamento della nozione di poesia e quindi strumento di più sottile penetrazione critica e storica. E contro il De Sanctis, accusato di un insicuro possesso dei “documenti storici tecnici e artistici, onde bisogna dominare la serie delle idee e lo svolgimento delle forme” rivalutava le canzoni All’Italia, Sopra il monumento di Dante, Ad Angelo Mai, opponendo la sua giovanile commozione di fronte a quella che gli era apparsa “lirica grande” alle riserve di un gusto sofisticato e nevrotico. Un contributo fondamentale dette poi agli studi leopardiani, richiamando l’attenzione sulle inedite carte napoletane (discorso al Senato del 9 apr. 1897)e presiedendo la commissione deputata al loro studio e alla loro pubblicazione: tra il ’98 e il ‘900 vide luce lo Zibaldone, allora intitolato meno leopardianamente Pensieri di varia filosofia e bella letteratura.Il discorso Allo scoprimento del busto di Giacomo Leopardi nella grande aula del Comune di Recanati il XXIX giugno MDCCCXCVIII ha, come il discorso manzoniano di Lecco e più ancora di quello, una certa aria di ufficialità solenne, che toglie naturalezza al pensiero e dissolve l’attitudine individualizzante nel generico della mitografia.
In genere le orazioni del C. (di cui le più famose sono: Presso la tomba di Francesco Petrarca, 1874; Ai parentali di Giovanni Boccacci, 1875; Per la morte di Giuseppe Garibaldi, 1882; Per l’inaugurazione di un monumento a Virgilio in Pietole, 1884; Lo Studio di Bologna, 1888; La libertà perpetua di San Marino, 1894)colpirono i contemporanei proprio per le loro virtù più esterne e caduche: la loro sapiente orchestrazione, l’uso sorvegliatissimo del climax, l’onda verbale e immaginifica che si innalza e precipita per tornare a spianarsi in distese tranquille, la dottrina esibita o dissimulata con signorile misura restano spesso scompagnati dal rigore razionale che cerca la lucida persuasione e non l’ammirato consenso. I giornali del tempo ci danno la misura della popolarità che il poeta andava acquistando e del successo di queste sue pubbliche comparse; ma il resoconto più vivace si legge spesso nelle pagine del suo epistolario: si direbbe che le calorose accoglienze gli accendessero l’estro allegro (e nasceva, ad esempio, il ritratto canzonatorio dell’Aleardi suo cooratore alle celebrazioni petrarchesche del ’74). Dagli anni dell’isolamento sdegnoso e polemico, il C. andava passando alla fase della stima e del consenso non più di una ristretta cerchia di scolari e di amici, ma della Italia colta, che si veniva riconoscendo nella sua parola di artista e nella sua lezione di studioso. Questo processo si basava sì sulla fermezza e sulla serietà con cui aveva sempre atteso alla sua opera, ma fu anche favorito dal nuovo rapporto che si venne instaurando fra lui e il potere costituito. Ciò significò anche il progressivo ammorbidimento delle posizioni giacobine e degli spiriti rivoluzionari che avevano acceso di baleni violenti la sua poesia, e potette apparire a giudizi più intransigenti un disimpegno e una incoerenza. Nel 1876 aveva accettato la candidatura alle elezioni parlamentari nel collegio di Lugo, convinto che la parte democratica dovesse impegnarsi nel confronto e conquistarsi il suo posto nella rappresentanza nazionale: risultato eletto, si vide escluso dal sorteggio, non potendo sedere alla Camera più di un numero stabilito di professori universitari.
L’esclusione non dovette dispiacergli, dati i timori più volte espressi che le incombenze di deputato avessero a distrarlo dagli studi e, peggio, a dissestare il suo magro bilancio domestico. Ma al fondo di questi motivi vi era la delusione che l’impatto con la realtà gli aveva procurato: “Questa politica vista da più vicino mi fa un senso di noia feroce e tempestosa”. L’amarezza e lo scetticismo conseguivano alla mancanza di concretezza e di un preciso contenuto che caratterizzasse le sue scelte politiche al di là di un nobile ma generico programma ideale. La vittoria delle sinistre gli dà l’entusiasmo momentaneo del trionfo su uomini a lungo e profondamente avversati (“I Lanza, gli Spaventa, i Visconti Venosta, i Guerra, i Finzi, i Massari, i Bonghi, o abbattuti o feriti a morte”); ma, mentre saluta con gioia la fine di un malcostume politico, pur teme l’insorgere fra gli uomini nuovi del vizio antico (“il paese e lo stato non sono più un’accomandita di faccendieri… pur che non si faccia una nuova consorteria di sinistra”); e conclude, quasi a sottolineare il suo distacco: “Non è la parte mia, non è il mio ideale che trionfa” (Ep., X, p. 264). La sua fede basata sul temperamento più che sul pensiero, la sua incapacità di comprendere i tempi lunghi e i compromessi di cui l’azione politica non di rado abbisogna lo portano da un lato a chiudersi in un sogno di grandezza e di eroicità proiettato nel mito di Roma, dall’altro al disprezzo e al sarcasmo contro i programmi concreti di strutturazione strativa ed economica del giovane Stato, contro la saggezza operosa, che gli appaiono politica grigia, senza lo splendore di una grande idea, risultato di giochi parlamentari tessuti da meschine camarille. Le crisi ministeriali succedutesi nella primavera del 1881, ad esempio, gli destano un malumore profondo, che si sfogherà nelle ingiuste contumelie contro Depretis e Sella: “Che importa a me se l’irto spettral vinattier di Stradella / mesce in Montecitorio celie allobroghe e ambagi? / e se il lungi operoso tessitor di Biella s’impiglia, / ragno attirante in vano, dentro le reti sue?”. Di fronte al mortificante spettacolo dell’oggi si apre la visione luminosa di Roma, mondo di affetti e di memorie, simbolo di risorgenti speranze. In essa, come sul piano del naturalismo estetico era avvenuto per l’immagine dell’Ellade serena, confluivano un bisogno di armonia e di pienezza vitale da attuare e la nostalgia consapevole di un’invalicabile lontananza. Sul piano dell’arte poche figurazioni imprigionano quel mito intellettuale e morale nella parola evocatrice libera dal peso di allotrie esigenze: in alcuni momenti la raffigurazione delle rovine (Dinanzi alle Terme di Caracalla) ha il senso della magnificenza che spira dalle incisioni del Piranesi, corsa da una venatura di malinconia romantica. Ma la purezza lirica facilmente si intorbida nelle giunture oratorie e nelle impennate tonali, che rompono la felice medietas dell’ode: “Febbre, io qui t’invoco, / nume presente”, “Febbre, m’ascolta. Gli uommi novelli quinci respingi e lor picciole cose”; così certe interrogazioni incrinano di scatti inquisitoriali il dipanarsi di più contenuto dettato, sovrapponendo alla commozione lirica l’urgenza della polemica intellettuale: “Chi l’ombre indusse del piangente salcio / su’ rivi sacri?” (Alle fonti del Clitumno); “Chi le farfalle cerca sotto l’arco di Tito?” (Roma). Al di là del suo valore estetico (che si realizza con una filigrana più pura proprio nei momenti della pensosità nostalgica, in cui si effonde il senso di una preclusione e di una disarmonia), il mito di Roma come si articolò nella poesia carducciana ebbe una sua non lieve incidenza sulla mentalità e sul costume dell’Italia tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del nuovo secolo. Ma può questa efficacia nel proporre un mito o nel fissare nella parola definitiva un’esigenza diffusa disgiungersi dalla suggestione e dal fascino di quella poesia? La distinzione che il ripensamento critico è venuto operando nella complessità di motivi e forme della poesia del C. non è essa stessa che un aspetto della vita di quella poesia nella storia, su cui esercitò presa per la forza sentimentale e la passione ideologica, o per il valore oratorio prevalente sui momenti di più distaccata contemplazione, o per questi stessi momenti che pure certe idealità e certi pensieri sommovevano, finché proprio per questo messaggio cadde in oblio e fu avversata, fino a più recenti riprese in chiave e in prospettive nuove. Se il mito di Roma che questa poesia celebrava fu accolto dal sorgente nazionalismo come espressione precorritrice delle sue idealità e dei suoi propositi, se l’oratoria fascista vi scorse un’affinità col suo programma di imperialismo, ciò riguarda la storia del nazionalismo e del fascismo ed è solo in linea mediata un capitolo della fortuna, non separabile da forzature e fraintendimenti, del poeta. Onde la necessità di distinguere, caratterizzando le diverse matrici storico-culturali a cui era riconducibile il vagheggiamento carducciano della romanità, ancora pervaso di spiriti risorgimentali, ulteriore simbolo della sua polemica laicista, ormai volta contro la politica italiana incapace di creare sul piano civile un equivalente della universalità della Chiesa. In questo mito si assommavano il messaggio mazziniano, spogliato della sua messianica sacralità; il pensiero degli storici tedeschi che, offrendo una più articolata e suggestiva immagine della romanità repubblicana e imperiale, ne additavano anche le conquiste imperiture; il desiderio di certa intellettualità europea, di cui era portavoce cattivante il Renan, che la capitale del cattolicesimo divenisse capitale della scienza e del libero pensiero; l’apostolato laicista di varie correnti risorgimentali, che qualche anno più tardi sarebbe stato fatto suo dalla rinnovata massoneria, contrapponentesi alla missione apostolica del sacerdozio ecclesiastico; infine, elemento non trascurabile nella risentita e passionale anima del Carducci, il senso di una frustrazione storica accumulata nel corso del Risorgimento, dal dissolversi dello spirito del ’48 e dal crollo della Repubblica romana, ai giorni neri di Aspromonte e di Mentana, alla vergogna di Lissa, al compimento dell’unità quasi per dono straniero, agli anni immediatamente postunitari caratterizzati dall’affarismo cinico, dal gioco delle consorterie parlamentari, dallo scarso peso della presenza dell’Italia nel consesso dei popoli. Una eticità schietta pervadeva questa idea come si veniva configurando nella sua poesia: la missione della terza Roma avrebbe dovuto essere di civiltà nel nome della giustizia e del diritto, di verità nel nome della scienza e della ragione, il suo trionfo sulla barbarie religiosa e chiesastica, come proclamava l’alcaica che di Roma celebrava, non senza artificiosità retorica, l’annuale della fondazione. Ideale quindi lontano dai miti oscuri del sangue, dalla crudeltà della guerra per la guerra, che il decadentismo avrebbe rivestito di una morbosa funeraria bellezza. Tuttavia, se la generazione che fece suoi questi miti e li tradusse nella barbarie dell’imperialismo, pur consapevole delle diverse scaturigini ideologiche e dei limiti tutti letterari dell’opera carducciana (e un valore emblematico assumeva questo divario come era fissato nettamente dal D’Annunzio nell’equivoca esaltazione Diun maestro avverso, più sincera dell’irrefrenabile magniloquenza agiografica del saluto ad Enotrio che avvia a chiudere Maia), potette in quest’opera scorgere una esperienza affine e precorritrice, non si può dire che solo prevaricasse: accampava in primo piano, e sia pure in una prospettiva distorta, il fondo oscuro di represse speranze, il sogno di potenza irriso dalla pochezza dell’oggi, il malcontento di una borghesia intellettuale rivoltata contro la volgarità e l’egoismo della propria classe e insieme timorosa dello spettro del socialismo, insomma le attese e le delusioni a cui il poeta aveva dato forma smagliante nel mito letterario della renovatio imperii.
L’accostamento alla monarchia fu l’esito di una evoluzione naturale nel C., dato il mutarsi della realtà storica italiana. Di fronte al pericolo di un revanscismo clericale e di una crescente presa sulle masse del pensiero socialista, la monarchia gli apparve garante dello spirito laico del Risorgimento e di un progresso sociale non sovversivo e rivoluzionario. La forma istituzionale dello Stato, sancita dal compimento dell’unità nazionale, era in fondo conciliabile con un programma anche di avanzato radicalismo e con la libertà richiesta dalla dialettica politica, che egli in fondo limitava alla lotta dei partiti borghesi. Questo approdo non rappresentava una involuzione e un tradimento rispetto al giacobinismo rivoluzionario di una volta: se mai della polemica intemperanza degli anni giambici rivelava il limite ideologico, che era nella matrice storico sociale del pensiero animatore.
Certo, nella esteriorità della vicenda giocarono un ruolo di indubbio peso uomini di governo quali Cairoli e Crispi, che presero a blandirlo pur nel rispetto della sua professione repubblicana; o l’abile mediazione della regina Margherita, che seppe far breccia su un animo semplice, anche toccandone discretamente la corda della vanità artistica (e il poeta l’avrebbe salutata nel ’78 con la raffinata arcadicheria di un’ode, che apparve debolezza imperdonabile nel sarcastico irrisore della Consulta araldica, ma di cui anche il severo mazziniano A. Saffi lodò la cavalleresca cortesia). L’incontro con i giovani sovrani a Bologna, raccontato nelle suggestive pagine di Eterno femminino regale (1882), fu il riconoscimento ufficiale che ormai anche lui non poteva disgiungere la casa Savoia e l’unità nazionale. Col passare degli anni l’ideale repubblicano gli venne rivelando sempre più la sua inattualità storica e fu a poco a poco confinato fra i sogni irrealizzati del Risorgimento.
Così il C., nonostante la fiera indipendenza del carattere (di cui, ad es., fu prova l’atteggiamento che assunse a favore di Oberdan e dell’irredentismo, con la conseguenza di provvedimenti disciplinari e penali istruiti a suo carico), venne sempre più aderendo al processo di trasformazione della vecchia Sinistra operato dal Crispi, che salutava “novello Procida” nell’ode del 1895 (Alla figlia di Francesco Crispi), proprio quando più violenta era scatenata la tempesta dell’opposizione contro il vecchio statista, la cui politica sarebbe stata travolta di lì a poco dalla sconfitta di Adua; e sempre più venne impersonando l’ufficio di vate nazionale dell’Italia umbertina, avversato, e in qualche momento anche aspramente, dai giovani radicali e democratici (nel marzo del ’91 gli fu inscenata una dimostrazione ostile nella sua aula universitaria), ma onorato in molti modi fino alla nomina a senatore per decreto regio nel dicembre 1890. Sugli atteggiamenti politici, sulle pubbliche prese di posizione ideologiche del C. non poca influenza ebbe, a partire dal 1886, la sua attiva partecipazione alla massoneria, rinnovata e potenziata dalla opera di A. Lemmi, che fu legato al poeta da amicizia oltre che da affinità di pensieri.
Nel 1877 era apparso, stampato dallo Zanichelli di Bologna, il volumetto delle Odi barbare, che raccoglieva quattordici liriche in metro neoclassico o barbaro; seguirono, sempre per lo stesso editore, nel 1882 le Nuove Odi barbare (in numero di venti, di cui tre traduzioni – una da Platen e due da Klopstock -, seguite dalla versione in latino e in tedesco di quattro odi) e nel 1889 le Terze Odi barbare (altre venti): queste tre raccolte furono fuse insieme nelle Odi barbare del 1893, divise in due libri, e così strutturate passarono nell’omonima sezione delle definitive Poesie.
La forma metrica innovava antichi tentativi risalenti a L. B. Alberti e L. Dati, che si moltiplicarono dopo che il cinquecentista C. Tolomei ne trattò nelle Regolette de la nuova poesia toscana.Il C. ricorda fra i precedenti, di cui aveva studiato i modi, il Tolomei appunto e il Chiabrera, il Ceroni, l’Astori, il Rolli, il Fantoni (“Io non conosco altro che questi saggi; e questi saggi, insieme con alcune odi tedesche, messi a raffronto delle odi di Orazio e di alcuni frammenti greci, furono il campo de’ miei tentativi, anzi il punto di mossa”, Ep., XI, p. 139). Riconosciuta l’impossibilità di stabilire un sistema prosodico nella lingua italiana, e rifiutando il sistema, seguito dai lirici tedeschi e inglesi, di fare coincidere le sillabe toniche del verso moderno con le arsi di quello greco-latino, il C. preferì cercare una corrispondenza fra il ritmo di singoli versi o combinazioni di versi italiani e l’andamento del verso classico come suonava a una lettura grammaticale: barbaro, cioè straniero, sarebbe ipoteticamente risuonato questo andamento metrico agli antichi, nonostante il modellarsi sulla loro lirica. Una questione tecnica, rimasta per secoli nel chiuso ambito dello specialismo, diveniva così un tema di vivaci discussioni nella cultura letteraria italiana, di cui è documento l’ampio e minuto saggio di G. Chiarini, premesso alla seconda edizione del 1878 delle Odibarbare (I critici italiani e le prime Odi barbare).Il significato polemico di questa scelta tecnica era affermato decisamente in limine alla prima raccolta nella saffica Preludio:l’abbandono della snervata forma della lirica tradizionale, “Odio l’usata poesia”, cui veniva contrapposta la strofe “vigile, balzante / co’l plauso e’l piede ritmico ne’ cori”, non rappresentava l’apertura verso schemi meno rigidi ove il discorso poetico potesse distendersi in più libera piena, bensì una nuova e più ardua conquista, di cui era simbolo la plastica immagine della ninfa inutilmente torcentesi fra le braccia del suo silvano amatore. Tuttavia una simile scelta, al di là e contro la direzione programmatica volta a più severa restaurazione classicista, finiva per porsi sulla linea storica di quel rinnovamento metrico inteso come conquista di strutture meno vincolanti, che sarebbe culminato nel novecentesco verso libero e quindi in una decisa rottura con le forme tradizionali. Anche questa fase dell’attività poetica carducciana è ideale e non cronologica, perché la lirica barbara si alternò con quella conforme agli schemi chiusi da un rigido sistema di rime, propri della versificazione romanza; anzi successiva a non poche barbare e allo stesso Preludio del ’75 è il saluto Alla Rima, occasionato come reazione alle accuse mosse a questo strumento di disciplina e di bellezza artistica da D. Gnoli (nell’articolo La rima e la poesia italiana, apparso sulla Nuova Antologia nel dicembre 1876), e condotto sulla scia di Sainte-Beuve in agili e rimatissime strofette ronsardiane e chiabreresche. L’odicina Alla Rima sarebbe stata collocata in fronte alla raccolta delle Rime nuove edita nel 1887, che sistemava le Nuove poesie in una disposizione diversa, con l’aggiunta di componimenti tratti da precedenti raccolte e di altri o inediti o sparsamente pubblicati, come i dodici sonetti del Ça ira, che già avevano visto luce nel 1883 per i tipi del Sommaruga, dedicati a celebrare gli avvenimenti del settembre 1792, “il momento più epico della storia moderna” che sanciva le conquiste della Rivoluzione francese, e come altre famose liriche fra le più suggestive e intense del C. (Era un giorno di festa, Davanti San Guido, La leggenda di Teodorico, Il Comune rustico, Faida di Comune, Ninna nanna di Carlo V)fino all’Intermezzo, che sulla polemica contro la poesia tardoromantica e la professione della sua poetica, dal momento giambico trascorsa a vagheggiare l’imperturbabile classicità ellenica, innestava memorie del paesaggio natio e della fanciullezza, di affetti domestici lacerati dalla morte, con un felice alternarsi di toni, dall’ironia alla pensosità malinconica, dallo scherzo alla virile tristezza, che il chiaroscuro e il contrasto heiniano mostravano ormai divenuto strumento di una originale e nervosa discorsività lirica.
La poesia barbara, non diversamente dall’altra produzione carducciana, da un lato propone i miti sentimentali e fantastici della Grecia e di Roma come naturalismo ed eroicità di cui è possibile la ripresa in una imminente era di scienza e di progresso civile, filtrando dunque quei miti in una ideologia inquieta di fermenti polemici, dall’altro celebra in quei miti un bene perduto, verso cui si protende il desiderio e che solo il sogno rinnova, sul grigio padule della realtà moderna. La storia è o processo di recupero o successione di irrecuperabili valori; ma sempre la pervade un senso di immanente giustizia, che il poeta potrà ipostatizzare nella pagana Nemesi, celebrandone il tragico corso nel destino dei Napoleonidi (Per la morte di Napoleone Eugenio)o di Massimiliano d’Asburgo (Miramar).Accanto a queste e ad altre odi che tendono alla rappresentazione solenne e commossa, ove la poesia si realizza, quando si realizza, su un impianto strutturale letterariamente costruito, fra mosse oratorie ed insistenze non raramente di dubbio gusto (Alle fonti del Clitumno, Alla Aurora, Sirmione, Roma, ecc.), non pochi componimenti, in apparenza minori perché conclusi nel giro di un breve sentimento, o di un pensiero, o di una immagine che sorrida alla fantasia destando un incresparsi di memorie liete o struggenti, rivelano in maniera più netta la finezza e la novità di un linguaggio poetico nel complesso gravato di tanta oratoria inerte.
Si pensi all’essenzialità di liriche quali Ave, Nevicata, Nella piazza di San Petronio, evitando però l’insidia di spostarle verso i più sottili esiti di certo gusto dominante nel nostro secolo. Ma anche dove più composito è l’intreccio dei motivi e il linguaggio tradisce, nelle sue disuguaglianze e nelle sue inerzie, l’altemarsi dell’impegno alla poesia e di più facili soluzioni letterarie, o del distaccato evocare e della ricerca di un’efficacia etico-politica; anche dove l’indecisione fra epos ed elegia impedisce da un lato alla visione di accamparsi serena senza il contrappunto di una sensibilità risentita, o alla vena di intime effusioni di consegnarsi senza il velo di una presunta oggettività narrativa (e qui forse è il segno di un presagio di poesia nuova, che non acquista però coscienza critica) si avverte una autenticità di ricerca, uno sperimentare che non ha la disinvolta eleganza, né raggiunge i risultati più facili e sicuri di ogni eclettismo estetico ed umano.
In Rime e ritmi (Bologna 1899), l’ultima raccolta, alla quale seguì il silenzio della poesia negli anni del malinconico tramonto dell’uomo, si possono distinguere da una parte le grandi odi celebrative (Piemonte, Bicocca di San Giacomo, Cadore, Alla città di Ferrara, La chiesa di Polenta), di cui la critica, a partire dal Thovez, è venuta mostrando la stanca tessitura storico-erudita, o la ripresa senza l’antico nerbo di certa polemica giambica, o il carattere decorativo che accoglieva antichi temi e movenze sotto una patina di maniera; dall’altra momenti di fresco impressionismo, immagini che fissano limpidamente un pensiero o uno stato d’animo, nostalgie d’amore e di spazi luminosi, profili di persone e di paesaggi colti col senso realistico e lirico di certi epigrammi goethiani o da Antologia palatina (Nel chiostro del Santo, Mezzogiorno alpino, L’ostessa di Gaby, Presso una certosa). Dietro questa poesia, in cui vibra talora il presagio del distacco e dell’ombra, il biografo cercherà la traccia delle esperienze umane che l’hanno occasionata: i viaggi, i nuovi incontri, gli amori e le amicizie femminili (Annie Vivanti, la contessa Silvia Pasolini), i soggiorni estivi sulle Alpi prolungati sempre più per un bisogno di solitudine e di pace.
Un velo di tristezza avvolse gli ultimi anni del poeta, la cui attività fu rallentata e resa difficile dalla precoce decadenza fisica. La morte gli andava aprendo vuoti intorno (il collega Gandino, l’allievo prediletto Ferrari); anche le consacrazioni e i giubilei erano segno di smobilitazione e di congedo. Nel 1904 lasciò l’insegnamento; nel 1906 fu insignito del premio Nobel per la letteratura (la sera del 10 dicembre andò a dargliene comunicazione ufficiale nella sua casa il barone De Bildt, ambasciatore di Svezia a Roma). Si spense nella notte fra il 15 e il 16 febbr. 1907 a Bologna; fu seppellito nella certosa.
Edizioni. Il C. stesso curò l’edizione definitiva delle sue Opere (Bologna, Zanichelli, 1889-1905, 20 voll.): I, Discorsi letterari e storici; II, Primi saggi; III, Bozzetti e schermo; IV, Confessioni e battaglie, s. 1; V, Ceneri e faville, s. 1 (1859-1870); VI, Juvenilia e Levia Gravia; VII, Ceneri e faville, s. 2 (1871-1876); VIII, Studi letterari; IX, Giambi ed Epodi e Rime nuove; X, Studi, saggi e discorsi; XI, Ceneri e faville, s.3 (1877-1901); XII, Confessioni e battaglie, s. 2; XIII, Studi su Giuseppe Parini. Il Parini minore; XIV, Studi su Giuseppe Parini. Il Parini maggiore; XV, Su Ludovico Ariosto e Torquato Tasso. Studi; XVI, Poesia e storia; XVII, Odi barbare e Rime e ritmi. Con una appendice; XVIII, Archeologia poetica; XIX, Melica e lirica del Settecento con altri studi di varia letteratura; XX, Cavalleria e umanesimo. Sutale ediz. è condotto l’utile strumento di consultazione della F. Trabaudi Foscarini, Indice analitico–sistematico di tutta la materia contenuta nei venti volumi delle Opere di G. C., I-II, Bologna 1929. Anche al C. si deve l’ediz. delle sue liriche in un solo volume, Poesie (1850-1900), Bologna 1901, e di una scelta delle sue prose più significative, Prose (259-1903), ibid. 1905: questi due volumi sono stati ristampati più volte.
Tra il 1935 e il 1940 è apparsa in 30 voll. l’edizione nazionale delle Opere di G. C., che si avvantaggia su quella curata dal poeta per la maggiore ricchezza di testi, ma che suscita non poche perplessità sul piano filologico. La materia vi è così distribuita: I, Primi versi; II, Juvenilia e Levia Gravia; III, Giambi ed Epodi e Rime nuove; IV, Odi barbare e Rime e ritmi; V, Prose giovanili; VI, Primi saggi; VII, Discorsi letterari e storici; VIII, Studi sulla letteratura italiana dei primi secoli; IX, I trovatori e la cavalleria; X, Dante; XI, Petrarca e Boccaccio; XII, Il Poliziano e l’Umanesimo; XIII, La coltura estense e la gioventù dell’Ariosto; XIV, L’Ariosto e il Tasso; XV, Lirica e storia nei secoli XVII e XVIII; XVI, Studi su Giuseppe Parini: Il Parini minore; XVII, Studi su Giuseppe Parini: Il Parini maggiore; XVIII, Poeti e figure del Risorgimento, s. 1; XIX, Poeti e figure del Risorgimento, s. 2; XX, Leopardi e Manzoni; XXI, Scritti di storia e di erudizione, s. 1; XXII, Scritti di storia e di erudizione, s. 2; XXIII, Bozzetti e scherme; XXIV, Confessioni e battaglie, s. 1; XXV, Confessioni e battaglie, s. 2; XXVI, Ceneri e faville, s. 1; XXVII, Ceneri e faville, s. 2; XXVIII, Ceneri e faville, s. 3; XXIX, Versioni da antichi e da moderni; XXX, Ricordi autobiografici, saggi e frammenti.
Tra il 1938 e il 1968 è stata pubblicata l’edizione nazionale delle Lettere, che in 22 volumi offre l’epistolario, non il carteggio, in testi non sempre sicuri e corredati di note imprecise e insufficienti. Si vedano le correzioni ed aggiunte accolte nell’ultimo volume; e inoltre: M. Valgimigli, Errata corrige all’Epistolario carducciano, in Giorn. stor. della lett. it., LXXVI (1959), pp. 604-633; G. Fatini, A pubblicazione avvenuta dell’Epistol. carducciano, in Nuova Antol., maggio 1960, pp. 75-95; T. Barbieri, Postille alle “Lettere” di G. C., in Giorn. stor. della lett. it., LXXIX(1962), pp. 84-1193 e Postilla alle “Lettere” di G. C., in Studi e problemi di critica testuale, n. 4, aprile 1972, pp. 172-209.
Edizioni originali delle poesie (limitatamente ai volumi: sono quindi qui tralasciati gli opuscoli e i fogli ove videro luce singole poesie, nonché le riviste): Rime di G. C., San Miniato 1857; Levia Gravia di Enotrio Romano, Pistoia 1868; Poesie di G. C. (Decennalia, Levia Gravia. Juvenilia), Firenze 1871; Primavere elleniche, ibid. 1872; Nuove poesie di Enotrio Romano, Imola 1873; Nuove poesie di G. C., 2 ed., Bologna 1875; Poesie di G. C., 3 ed., preceduta da una biografia del poeta, Firenze 1878; Odi barbare, Bologna 1877; Levia Gravia di G. C., ibid. 1881; Giambi ed epodi, ibid. 1882; Nuove Odi barbare, ibid. 1882; ça ira, Roma 1883; Nuove Odi barbare, 2 ed., Bologna, 1886; Rime nuove, ibid. 1887; Terze Odi barbare, ibid. 1889; Delle Odi barbare di G. C., Libri II ordinati e corretti, ibid. 1893; Rime e ritmi, ibid. 1899. Nell’ordinamento definitivo il C. divise tutta la produzione poetica (da cui escluse i versi dell’adolescenza che ora si vedano nel vol. I dell’ed. naz. delle Opere), senza tenere conto della esatta cronologia dei singoli componimenti, in: Juvenilia (6 libri), Levia Gravia (2 libri), A Satana, Giambi ed epodi (2 libri, preceduti da un Prologo;tra il I e il II Ripresa), Intermezzo, Rime nuove (in 9 libri, di cui il VII ça ira), Odi barbare (2 libri), Rime e ritmi, Dalla “Canzone di Legnano” Parte I, Il Parlamento.Dato il continuo spostamento delle singole liriche da una raccolta all’altra e nell’interno di una stessa raccolta da un’edizione all’altra, sono utili le tavole di concordanza che si trovano in appendice al vol. di A. Jeanroy, G. C. l’homme et le poète, Paris 1911, pp. 259-285.
Edizioni originali delle prose e pubblicazioni curate dal C.: L’arpa del popolo, scelta di poesie religiose, morali e patriottiche “accomodate all’intelligenza del popolo“, Firenze 1855; Antologia latina e saggi di studi sopra la lingua e la letteratura latina, ibid. 1855; Poesie liriche di V. Monti, ibid. 1858; Satire e poesie minori di V. Alfieri, ibid. 1858; La Secchia rapita e l’Oceano di A. Tassoni, ibid. 1858; Poesie di G. Parini, ibid. 1858; Del Principe e delle lettere e altre prose di V. Alfieri, ibid. 1859; Poesie di Lorenzo de’ Medici, ibid. 1859; Poesie di G. Giusti, ibid. 1859; Satire, Odi e lettere di Salvator Rosa, ibid. 1860; Poesie di G. Rossetti, ibid. 1861; Canti e poemi di V. Monti, ibid. 1862; Rime di messer Cino da Pistoia e d’altri del sec. XIV, ibid. 1862; Le Stanze, l’Orfeo e le Rime di A. Poliziano, ibid. 1863; T. Lucrezio Caro, Della natura delle cose, libri 6 volgarizzati da A. Marchetti, ibid. 1864; Tragedie, drammi e cantato di V. Monti, ibid. 1865; Rime di Matteo di Dino Frescobaldi, Pistoia 1866; Poeti erotici del sec. XVIII, Firenze 1868; Versioni poetiche di V. Monti, ibid. 1869; Lirici del sec. XVIII, ibid. 1871; Studi letterari, Livorno 1874; Delle poesie latine edite e inedite di L. Ariosto, Bologna 1875; Rime di F. Petrarca sopra argomenti storici, morali e diversi. Saggio di un testo e commento nuovo col raffronto dei migliori testi e di tutti i commenti, Livorno 1876; Lettere di F. D. Guerrazzi, ibid. 1880; La poesia barbara nei secc. XV e XVI, Bologna 1881; Confessioni e battaglie, s. 1, Roma 1882; Confessioni e battaglie, s. 2, ibid. 1883; Lettere disperse e inedite di P. Metastasio, Bologna 1883; Letture italiane, ibid. 1883; Confessioni e battaglie, s. 3, Roma 1884; Conversazioni critiche, ibid. 1884; Scritti letterari e artistici di A. Mario, Bologna 1884; Scelte poesie di V. Monti, Livorno 1885; Il libro delle prefazioni, Città di Castello 1888; Storia del Giorno, Bologna 1892; Sul’Aminta di T. Tasso, Firenze 1896; Letture del Risorgimento italiano, 2 voll., Bologna 1896-1897; Le prime vittime di Francesco IV Duca di Modena Notizie di A. Panizzi, Roma 1897; Degli spiriti e delle forme nella poesia di G. Leopardi, Bologna 1898; Le Rime di F. Petrarca di su gli originali, commentate da G. C. e S. Ferrari, Firenze 1899; Di Lodovico Antonio Muratori, in Raccolta degli storici italiani dal Cinquecento al Millecinquecento ordinata da L. A. Muratori, Città di Castello 1900; Scritti politici di A. Mario, Bologna 1901; Primavera e fiore della lirica italiana, I-II, Firenze 1903; Antica lirica italiana: canzonette, canzoni, sonetti dei secoli XIII e XIV, ibid. 1907.
Delle edizioni commentate ci limitiamo a ricordare quella delle poesie a cura di D. Ferrari, I-IX, Bologna 1919-1931; e quella tutt’ora in corso, di cui sono usciti: Giambi ed Epodi (a cura di E. Palmieri, Bologna 1959), Odi barbare (a cura di M. Valgimigli, Bologna 1959); Rime nuove (a cura di P. P. Trompeo-G. B. Salinari, Bologna 1961); Rime e ritmi (a cura di M. Valgimigli e G. B. Salinari, Bologna 1964). Si tengano presenti pure le antologie, non solo per le introduzioni e i commenti ma anche perché proprio nella scelta esse documentano l’evolversi dell’atteggiamento nei confronti del poeta: G. Mazzoni-G. Picciola, Antologia carducciana, Bologna 1908; Pagine autobiografiche, a cura di G. Lipparini, Bologna 1921; Prose scelte, a cura di L. Bianchi-P. Nediani, Bologna 1935; F. Bernini-L. Bianchi, C., Pascoli e D’Annunzio, Bologna 1935; A. Vicinelli, Le tre corone, Milano 1940; Prose e poesie di G. C., a cura di G. Getto – G. Davico Bonino, Firenze 1965; Poesie e prose scelte, a cura di M. Fubini-R. Ceserani, Firenze 1968 (di cui è importante l’introd., Premessa ad una rilettura di C.); Poesie scelte, a cura di P. Treves, Novara 1968.
Bibl.: G. Chiarini, G. C. Impress. e ricordi, Bologna 1901; Id., Mem. della vita di G. C., Firenze 1903;M. Saponaro, C., Milano 1940;M.Biagini, Il poeta della terza Italia (Vita di G. C.), Milano 1961.Innumerevoli sono gli scritti su aspetti e momenti particolari della vita del poeta; ci limitiamo a segnalarne i più importanti, rimandando per gli altri alle accurate note della biogr. del Biagini e alla ricca bibliografia, che segue le pagine dedicate al C. da G. B. Salinari, in Storia della lett. ital. Garzanti, diretta da E. Cecchi-N. Sapegno, VIII, Milano 1968, pp. 719-729;U. Brilli, A G. C. Grosseto e la Maremma, Grosseto 1907; L. Barboni, Col C. in Maremma, Firenze 1906;G. Fatini, G. C. fra i colerosi di Pian Castagnaio (1855), in Rivista d’Italia, XI (1908), 2, pp. 69-83;O. Bacci, G. C. e gli “Amici Pedanti“, in Rassegna contemporanea, I (1908), 6, pp. 449-477;C. Adami, G. C. maestro di retorica nell’anno scolastico 1856–57, in Ai mani di G. C. gli insegnanti federati delle scuole medie di Alessandria ecc., Alessandria 1908;D. Zanichelli, G. C. nella vita bolognese, in Polit. e storia, Bologna 1903, pp. 409-32;G. Nencioni, Consule Planco, in Impressioni e rimembranze, Firenze 1923, pp. 61-75;D. Manetti, Un dramma in casa C., Bologna 1927;A. Luzio, La massoneria e il Risorg. ital., Bologna 1925, II, pp. 211-228; F. Salata, Processi penali e discipl. contro G. C., Bologna 1924;G. Squarciapino, Roma bizantina, Torino 1950, passim;P. Pancrazi, Un amoroso incontro della fine Ottocento, Firenze 1951; Bologna e la cultura dopo l’unità d’Italia, Bologna 1960, passim.
Princip. studi critici: E. Panzacchi, Teste quadre, Bologna 1881, pp. 116-56;A. Borgognoni, Prefaz.alle Poesie di G. C., Firenze 1878;G. Chiarini, I critici ital. e la metrica delle Odi barbare, Bologna 1878;E. Nencioni, Saggi critici di letter. ital., Firenze 1898;E. Scarfoglio, Illibro di don Chisciotte, Roma 1885, passim;A. Panzini, L’evoluzione di G. C., Milano 1894;G. Mazzoni, G. C., Firenze 1901; F. D’Ovidio, La versificaz. delle Odi barbare, in Misc. Graf, Bergamo 1903, pp. 9-52;B. Croce, G. C., in La Critica, I(1903), 1, pp. 731; G. Rabizzani, Spiriti della poesia carducciana, in Studi e ritratti, Firenze 1909; E. Thovez, Il pastore, il gregge e la zampogna, Napoli 1909, pp. 305-321; B. Croce, Studi sul C., in La Critica, VIII (1910), pp. 1-21, 81-97, 161-85, 321-38; R. Serra, Per un catal., Firenze 1910 (poi in Scritti, Firenze 1938, pp. 71-99); E. Romagnoli, Polemica carducciana, Firenze 1911; T. Parodi, La poesia di G. C. in La cultura, XXX(1911), (poi pubbl. in G. C. e la letter. della nuova Italia, Torino 1939); C. De Lollis, Appunti sulla lingua poeta del C., in Saggi sulla forma poetica ital. dell’Ottocento, Bari 1929, pp. 99-138; G. Maugain, G. C. et la France, Paris 1914; E. G. Parodi, Poeti antichi e moderni, Firenze 1923, ad Ind.;B. Sposato, L’evoluz. poetica di G. C., Firenze 1927; D. Petrini, Poesia e poetica carducciana, Roma 1927; A. Galletti, L’opera di G. C., Bologna 1929; F. Valsecchi, G. C., Bologna 1929; G. Petronio, G. C. L’uomo e il poeta, Messina 1930; G. Citanna, Il romanticismo e la poesia ital. dal Parini al C., Bari 1935, pp. 252-310 (2 ed., Bari 1949, pp. 240-294); G. De Robertis, Nascita della poesia carducciana, in Pan, III(1935), 12, pp. 418-39 (poi in Saggi, Firenze 1953, pp. 95-127); L. Foscolo Benedetto, C. e la Francia, ibid., 9, pp. 25-43 (poi in Uomini e tempi, Milano-Napoli 1953, pp. 421-442); P. Pancrazi, Scrittori ital. dal C. al D’Annunzio, Bari 1937, pp. 5-28; D. Mattalia, L’opera critica di G. C., Genova 1934; Id., C. poeta, Messina 1936; G. A. Peritore, La poesia di G. C., Modena 1937; A. Momigliano, Le prime Odi barbare e C.critico, in Studi di poesia, Bari 1938, pp. 209-222; U. Bosco, Da C. ai “crepuscolari“, in Nuova Antologia, 1º marzo 1938, pp. 21-33; M. Praz, Gusto neoclassico, Firenze 1940, pp. 275-94; A. Gargiulo, Ragioni metriche, in Letter. ital. del Novecento, Firenze 1940, pp. 243-259; P. P. Trompeo, C. e D’Annunzio, Roma 1943; G. Santangelo, C., Palermo 1945; A. Baldini, Fine Ottocento, Firenze 1947, pp. 3-89; U. Bosco, La poesia di G. C., Napoli 1947; A. Omodeo, Lettere del C., in Ilsenso della storia, Torino 1948, pp. 427-443; N. Sapegno, Storia di C., in Società, V(1949), pp. 5-23 (poi in Ritratto di Manzoni e altri saggi, Bari 1962, pp. 232-255); P. Alatri, C. giacobino, Palermo 1953; A.Momigliano, Lett. a Lidia, in Ultimi studi, Firenze 1954, pp. 51-55; L. Russo, C. senza retor., Bari 1957; W. Binni, Linea e momenti della poesia carducciana, in C. e altri saggi, Torino 1960, pp. 11-49 (seguito da altri due saggi: Tre liriche del C., pp.50-73 e C. politico, pp.75-88); M. Vinciguerra, C. uomo politico, Pisa 1957; N. Busetto, G. C., Padova 1958; U. Bosco, Realismo carducciano, in Realismo romantico, Caltanissetta 1959, pp. 147-208; F. Flora, La poesia e la prosa di G. C., Pisa 1959; M. Petrini, Postille al C. barbaro, Messina-Firenze 1963; R. Sirri, Retorica e realtà nella poesia giambica del C., Napoli 1965; S. Timpanaro, G. C. e Chiarini, in Classicismo e illuminismo nell’Ottocento, Pisa 1965, pp. 119-132; P. Treves, C. poeta di tradizione, in G. Carducci, Poesie scelte, Novara 1968; G. A.Papini, Formaz. del C. “barbaro“, in Convivium, XXXVI (1968), pp. 1-79; L. Baldacci, C., in Secondo Ottocento, Bologna 1969, pp. 55-73; P. Vannucci, Saggivari tra carducciani e pascoliani, Firenze 1969, pp. 3-109; E. Caccia, Poesia e ideologia per C., Brescia 1970; E. Circeo, Lettura di C. e di altri scrittori, Messina-Firenze 1971; R. Bruscagli, C.nelle lettere. Il personaggio e il prosatore, Bologna 1972; R. Macchioni Jodi, Baudelaire e C., in Prodromi di narrativa ottocentesca, Messina-Firenze 1973, pp. 227-357; R. Tissoni, Giordani e C., in Atti del Convegno di studi nel II centenario della nascita di Pietro Giordani, Piacenza 1974, pp. 323-351; F. Mattesini, Per una lettura storica di C., Milano 1975; si vedano inoltre i due volumi miscellanei C. Discorsi nel centenario della nascita, Bologna 1938, e C. Discorsi nel cinquantenario della morte, Bologna 1959.(fonte)