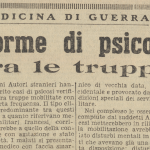Giuseppe ZILIOTTO
D’Annunzio a Zara
Estratto da:
LA RIVISTA DALMATICA
Vol. LIII (N. I), p. 1-6, 1982
ARTI GRAFICHE E. COSSIDENTE & F.LLI – ROMA
Riv. dalmatica (Roma), 53 (n. 1), p. 1-6, 1982.
Giuseppe ZILIOTTO[1]
Pubblichiamo qui il testo integrale del discorso che l’avv.
Ziliotto, nominato Sindaco onorario del Libero Comune di
Zara in Esilio, avrebbe voluto pronunciare l’11 ottobre 1981,
al compimento del suo quinquennale mondato di Sindaco ef-
fettivo, all’Assemblea dei Dalmati convenuti per il loro XXVIII
Raduno Nazionale nella Sala dello Scrutinio del Palazzo Ducale
di Venezia, poiché in tale sede egli fu invitato a limitarlo al-
le sole parti introduttiva e finale, per ragioni di così detta op-
portunità”.
Cari amici zaratini, dalmati, simpatizzanti!
Signore e Signori!
Credo di dover anzitutto rivolgere a titolo personale, ed anche a no-
me di tutti gli intervenuti, un caldo sincero ringraziamento all’amico Tul-
lio Vallery, che con tanta cura e passione ha curato l’organizzazione di
questo nostro XXVIII Raduno Nazionale, dalla Mostra fotografica di
“Zara nell’800” presso la Scuola Dalmata al ritrovo danzante la sera del
sabato, dal Concorso “ZARA” per una poesia nel nostro dialetto, a questa
Assemblea nella solenne cornice della “Sala dello Scrutinio” al Palazzo Du-
cale. Speciale sensibilità egli ha dimostrato scegliendo la Chiesa di Santa
Maria del Giglio, per la cerimonia religiosa in suffragio di tutti i nostri
defunti.
Prima di entrare nella Chiesa ho voluto sostare davanti al bassori-
lievo di Antonio Barbaro che rappresenta la nostra città, e toccarlo, come
faceva — perdonatemi l’ambizioso accostamento — Gabriele d’Annun-
zio, quando vi passava davanti per raggiungere la non lontana Casetta
Rossa (lo racconta il Poeta, nelle prime pagine del “Notturno”).
2
E poiché ho parlato di d’Annunzio e di Zara, consentite che io mi
soffermi a porre nella giusta luce il sentimento che il Poeta Soldato nu-
triva nei confronti della nostra Città. Lo desumo, credo in maniera incon-
futabile, dalle sue stesse parole.
Nel giorno dei Morti del 1915, in quella Aquileia donde era stato
traslatato a Zara il corpo di Grisogono, suo protettore antichissimo, il Poeta
leggeva ai soldati inginocchiati i versetti di un nuovo Salmo. Erano i “Tre
Salmi per i nostri Morti”.
Dopo aver sorvolato tutti i campi di battaglia, dalle Alpi alla foce
dell’Isonzo, negli ultimi versetti del primo dei tre Salmi egli interpreta la
voce della Patria:
« Mia ne l’Alpe la città che Dante copre. Mia sul golfo quella ove
approda, sceso da l’Alpe, il giovinetto sanguinoso, vittima integra e nuovo
pegno certo.
Mie tutte le città del mio linguaggio, tutte le rive delle mie vestigia.
Mando » [notate bene, dice mando] « segni e portenti in mezzo ad esse.
Ma in Zara è la forza del mio cuore; su la Porta Marina sta la mia
fede, ed in Santa Anastasia arde il mio voto. Grida o Porta! Ruggi, o Città,
coi tuoi Leoni! A te darò la stella mattutina.
A te verrò, » [notate, non dice più mando, ma a te verrò] « e di
sotto alla tavola del tuo altare trarrò i tuo stendardi. Li spiegherò nel
vento di levante [. . .] ».
D’Annunzio aveva già sorvolato Trento, Trieste e Pola, ed aveva
lanciato messaggi di incoraggiamento alle città irredente in attesa. Ma
Egli anelava a raggiungere anche Zara; l’impresa, con i mezzi di allora,
era assai più ardua: troppo grande la distanza tra la base di decollo di
Venezia e la città dalmata, enorme il rischio. Il piano tuttavia fu accurata-
mente studiato. Per poterlo porre in atto, d’Annunzio dovette ottenere il
consenso del Comando Supremo e, sembra, del Re stesso. Il volo avrebbe
dovuto essere intrapreso il 23 dicembre 1915. Ma due giorni prima della
data stabilita, il 21 dicembre, in uno degli ultimi voli di addestramento il
suo pilota, tenente Giuseppe Miraglia, cadde e morì. Il volo su Zara non
venne più eseguito.
D’Annunzio aveva però già preparato il “Messaggio” che avrebbe vo-
luto lanciare su Zara. L’amico Oddone Talpo mi disse di aver avuto la
ventura di vedere l’originale del Messaggio, conservato dalla duchessa
Imperiali, figlia del Grande Ammiraglio Thaon de Revel, alla quale era
stato donato dallo stesso d’Annunzio.
3
Di tutti i Messaggi destinati alle città irredente, questo diretto a Za-
ra era indubbiamente di gran lunga il più bello, il più alato, il più sentito.
Purtroppo esso non è conosciuto quanto meriterebbe: tutti gli zaratini
e coloro che ci sono sentimentalmente vicini, in particolare le nostre gio-
vani generazioni, dovrebbero sempre averlo nella mente e nel cuore; esso
è un inno senza pari alla nostra disperata attesa.
Il testo è troppo lungo ed io, per la mia menomazione fisica, non
sono più in grado di leggerne anche solo qualche frase: citerò a memoria,
senza attenermi strettamente alla loro collocazione nel testo, quelle pa-
role e quelle frasi che più profondamente sono rimaste scolpite dentro il
mio cuore:
« Zara, Zara la santa — così comincia il Messaggio — Zara l’in-
vitta, questo è un messaggio d’Italia avvolto nel tricolore.
Eccoti la buona novella che aspetti, eccoti la parola invocata dalla
tua passione.
E’ la prima volta che su te volano ali italiane; ali armate in guerra,
ali della nostra guerra [. . .]
Noi veniamo da Venezia. Siamo partiti su l’alba da quella Venezia
cui tu assomigli. [. . .]
O Zara, che sei tuttora quale fosti per Antonio Barbaro scolpita nel
bassorilievo di Santa Maria del Giglio, simile a un’ala con la sua giuntu-
ra forte, simile a una lunga ala di guerra come la nostra, ben costrutta,
a un’ala d’Italia sul mare, o Zara di Nicolò T rigari, Zara di Luigi Ziliotto,
rocca di fede [. . .]
Chi più di te fu coraggiosa e costante, fidente e disperata, nella lot-
ta d’ogni giorno? Noi lo sappiamo, noi ce ne ricordiamo. Il popolo di Za-
ra, solo contro tutti, negletto dalla madre e senza lamento contro la Ma-
dre, ha salvato il comune italiano, ha preservato la figura della nostra più
antica dignità. [. . .]
Non v’è per te lode assai alta, non v’è corona assai chiara per te,
per il premio dei tuoi fatti. Queste parole che ti gettiamo dovrebbero es-
sere un canto, perché solo il canto è degno di avvicinarsi alla tua virtù e
al tuo martirio. [. .] »
A chi scetticamente volesse insinuare che si tratta di retorica, rispon-
derei che questo è sentimento, è pura poesia.
Consentitemi qualche ricordo personale.
Nel 1919, dopo oltre due mesi di peregrinazioni dalle Alpi alla Sici-
lia, trascorsi visitando le principali sedi universitarie della Penisola per
4
raccogliere negli ambienti studenteschi consensi ed adesioni alle nostre
rivendicazioni adriatiche, un gruppo di studenti dalmati arrivò verso la
metà di marzo a Venezia, accolto alla stazione dal Sindaco, conte
Grimani in persona, e ricevuto, un paio di giorni dopo, dal Patriarca,
Cardinale La Fontaine, a quel tempo ancora Primate della Dalmazia.
Ma l’aspirazione principale degli studenti dalmati era quella di es-
sere ricevuti da Gabriele d’Annunzio, il Poeta Soldato, al quale intendevano
donare l’azzurro gonfalone con le tre teste di leopardo e con la scritta
«ITALIA O MORTE» che li aveva accompagnati nella loro patriottica pere-
grinazione.
L’incontro venne concesso senza difficoltà: ci fu però caldamente
raccomandato di non trattenerci troppo a lungo, per non affaticare il Co-
mandante. Fummo accolti con straordinaria cordialità, e il dono del no-
stro Gonfalone fu particolarmente gradito. Il Poeta ci colmò di ricordi:
fotografie e pubblicazioni con dedica autografa. A ognuno di noi donò un
fazzolettino di seta tricolore, che firmò aggiungendovi il motto «Alalà! »;
uguali a quello che aveva con sé durante il suo volo su Vienna. Questo di
Vienna lo volle donare a Enrico de Serragli di Ragusa, « il solo — disse il
Poeta — che lotta senza speranza ».
Ad ogni nostro cenno di voler prendere commiato, Egli ci tratteneva
ponendoci sempre nuove domande sui nostri problemi adriatici. Nel con-
gedarci, infine, Lo pregammo di venire a Zara: « Verrò, ve lo prometto »,
ci assicurò.
E tenne fede alla promessa: venne a Zara, da Fiume, con un batta-
glione di legionari fiumani, il 14 novembre di quello stesso anno 1919.
Quando ci recammo con una delegazione di cittadini di Zara, guidati dal
Sindaco, a restituirgli la visita un paio di giorni dopo, notai, su una parete
dello studio del Comandante, il Gonfalone da noi donato. Al mio evidente
compiacimento, il Poeta osservò: « E’ sempre davanti ai miei occhi, come
dentro il mio cuore ». Mi donò in quella occasione una sua recente pub-
blicazione e la firmò « un dalmatico che ha mantenuto la promessa ».
Una breve parentesi: un biografo di d’Annunzio annovera tra le sue
debolezze quella di non mantenere le promesse e l’abitudine, quando aveva
visite, di assentarsi per non ricomparire più. Con noi studenti dalmati, fu
Egli a trattenerci, restando con noi fino all’ultimo, e volle sottolineare, con
quella dedica, la promessa adempiuta.
Taluno potrebbe obiettare che, per Fiume, d’Annunzio aveva posto in
secondo piano Zara e la Dalmazia. Non è assolutamente vero. Nel settem-
5
bre del 1919, nonostante la già manifesta opposizione del Presidente ame-
ricano Wilson, Zara e la Dalmazia del Patto di Londra erano in saldo pos-
sesso dell’Esercito Italiano, che le deteneva in forza alle clausole dell’ar-
mistizio di Villa Giusti, mentre la situazione di Fiume, occupata dalle truppe
alleate, e quindi anche da americani, inglesi e francesi, oltre che dagli
italiani, stava diventando — in particolare, per la oltracotanza dei fran-
cesi — ogni giorno più grave e delicata. I patrioti fiumani si rivolsero al-
lora a d’Annunzio, pregandolo d’intervenire a tutela della città.
Che d’Annunzio non avesse dimenticato Zara e la Dalmazia, lo si de-
sume in modo incontestabile dalla lettera “Ai fratelli di Dalmazia”, datata
21 settembre 1919, cioè soli nove giorni dopo la marcia su Fiume (*).
« Fin dalla notte stellata di Ronchi — scriveva in questa lettera il Co-
mandante — fin dall’ora della dipartita, una malinconia sempre più amara
si andava addensando in fondo alla mia risolutezza; una spina sempre più
acuta mi penetrava nel cuore fedele. Era il pensiero di voi, il rammarico di
non avere forze bastevoli a propagare l’incendio in quel medesimo giorno
fino a Spalato nostra, e più oltre ancora, fino alle Bocche di Cattaro, fino a
quell’antica Perasto, che custodisce la speranza e il gonfalone. La passione
di Dalmazia non travagliò mai così addentro il mio petto come durante la
marcia verso Fiume. Che dirà, che farà la mia Zara quando le giungerà l’
annuncio? Che diranno, che faranno Sebenico, T raù, Spalato e le sorelle?».
D’Annunzio non ha mai scordato, anche nei momenti più duri, Zara
e la Dalmazia; sempre ben addentro al suo cuore.
Vi prego di perdonarmi se vi ho intrattenuto così a lungo per riferirvi
il pensiero di d’Annunzio nei riguardi di Zara e della Dalmazia. Io credo
che nessuno meglio di Lui, nelle parole del suo “Messaggio a Zara”, abbia
saputo interpretare ed esprimere quali erano i nostri più segreti sentimenti
e la nostra aspirazione verso la Patria.
Io, personalmente, non posso dimenticare, pur essendo trascorsi da
allora più di sessant’anni, le parole che mio Padre pronunciò nel suo discor-
so al Senato del Regno contro la ratifica del Trattato di Rapallo, suscitando
le proteste del Ministro degli Esteri, Sforza, e di quello della Marina, Sechi.
Disse in quell’occasione Luigi Ziliotto: « Il fenomeno d’Annunzio è
uno di quei fenomeni meravigliosi che si presentano forse una volta sola
…………………………………………
(*) L’autografo originale della lettera è attualmente conservato da Silvano
Drago, che lo salvò dalla distruzione di Zara.
6
nella storia: che io sappia, niente di simile c’è stato giammai. Di poeti che
siano stati la coscienza più profonda della loro nazione, pochi certamente,
ma ce ne furono; e la nostra nazione non ha, in questo riguardo, da invi-
diare alcun’altra. Di poeti soldati anche ce ne furono. Ma di un Vate nel
più bello e vasto senso della parola, che sia stato un soldato eroico come al-
tri mai e che senta anche in sé l’uomo di Stato, chiamato a forgiare i destini
della sua Patria, io credo che questo sia l’unico esempio. [. . .] Io non mi
credo proclive al misticismo, eppure mi pare che Gabriele d’Annunzio veda
tanto addentro nell’animo nazionale che se tutti noi 40 milioni di italiani
dovessimo concordi dire quale sia il pensiero e la volontà della nazione ed
egli solo fosse d’avviso contrario, non noi, tutti uniti, ma egli solo interpre-
terebbe l’animo nazionale ».
Concetto forse ardito, ma bellissimo.
Nella diàspora che ci ha privati della nostra città e ci ha dispersi in
ogni parte d’Italia e del mondo, a noi non resta ormai che la consolazione
delle nostre memorie e la coscienza e la soddisfazione di non esser mai
venuti meno nel nostro amore verso la terra natale.
Conservare le memorie, conservare le tradizioni del nostro dialetto,
conservare il ricordo della nostra disperata passione: conservarli e traman-
darli — assieme a una lontana segreta speranza — ai nostri figli ed alle fu-
ture generazioni; queste le ragioni per cui è sorto e vive il nostro Libero Co-
mune di Zara in Esilio, in una inesausta coscienza di propositi e di intenti, c
ome l’aveva voluto il suo ideatore, l’indimenticabile amico Guido Calbiani;
come, malgrado la nostra pochezza, ci lusinghiamo di aver saputo con-
tinuarlo noi, e come, ne siamo certi, farà con tutto l’entusiasmo sempre ed
in ogni occasione dimostrato, colui che ieri il Consiglio del nostro Libero
Comune ha designato per succedermi in questo incarico, l’amico Dottor
Nerino Rismondo, il nostro impareggiabile “Rime”.
Nell’adunanza di ieri, il Consiglio Comunale ha approvato una mo-
difica al nostro Statuto, con la quale viene istituita la carica di Sindaco
onorario a vita, e questa è stata attribuita a me.
Ne sono profondamente lusingato e commosso: l’altissimo onore che
mi vien reso, io non posso considerarlo diretto soltanto alla mia persona,
perché sinceramente credo di non aver fatto nulla di eccezionale, anzi di
aver fatto assai meno di quanto avrei desiderato per il nostro Comune; ma
lo accetto di buon grado perché sento che esso è diretto anzitutto al nome
che porto, e vuole perciò essere un onore reso alla memoria e all’opera di
mio Padre, il Podestà di Zara nella nostra disperata attesa, il Sindaco del-
la nostra Redenzione!
[1]avv. Giuseppe ZILIOTTO, Presidente dell’Associazione nazionale per la Venezia Giulia e Dalmazia, con i membri del Consiglio nazionale residenti a Roma.(fonte)
[2]Gabriele D’Annunzio.Scrittore (Pescara 1863 – Gardone Riviera 1938). Fu uno dei maggiori esponenti del decadentismo europeo. Dotato di una cultura molto vasta, mostrò un’inesauribile capacità di assimilare le nuove tendenze letterarie e filosofiche, rielaborandole con una raffinata tecnica di scrittura.
Vita
Era ancora convittore presso il collegio Cicognini di Prato quando esordì con Primo vere (1879), una raccolta di poesie pubblicata a spese del padre (Francesco Paolo Rapagnetta, che, adottato nel 1851 da una zia materna e dal marito di questa, Antonio D’A., ne aveva assunto il cognome, trasmettendolo poi ai figli), e positivamente recensita da G. Chiarini. Trasferitosi a Roma nel 1881 per gli studî universitarî, che non avrebbe mai condotto a termine, fu accolto con simpatia negli ambienti giornalistici e letterarî e cominciò a collaborare alla Cronaca bizantina, la rivista di A. Sommaruga, restando affascinato dai metodi modernamente spregiudicati dell’editore, cui affidò la stampa (1882) di Canto novo e delle novelle di Terra vergine. Nel successivo periodo di dissipatezze (“La giovinezza mia barbara e forte In braccio de le femmine si uccide”), celebrato dall’audace Intermezzo di rime (1883), si unì in matrimonio con la duchessina Maria Hardouin di Gallese (dal matrimonio nasceranno i figli Mario, Gabriellino e Veniero), trovò un impiego stabile come redattore della Tribuna, firmando con varî pseudonimi cronache mondane e culturali, e pubblicò le raccolte di novelle Il libro delle vergini (1884) e San Pantaleone (1886; insieme con altre, una scelta di novelle da questi due libri sarà ripubblicata in Novelle della Pescara, 1902). All’esperienza della più elegante società romana e al nuovo grande amore per Elvira (o Barbara, come preferì chiamarla) Fraternali Leoni, si ispirò il romanzo Il piacere, composto negli ultimi mesi del 1888 e pubblicato l’anno successivo dall’editore Treves di Milano. Dopo la parentesi fastidiosa del servizio militare (1889-90), le ristrettezze economiche lo indussero a spostarsi a Napoli (1891), dove intrecciò una nuova relazione con la nobildonna siciliana Maria Gravina Cruyllas, dalla quale nacquero i figli Renata e Gabriele Dante. A Napoli collaborò tra l’altro al Mattino, si interessò alle opere di Nietzsche e Wagner, e pubblicò a puntate (1891-92) il romanzo L’innocente, apparso poi in volume presso l’editore Bideri (1892) e subito tradotto in Francia; insieme con il racconto lungo Giovanni Episcopo, di poco precedente (1891; in vol. 1892), esso risente l’influsso della narrativa russa. L’influenza della lettura di Nietzsche si fa invece sentire in modo determinante già nel Trionfo della morte (1894), e all’insegna del superomismo si svolgerà la successiva produzione dannunziana, a partire da Le vergini delle rocce (1896). Nel 1895 D’A. partecipò a una crociera in Grecia, che avrebbe poi trasfigurato nel primo libro delle Laudi. Intanto le suggestioni della crociera rivissero in un dramma, La città morta (1896; pubbl. 1898), grazie anche all’incoraggiamento a scrivere per il teatro che a D’A. veniva da Eleonora Duse, la più grande attrice del tempo, con la quale aveva ormai intrecciato una relazione (e per la quale avrebbe scritto poi Sogno d’un mattino di primavera, 1897, La Gioconda, 1899, e La gloria, 1899). Nel 1897 fu eletto deputato nel collegio di Ortona a Mare, ma, sia per la scarsa partecipazione ai lavori parlamentari sia per il clamoroso passaggio dai banchi della destra a quelli dell’estrema sinistra (“vado verso la Vita”), uscì sconfitto dalle successive consultazioni elettorali. La sua preoccupazione dominante, anche per le solite difficoltà economiche ora accentuate dal principesco tenore di vita nella villa detta la “Capponcina” presso Settignano, era piuttosto la produzione letteraria. Furono così composti, in un breve giro di anni, quelli che vengono considerati comunemente i capolavori dannunziani: il romanzo Il fuoco (1900); la tragedia Francesca da Rimini (1902); i primi tre libri delle Laudi: Maia (1903), Elettra e Alcyone (1904); la tragedia pastorale La figlia di Iorio (1904). Nonostante qualche clamoroso insuccesso e la fine della relazione con la Duse, prevalentemente teatrali furono gli interessi del periodo successivo (La fiaccola sotto il moggio, 1905; Più che l’amore, 1907; La nave, 1908; Fedra, 1909), che pure culminò nell’ultimo grande romanzo dannunziano, ispirato a una drammatica vicenda amorosa, Forse che sì forse che no (1910). Nel 1910, per sfuggire ai creditori, D’A. fu costretto all'”esilio” in Francia, dove rinverdì un prestigio che risaliva agli anni Novanta e alle traduzioni dell’Innocente e del Piacere, scrivendo in francese antico Le martyre de saint Sébastien (1911), che fu musicato da C. Debussy e interpretato dalla danzatrice I. Rubinstein, e La Pisanelle ou La mort parfumée (1913). In traduzione francese, col titolo Le chèvrefeuille, veniva rappresentata nel 1913 la tragedia Il ferro, da lui composta in italiano come la precedente Parisina del 1912. In questi anni lavorò anche per il cinema, contribuendo non poco, con le sue sonanti didascalie, al successo del film Cabiria (1914) di Piero Fosco (G. Pastrone). Nel 1915, invitato a Quarto per inaugurare il monumento ai Mille, rientrò in Italia e avviò una personale, infiammatissima campagna interventista, in aperta polemica con gli atteggiamenti del governo. Dopo la dichiarazione di guerra, si arruolò come volontario e si distinse in una serie di imprese militari, come la Beffa di Buccari o il volo su Vienna, pur essendo rimasto gravemente ferito in un incidente aviatorio in seguito al quale perse un occhio. Nella totale cecità postoperatoria, aveva scritto (1916) il Notturno su sottili strisce di carta che la figlia Renata provvedeva a decifrare e ricopiare. Eroe pluridecorato e figura ormai leggendaria presso i reduci, si fece interprete, dopo la fine della guerra, della loro indignazione per la “vittoria mutilata” e guidò la “marcia di Ronchi” e l’occupazione di Fiume, che tenne, in qualità di “Reggente”, dal settembre 1919 al dicembre 1920, quando fu costretto militarmente a rinunciare alla sua impresa (a testimonianza degli ambiziosi programmi politici e sociali del D’A. fiumano resta la Carta del Carnaro a sfondo corporativista, che, redatta da A. De Ambris, ebbe da D’A. la forma letteraria definitiva). Ritiratosi nella villa Cargnacco, in quello che poi chiamerà il “Vittoriale degli Italiani”, sul Lago di Garda, fu colto alla sprovvista dal colpo di mano di Mussolini, che aveva appoggiato l’impresa fiumana e a essa probabilmente si era ispirato. Con il dittatore fascista intrattenne un rapporto difficile, apparentemente amichevole e di reciproca ammirazione, ma in realtà minato dal sospetto, vedendosi quindi confinato nella dorata prigione del Vittoriale e dissuaso da qualsiasi interferenza politica, in cambio del massimo riguardo formale e di non poche concessioni (nel 1924 fu creato principe di Montenevoso; poté sovrintendere all’edizione nazionale delle sue opere; nel 1937 divenne presidente dell’Accademia d’Italia).
Opere
Tra i molti generi letterarî da lui tentati, D’A. predilesse la poesia lirica: essa anzi fu l’asse intorno al quale tutte le altre forme espressive ruotarono e si organizzarono, allo stesso modo in cui intorno alla letteratura ruotarono i varî aspetti della sua personalità poliedrica. Poetici sono del resto i suoi esordî, con due raccolte addirittura passate in proverbio: Primo vere (1879), per la straordinaria precocità, e Canto novo (1882), per l’invenzione di una inconfondibile cifra personale, pur a ridosso e quasi come approfondimento delle originarie suggestioni carducciane. Del classicismo carducciano, e in particolare delle Odi barbare, rimane virtualmente tributaria una poesia d’ora in poi sempre giocata sulla consapevolezza della propria inafferrabilità di Ideale e sulla conseguente inevitabilità dell’artificio: tutta barbara, congetturale e artificiosa, come congetturale e artificioso era stato il tentativo delle Odi carducciane di riprodurre i metri classici nella versificazione italiana. La stessa scoperta sensuale della natura, che rappresenta la novità più caratteristica di Canto novo e accompagnerà D’A. in tutti gli esperimenti successivi, coincide con un artificio, sullo sfondo di un primordio fantastico giustificando una barbarica irruzione nel mondo ignoto della poesia e conciliando il massimo dell’attualità e della concretezza con l’atemporalità del mito classicistico. Mentre il narratore di Terra vergine (1882) approfitta con acume della lezione verghiana, e soprattutto fornisce di un retroterra aneddotico la sfrenata sensualità del Canto novo, con Intermezzo di rime (1883) D’A. apre il gioco che da cronista mondano avrebbe condotto a perfezione nel quinquennio successivo: una scherzosa divinizzazione del bel mondo romano e di un rituale trasparentemente erotico, cui la poesia fosse in grado di restituire serietà, se non esplicitezza, ricavandone dal canto suo la conferma di una funzione sociale e del relativo consenso. È però da romanziere, con Il piacere (1889), che gli riesce di emanciparsi dalle frigide eleganze e dal valore puramente ludico già presentiti e ben esemplati da Isaotta Guttadàuro e altre poesie (1886). Nel romanzo, la “lotta d’una mostruosa Chimera estetico-afrodisiaca col palpitante fantasma della Vita nell’anima d’un uomo” mette finalmente di fronte una fedeltà all’Ideale deprecabile come un vizio immondo, per la disumanità che comporta, e un buon senso tanto immediatamente redditizio e socialmente rispettabile quanto assolutamente sprovvisto di qualsiasi attrattiva letteraria e intellettuale. Lo scrittore ribadisce così l’irrinunciabilità dell’Ideale nell’amore e nell’arte e al romanzo assegna il compito di creare artificialmente nel lettore la disposizione ad assecondare il suo sogno. A questa nuova disposizione del lettore si rivolge la più affabile poesia delle Elegie romane (1892) e soprattutto del Poema paradisiaco (1893), opera in cui, smessi i travestimenti delle raccolte precedenti per agitare l’altrettanto speciosa parola d’ordine della stanchezza dei sensi e della bontà, D’A. riscatta virtuosisticamente il linguaggio più dimesso del suo repertorio, puntando sulla tensione psicologica dei duetti sentimentali e sulla moltiplicazione delle pause che alonano di sottintesi e potenziano anche le parole più banali. Un altro romanzo, L’innocente (1892), proprio a partire da un equivoco umanitarismo esemplato su Dostoevskij e Tolstoj, aveva del resto chiarito che anche il mito della bontà e della semplicità era nutrito di intellettualismo e si fondava su un idealismo consequenziario in maniera spietata. La conversione al superomismo nietzschiano, per quanto effettivamente incoraggiata da affinità psicologiche e culturali indipendenti dalle letture napoletane di D’A., risulta tuttavia decisiva, sia per l’acuirsi degli interessi teorici di uno scrittore che infatti per un intero decennio mostra di prediligere la forma romanzo, e un romanzo per giunta “idealista”, sia per la più risentita percezione della dimensione sociale dell’attività artistica. Si passa quindi dal Trionfo della morte (1894), in cui il già collaudato tema misogino della Nemica coinvolge nella sua ispirazione distruttiva miti e istituzioni inconciliabili con la purezza dell’Arte, a Le vergini delle rocce (1896), il romanzo “di una Bellezza misteriosa e quasi terribile” che racconta, in una maniera provocatoriamente antiromanzesca, il sogno di una folle palingenesi reazionaria contro la “diminuzione” e la “violazione” da cui sono minacciati tutti i valori in una moderna società democratica. E si approda infine a Il fuoco (1900), che mette in scena l’esperimento di una sorta di regia dell’albeggiante vita spirituale delle masse, non più temute e respinte ma incoraggiate e guidate nelle loro oscure aspirazioni verso la Bellezza. Alle teorizzazioni romanzesche, corrispondono i concreti tentativi di un’arte sia pure solo velleitariamente popolare, compiuti attraverso il teatro. Miti, secondo la ricetta classica dell’arte per il popolo, e insieme dimostrazioni della immutata efficacia dei miti antichi sono le tragedie dannunziane, da La città morta (1898) a La figlia di Iorio (1904) a Più che l’amore (1906), a Fedra (1909), in cui la solita lotta per l’Ideale, spinta talora fino al crimine, rappresenta iperbolicamente una comune insofferenza nei confronti del grigiore della vita quotidiana e la parola poetica sperimenta la propria efficacia fuori del libro. La stagione dei capolavori dannunziani culmina però nei due più celebrati libri delle Laudi del cielo del mare della terra e degli eroi, quando l’urgenza del comprendere lascia il posto alla liberatoria conquista di una poesia nella quale felicemente collaborino istinto e artificio. Gli oltre ottomila versi di Maia (1903) sono virtuosisticamente giocati sul mantenimento della stessa tensione espressiva e esplicitamente votati addirittura all’emulazione del poema dantesco, ponendosi altresì a modello delle innovazioni metriche novecentesche e lasciando intravedere una nuova strada per la poesia civile. Alcyone (1904), di là dalla tenue trama di una vacanza estiva a contatto con la natura toscana, trova un motivo unitario nel suo porsi come “tregua” e nella conseguente scelta di argomenti privati e sentimentali, e punta sulla suggestione d’una lingua manipolata senza sforzo evidente e sulla sconcertante prossimità al linguaggio prosastico, sempre imminente e ogni volta mirabilmente eluso (ad esiti altrettanto significativi non giungono il secondo e il quarto libro delle Laudi: Elettra, 1904; Merope, 1912; né Canti della guerra latina, 1933, noto anche come Asterope). La fase del ripiegamento memoriale si apre all’indomani della splendida fioritura primonovecentesca, all’insegna di un autobiografismo meno strumentale e idealizzato. Se così Forse che sì forse che no (1910) traduce, concretamente svilendolo, l’Ideale dei romanzi precedenti nella passione aviatoria e, quasi come postuma compensazione, rappresenta il dramma della femminilità offesa, tutte le prose di memoria e quella che è stata definita “esplorazione d’ombra”, comprese tra l’atteggiamento solennemente meditativo della Contemplazione della morte (1912) e la scrittura apparentemente pedantesca e in realtà comica del Secondo amante di Lucrezia Buti (nel vol. Il venturiero senza ventura e altri studii del vivere inimitabile, 1924, primo dei due tomi che, con Il compagno dagli occhi senza cigli e altri studii ecc., 1928, compongono Le faville del maglio), rivelano addirittura uno scrittore nuovo. Con il Notturno (pubbl. nel 1921), il mutamento dello scenario psicologico e la singolare tecnica compositiva si risolvono nella ricerca di una lirica essenzialità all’interno della prosa, che nella paratassi inevitabile di un eterno presente vive l’ultima stagione di una sensibilità sovrumana, e, con le Cento e cento e cento e cento pagine del libro segreto di Gabriele D’A. tentato di morire (1935), lo scrittore a quella tecnica fa corrispondere la naturalezza quasi meccanica con cui si concede alla registrazione, al ricordo, all’intuizione più penetrante, senza ricavarne più nessuna scintilla di vitalità.
Le opere di D’A. furono da lui stesso riordinate in 48 voll., per l’ed. nazionale (1927-36), cui si aggiunse un vol. di Indici, a cura di A. Sodini (1936). Postumi sono stati pubblicati: Solus ad solam, un diario d’amore, a cura di J. De Blasi (1939); una scelta di sue Lettere a Barbara Leoni, a cura di B. Borletti (1954); i Taccuini, a cura di E. Bianchetti e R. Forcella (1965), seguiti da Altri taccuini, a cura di E. Bianchetti (1976) e da Di me a me stesso, a cura di A. Andreoli (1990); il Carteggio D’A.-Mussolini (1919-1938), a cura di R. De Felice e E. Mariano (1971); alcuni testi inediti, che dovevano far parte della raccolta La penultima ventura (2 voll., 1931), dedicata al periodo fiumano, in La penultima ventura, a cura di R. De Felice (1974), il Carteggio D’A. – Ojetti (1894-1936), a cura di C. Ceccuti (1979).(fonte)
[3] Zara (croato Zadar) Città della Croazia (69.556 ab. nel 2001), nella Dalmazia settentrionale, sulla costa del canale omonimo. Il centro è raccolto su una stretta e lunga penisola parallela alla costa, ridotta a isola con lo scavo di un canale al principio del Seicento, e più tardi unita di nuovo alla terraferma. Il sobborgo di Cerarìa, situato sulla sponda nord-orientale del porto, è collegato alla città con un ponte, che limita praticamente il porto, la cui estrema parte interna forma la Valle de’ Ghisi. La città, frequentata località turistica, conserva alcune delle fiorenti industrie del passato (maraschino, pesce inscatolato) e possiede moderni stabilimenti tessili, meccanici e cantieristici. È capoluogo della contea omonima (3646 km2 con 174.595 ab. nel 2008).
Antico centro dei Liburni, la città fu eretta in colonia dai Romani, che la chiamarono Iader. Sotto l’Impero godette di grande prosperità, soprattutto per il commercio del vino e dell’olio. Passata sotto l’Impero d’Oriente (540), nel 7° sec. divenne il centro principale della Dalmazia bizantina. Caduta Ravenna (751), ne ereditò le funzioni di più importante città dell’Adriatico. All’inizio del 9° sec. era capitale del ducato autonomo di Dalmazia e anche quando la sovranità imperiale vi fu ristabilita conservò una posizione preminente. Premuta dagli Slavi, riconobbe al doge Pietro II Orseolo (verso il 1000) il titolo e l’ufficio di duca di Dalmazia, ma cacciati gli Orseolo dal dogado, si sottrasse alla dipendenza da Venezia. Nella seconda metà dell’11° sec. entrò nella giurisdizione ecclesiastica romana e si pose, alternativamente, sotto la protezione di Venezia e di Bisanzio, finché nel 1202 Enrico Dandolo non vi stabilì il dominio della Serenissima. Nel 1358 Z. riprese le funzioni di capitale della Dalmazia, come libero comune e fiorente centro commerciale, ma nel 1409 Venezia ottenne da Ladislao la cessione della Dalmazia, e Z. tornò sotto la signoria di Venezia, che sarebbe durata fino al 1797, quando fu occupata dalle truppe austriache. Nel 1805, per la pace di Presburgo passò con la Dalmazia a Napoleone, entrando poi a far parte del Regno Italico e dal 1809 delle Province Illiriche. L’8 dicembre 1813, dopo un lungo assedio, Z. fu nuovamente occupata dagli Austriaci. Per tutto il 19° sec., e particolarmente nel 1848 e nel 1861, la popolazione di Z. diede prova di sentimenti italiani. Nel novembre 1868 fu dichiarata città libera. Insorta il 29 ottobre 1918, la città fu occupata il 4 novembre da forze italiane. Assegnata all’Italia dal trattato di Rapallo (1920), il 5 gennaio 1921 vi fu proclamata l’annessione all’Italia. Nel corso della Seconda guerra mondiale, Z., eretta nel 1941 (dopo l’accordo tra Italia e Croazia del 18 maggio 1941) a capoluogo della Dalmazia, subì durissimi bombardamenti. Dal settembre 1943 la popolazione italiana cominciò ad abbandonare la città, rifugiandosi a Trieste e di là in altre parti d’Italia. Per il trattato di pace del 10 febbraio 1947 Z. entrò a far parte della Federazione iugoslava nell’ambito della Repubblica di Croazia.
Notevoli i resti della città romana, fra cui il foro lastricato con resti di portici e di edifici pubblici. Il complesso monumentale medievale di Z. è costituito dalla chiesa di S. Donato, forse del 9° sec., su fondazioni di epoca romana (a pianta circolare, con due piani di navate anulari, tre grandi absidi e cupola), e dal duomo, dedicato a S. Anastasia, (12°-13° sec.), su un precedente edificio del 9° sec. (interno a tre navate divise da pilastri con colonne binate e matronei esagoni divisi da lesene, cripta del 9° sec.; all’interno opere del 13°, 14° e 15° sec.). Tra gli altri monumenti: chiesa del monastero di S. Maria (facciata di tipo veneziano, del 15° sec., e campanile romanico; sala capitolare del 12° sec.); S. Simeone; S. Francesco (1282, rimaneggiata); S. Crisogono (12° sec., con notevoli affreschi). Di tipo veneto sono anche gli edifici civili: Palazzo del Capitan Grando (15° sec.); Loggia civica (G.G. Sanmicheli); Porta Terraferma (M. Sanmicheli), e numerose case d’abitazione. Tra i musei, notevoli il Museo archeologico e il Museo dell’arte sacra.(fonte)